Blog di Krugman
Un manuale della crisi finanziaria, parte prima. Come le cose possono andare storte in modo catastrofico. Di Paul Krugman (dal blog di Krugman, 13 aprile 2025)
Apr. 13, 2025
A Financial Crisis Primer, Part I. How things can go catastrophically wrong
Paul Krugman

Last week was a scary time in U.S. financial markets, and the danger may not be over.
I’m not talking about stocks, whose fluctuations often tell us nothing at all. What had me and others rattled were developments in bond and currency markets. Interest rates on long-term government debt rose sharply even as the perceived risk of a recession, which normally pushes rates down, rose. And the dollar went down against other currencies even though interest rates went up.
These moves weren’t normal for an advanced country like the United States. However, the combination of rising interest rates and a falling currency as the economy slumps is something often seen in emerging markets facing a financial crisis. The chart at the top of this post shows an example: Indonesia from 1997 to 1999. Obviously we haven’t seen anything that severe for the United States. But suddenly I and many others are wondering whether we’re looking at the early stages of a U.S. financial crisis.
So this seems like a good time to post a primer on the economics of financial crises. However, this is a big topic, so I’ll do it in two parts. This week I’ll discuss the logic of financial crises. Next week I’ll discuss policy responses and recent developments in the United States — although God knows where we’ll be by then.
This time isn’t different
Back in 2009 Carmen Reinhart and Ken Rogoff published a terrific book on financial crises with the sarcastic title “This Time Is Different.” The gallows-humor joke was that whenever people brush off the risks of crisis by saying that the lessons of history don’t apply to the current situation, history bites them in the um, assets.
The truth is that financial crises keep happening. And when one happens, it’s always clear in retrospect that the crisis arose from one of two sources: a liquidity crunch or balance sheet problems.
In a liquidity crisis, which may include but isn’t limited to bank runs, banks or other institutions have obligations that they can’t meet on short notice, because they can’t sell their assets except at extreme fire-sale prices. And fear that these obligations won’t be honored leads causes investors to rush for the exits, deepening the crisis. In a balance sheet crisis, falling asset prices force investors or in some cases debtors to retrench and/or engage in fire sales, driving prices down even more. In both cases there is a self-reinforcing downward spiral. This can cause contagion, spreading through the economy, if public policy doesn’t contain the damage.
Thus the financial freeze that followed the fall of Lehman Brothers in 2008 was fundamentally similar to the banking crisis of 1930-31. And the wave of bank failures in the early 1930s, not the 1929 stock market crash, was what made the Great Depression such a disaster.
As I’ll explain next week, the incipient bond market crisis that scared Donald Trump into fake-pausing his Rose Garden tariff regime appears to have been, in essence, a balance sheet crisis that was qualitatively, though not quantitatively, similar to the crises that wracked the world economy in the late 1990s.
If financial crises always follow two standard scripts, why do they often come as a surprise even to alert observers? The answer is that while the underlying mechanics are the same, the superficial details can look very different. While the 2008 crisis was basically a banking crisis, in large part a kind of bank run, it was centered on institutions that didn’t look like — and, crucially, weren’t regulated like — conventional banks. Similarly, the balance sheet crisis that caused bond prices to plunge, and yields to soar, after Trump’s Rose Garden tariff announcement involved novel channels, notably the role of hedge funds in the “basis trade” (as I’ll explain next week.)
So it’s hard to anticipate financial crises. Sometimes you only find out about the skeletons in the closet when the house falls down. But when crisis strikes, policymakers have to respond quickly and well, or the crisis can inflict severe economic damage.
What constitutes a financial crisis?
Financial crises have been happening since the birth of financial markets. Adam Smith’s The Wealth of Nations, published in 1776, is famous for its advocacy of free markets. But Smith also called for bank regulation, which he compared to requiring fire walls between row houses. Why? Because the credit crisis of 1772-3, which hit Scotland’s banks hard, was still fresh in his memory.
Before World War I financial crises were usually referred to as “panics.” For example, the U.S. Panic of 1837 involved both cotton-backed borrowing and a burst real-estate bubble, while the Panic of 1873 was centered on railroad speculation. As the “panic” label suggests, every financial crisis involves a rush to dump or sell some kind of asset, be it bank deposits or Greek debt.
But not every asset selloff is a financial crisis. While the NASDAQ lost three-quarters of its value between early 2000 and fall 2002, as the dotcom bubble burst, I don’t know of anyone who calls that a financial crisis. It was more of a Wile E. Coyote moment, named after the cartoon character who keeps running off cliffs. Obeying the laws of cartoon physics, he doesn’t fall until he looks down and realizes that there is nothing to support him.
The distinguishing feature of financial crises is their self-reinforcing nature: people rush to dump assets mainly because other people are rushing to dump those assets. That is, your decision to pull out is my motivation to pull out. For example, in a bank run people rush to cash out because other people are doing so. They fear that if they don’t do so, the bank will go under before they can rescue their funds.
Similarly, investors sometimes pull out of highly indebted nations’ currencies because of the flight of other investors. This causes the currency to fall, bankrupting local companies that have borrowed in dollars and crashing the economy, validating investors’ fears. The Indonesian crisis of 1997-9, illustrated at the top of this post, was a classic case. It involved an 80 percent decline in the rupiah and a 13 percent decline in real GDP.
As these examples suggest, financial crises can take multiple forms. There’s probably some deep underlying principle that underlies all crises, but I haven’t quite figured it out. However, as I said, every financial crisis I’ve looked at falls into one of two broad categories: liquidity crises or balance sheet crises.
Let’s look at the logic of each kind of crisis, along with some historical examples.
Bank runs and other liquidity crises
Embarrassingly few economists predicted the financial crisis of 2008. As far as I know, those who did also predicted many other crises that didn’t happen. But while the “Lehman moment” came as a shock, I don’t know any economists whose reaction was that we were seeing something unprecedented and impossible. Instead, all the economists I knew were wandering around muttering “Diamond-Dybvig, Diamond-Dybvig,” after the authors of a canonical theoretical analysis of bank runs, which won them a Nobel.
What many economists, myself included, suddenly realized was that financial institutions that don’t look like traditional banks — no marble buildings, no rows of tellers — can still be subject to the functional equivalent of bank runs.
All banks operate with a fundamental vulnerability. They take depositors’ money and put it into long-term assets like loans to businesses and home buyers. But they promise to return depositors’ cash on demand. And their loans can’t be sold quickly to raise cash except at fire sale prices.
In normal times, banks can manage this mismatch because depositors don’t all try to withdraw their money at the same time. That is, banks can operate with fairly small cash reserves because only a few depositors want to make withdrawals on any given day. But in abnormal times, if there is fear (justified or not) that a bank is in difficulty and may not be able to honor its promises to depositors, many depositors will in fact rush to withdraw their funds. And these fears, justified or not, can become a self-fulfilling prophecy, causing the bank to fail. Knowing this, everyone will try to pull their money out if they believe that others are about to do the same. That’s a bank run.
Furthermore, bank runs can be contagious: After one bank fails, depositors often flee other banks too, leading to a wave of bank runs. An epic wave of bank runs in 1930-31 was what turned a garden-variety recession into the Great Depression.
Old-fashioned bank runs have been rare since 1933, when FDIC insurance was introduced to protect depositors against bank failure (although depositors are only insured up to $250,000, as customers of Silicon Valley Bank recently learned.) But the lesson of 2008 was that institutions that aren’t officially banks can play bank-like roles in the economy and, as I said, experience the functional equivalent of bank runs.
In particular, Lehman Brothers didn’t take deposits. But it issued repo — debt securities with a one-day maturity — which many corporate treasurers used as a place to park their funds, because it seemed safe and offered slightly higher interest rates than bank deposits. The funds raised via repo were invested in mortgage-backed securities. Then, suddenly, repo no longer seemed safe, and the de facto bank run was on.
There’s some dispute about the extent to which the 2008 crisis should be seen as a “run on repo.” But repo and other forms of “shadow banking” were clearly central to the story.
Liquidity crises don’t have to involve banks, conventional or shadow. In 2011 the Belgian economist Paul De Grauwe argued that the euro area crisis then underway was not, as many argued, the result of unsupportable debt levels. It was, instead, a self-fulfilling liquidity crisis.
De Grauwe suggested that investors were unwilling to lend to some European governments, not because they were fundamentally insolvent, but because they might be forced into default by lack of cash — and the reason they might run out of cash was precisely that nobody would lend to them. His analysis was validated in 2012 when Mario Draghi, president of the European Central Bank, said three words — “whatever it takes” — that investors took to mean that the ECB would make sure that these governments weren’t forced into default. And the euro crisis rapidly faded away.
I’ve discussed liquidity crises because they have loomed so large historically. However, the pressures in U.S. financial markets right now don’t seem to involve a lack of liquidity, at least so far. Instead, they seem to be about deteriorating balance sheets.
Margin calls and other balance sheet crises
Liz Truss became Prime Minister of the United Kingdom on Sept. 6, 2022. She left office 49 days later, having failed to outlast a head of lettuce whose wilting the tabloid The Star livestreamed next to her portrait. What did her in was a surge in long-term British interest rates and a fall in the pound after she announced an economic plan built around belief in the magic of tax cuts.
Her plans were bad economics and would have increased the UK budget deficit. But Britain, like the United States, is an advanced nation that borrows in its own currency, which usually gives it a lot of leeway to run deficits. So what happened?
The answer seems to involve pension funds. British pension funds hold a lot of gilts — long-term government debt. But in an effort to achieve higher returns, they also hold other, riskier assets, hedging those risks with financial derivatives. The Truss budget, which drove up interest rates, reduced the value of the collateral they had put up to secure those derivatives. Sellers of derivatives demanded that they put up more collateral, which they could only do by selling gilts. And their sales drove bond prices down and interest rates even higher.
The Bank of England, Britain’s equivalent of the Federal Reserve, stepped in to limit the damage. More about policy responses to financial crisis next week. But Truss’s political fortunes never recovered.
Truss versus the head of lettuce will be remembered as a classic example of a balance sheet crisis. While, the British economy took a hit, other balance sheet crises have been much more frightening. Back in 1998 the whole world economy was shaken by the collapse of Long Term Capital Management, a hedge fund that had made huge bets on risky assets, mostly made with borrowed funds. When LTCM lost heavily on Russian investments, its desperate attempts to raise cash by selling its assets caused asset prices to plunge around the globe.
The LTCM panic was eventually contained by a show of confidence by U.S. officials. Readers of a certain age may remember this magazine cover:
I’ll talk next week about when and how official intervention can head off financial panics.
How can the losses of a single investor, like LTCM or a class of investors, like British pension funds, cause large declines in asset prices? Why don’t other investors step in to buy the dips and thereby stop the contagion?
I usually think about these things through the lens provided by Andrei Shleifer and Robert Vishny in their 1997 paper “The limits of arbitrage.” Shleifer and Vishny pointed out that arbitrageurs, who buy undervalued assets, are typically “highly specialized investors using other people’s capital.” While arbitrageurs mostly rely on other people’s money to buy the dips, such investors need to put up some of their own capital as collateral.
The problem is that a large decline in the prices of those assets shrinks the arbitrageurs’ own capital, and thereby reduces their ability to buy the dip. In fact, like British pension funds in 2022 or LTCM in 1998, they may be forced to sell when they should be buying. Hence the contagion spreads.
An aside: I’ve mentioned Silicon Valley Bank. What happened there wasn’t so much a bank run as a balance sheet issue. The bank, which had become a favorite place for tech bros to park their money, suffered large losses as interest rates rose and bond prices fell. At that point the supposedly smart money learned that their huge deposits mostly exceeded the maximum insured by the FDIC. They were bailed out, but this was a reminder that even conventional banks can pose risks.
But back to LTCM or UK pension fund-type crises: It looks as if something like that may be happening with U.S. hedge funds right now. But I’ll talk about that next week, by which time more may have happened.
All of what I’ve said so far is about investors like pension funds and hedge funds. How do emerging-market crises like Indonesia’s fit in? The answer is that the relevant balance sheets in that case were those of Indonesian businesses, many of which had borrowed in dollars. When the rupiah plunged, their debts measured in domestic currency exploded, forcing many into bankruptcy and drastically reducing the whole business sector’s ability to invest. The deep recession that followed — so deep that it amounted to a depression — validated foreign investors’ fears. So that was also a balance sheet crisis, involving a different set of actors.
I don’t think the Trump tariff regime will cause that severe an economic earthquake in America. But last week we were definitely feeling tremors, and it’s far from clear that this saga is over.
Un manuale della crisi finanziaria, parte prima. Come le cose possono andare storte in modo catastrofico.
Di Paul Krugman

La scorsa settimana è stato un periodo spaventoso per i mercati finanziari statunitensi, e il pericolo non è passato.
Non sto parlando delle azioni, le cui fluttuazioni spesso non ci dicono proprio niente. Quello che ha innervosito me ed altri sono stati gli sviluppi nei mercati delle obbligazioni e valutari. I tassi di interesse sui titoli del debito pubblico a lungo termine sono cresciuti bruscamente anche mentre il rischio percepito di una recessione, che normalmente spinge in basso i tassi, aumentava. E il dollaro in rapporto alle altre valute è calato anche se i tassi di interesse salivano.
Questi movimenti non sono normali per un paese avanzato come gli Stati Uniti. Tuttavia, la combinazione di tassi di interesse in crescita e di una valuta in calo mentre l’economia recede è qualcosa che si è visto spesso nei mercati emergenti che fronteggiano una crisi finanziaria. Il diagramma in cima a questo post mostra un esempio: l’Indonesia dal 1997 al 1999. Ovviamente, non abbiamo osservato niente di così grave per gli Stati Uniti. Ma io e molti altri ci stiamo chiedendo se non stiamo osservando i primi stadi di una crisi finanziaria negli Stati Uniti.
Dunque sembra un buon momento per pubblicare un manuale di economia delle crisi finanziarie. Tuttavia, questo è un tema vasto, così lo dividerò in due parti. Questa settimana discuterò la logica delle crisi finanziarie. La prossima discuterò le risposte politiche e gli sviluppi recenti negli Stati Uniti – sebbene lo sa Dio dove saremo a quel punto.
Questa volta non è diverso
Nel passato 2009 Carmen Reinhart e Ken Rogoff pubblicarono un formidabile libro sulle crisi finanziarie dal tiolo sarcastico “Questa volta è diverso”. Lo scherzo da umorismo macabro consisteva nel fatto che ogni qualvolta le persone liquidano i rischi di una crisi dicendo che le lezioni della storia non si applicano alla situazione attuale, la storia li morde … negli asset.
La verità è che le crisi finanziarie continuano ad avvenire. E quando ne accade una, retrospettivamente è sempre chiaro che la crisi è saltata fuori da una delle due cause: una crisi di liquidità o problemi di equilibri patrimoniali.
In una crisi di liquidità, che può comprendere ma non è limitata agli assalti agli sportelli bancari, le banche o altre istituzioni hanno obblighi che non possono soddisfare con breve preavviso, perché non possono vendere i propri asset se non a prezzi di svendita. E la paura che questi obblighi non verranno onorati porta alle cause per le quali gli investitori si precipitano alle vie d’uscita, approfondendo la crisi. In una crisi degli equilibri patrimoniali, i prezzi in calo degli asset costringono gli investitori o in alcuni casi i debitori a ridurre le spese e/o ad impegnarsi in svendite, spingendo ancora di più i prezzi in basso. Questo può provocare contagi, che si diffondono nell’economia, se la politica pubblica non contiene il danno.
Quindi il congelamento finanziario che seguì la caduta della Lehman Brothers nel 2008 fu fondamentalmente simile alla crisi bancaria del 1930-31. E l’ondata dei fallimenti delle banche agli inizi degli anni ‘930, non il crollo del mercato azionario del 1929, fu quello che rese la Grande Depressione un tale disastro.
Come spiegherò la prossima settimana, l’incipiente crisi del mercato dei bond che ha spaventato Donald Trump, sino alla falsa sospensione del suo Rose Garden [1] del regime tariffario, sembra essere stata, in sostanza, una crisi dei bilanci patrimoniali che era qualitativamente, per quanto non quantitativamente, simile alle crisi che sfasciarono l’economia mondiale alla fine degli anni ‘990.
Se le crisi finanziarie seguono sempre due copioni standard, perché spesso arrivano come sorprese persino per osservatori attenti? La risposta è che mentre la sottostante meccanica è la stessa, i dettagli di superficie possono apparire molto diversi. Mentre la crisi del 2008 fu fondamentalmente una crisi bancaria, in larga parte una sorta di assalto agli sportelli, essa si concentrava su istituti che non somigliavano – e, fondamentalmente, non erano regolati come le banche convenzionali. In modo simile, la crisi di bilancio che ha spinto i prezzi dei bond a crollare, e i rendimenti a volare in alto, dopo l’annuncio sulle tariffe del Rose Garden di Donald Trump, riguardano canali innovativi, in particolare il ruolo dei fondi speculativi nel “commercio di base” (come spiegherò la settimana prossima).
Dunque è difficile prevedere le crisi finanziarie. Talvolta si viene soltanto a sapere degli scheletri negli armadi quando la casa crolla. Ma quando la crisi colpisce, gli operatori politici debbono rispondere rapidamente e bene, oppure la crisi può infliggere un grave danno economico.
Da cosa è composta una crisi finanziaria?
Le crisi finanziarie sono accadute dalla nascita dei mercati finanziari. “La ricchezza delle nazioni” di Adam Smith, pubblicato nel 1776, è famoso per la sua difesa dei mercati liberi. Ma Smith si pronunciava anche per la regolamentazione delle banche, che egli paragonava alla richiesta delle pareti anti incendio tra le case a schiera. Perché? Perché la crisi del credito del 1772-3, che colpì duramente le banche scozzesi, era ancora fresca nella sua memoria.
Precedentemente alla Prima Guerra Mondiale, alle crisi finanziarie ci si riferiva di solito come crisi di “panico”. Ad esempio, il Panico statunitense del 1837 riguardò sia i prestiti sostenuti dal settore del cotone che lo scoppio di una bolla patrimoniale, mentre il Panico del 1873 era concentrato sulla speculazione sulle ferrovie. Come il termine “panico” suggerisce, ogni crisi finanziaria riguarda una corsa per scaricare o vendere quache genere di asset, che si tratti di depositi bancari o di titoli sul debito greco.
Ma non tutte le liquidazioni di asset sono crisi finanziarie. Mentre il NASDAQ perdeva tre quarti del suo valore tra gli inizi del 2000 e l’autunno del 2002, quando scoppiò la bolla del commercio elettronico, io non conosco nessuno che chiami quella una crisi finanziaria. È più qualcosa come un ‘momento di Willly il Coyote’ [2], titolo che deriva dal personaggio dei fumetti che continua a crollare dai precipizi. Obbedendo alle leggi della fisica dei fumetti, lui non crolla finché non guarda sotto e non si rende conto che non c’è niente che lo sorregga.
La caratteristica distintiva delle crisi finanziarie è la loro natura auto rafforzante: le persone si precipitano a scaricare asset principalmente perché altre persone si precipitano a scaricare quegli asset. Ovvero, la vostra decisione di venir fuori è la mia motivazione a venir fuori. Ad esempio, in un assalto agli sportelli bancari le persone si precipitano a ritirare il contante perché altre persone lo stanno facendo. Hanno paura che non facendolo, la banca andrà al fallimento prima che loro riescano a mettere in salvo i loro fondi.
In modo simile, talvolta gli investitori vengono fuori dalle valute delle nazioni altamente indebitate a causa della fuga di altri investitori. Questo porta la valuta al ribasso, mandando in bancarotta le società locali che si sono indebitate in dollari e facendo crollare l’economia, confermando le paure degli investitori. La crisi indonesiana illustrata in cima a questo post, fu un caso classico. Essa comportò un declino dell’80 per cento della rupia ed un declino del 13 per cento del PIL reale.
Come questi esempi indicano, le crisi finanziarie possono prendere molte forme. Probabilmente c’è qualche principio profondo sottostante che sta alla base di tutte le crisi, ma io non l’ho ancora compreso. Tuttavia, come ho detto, ogni crisi finanziaria che ho osservato ricade in una delle due generali categorie: crisi di liquidità o crisi degli equilibri patrimoniali.
Passiamo alla logica di ciascun tipo di crisi, assieme ad alcuni esempi storici.
Assalti agli sportelli delle banche ed altre crisi di liquidità
In modo imbarazzante, pochi economisti avevano previsto la crisi finanziaria del 2008. Per quanto ne so, coloro che lo fecero avevano anche previsto molte altre crisi che non erano avvenute. Ma mentre il “momento Lehman” arrivò come uno shock, non conosco nessun economista la cui reazione fu che eravamo in presenza di qualcosa senza precedenti e impossibile. Piuttosto, tutti gli economisti che conoscevo andavano in giro borbottando; “Diamond-Dybvig, Diamond-Dybvig”, riferendosi agli autori di una canonica analisi teorica degli assalti agli sportelli bancari che aveva loro permesso di vincere un Nobel.
Quello che molti economisti, me compreso, all’improvviso realizzarono fu che anche le istituzioni finanziarie che non somigliano alla banche tradizionali – senza edifici di marmo e senza fila di cassieri – possono essere soggette all’equivalente pratico degli assalti agli sportelli.
Tulle le banche operano con una vulnerabilità fondamentale. Esse prendono i soldi dei depositanti e li collocano in asset a lungo termine come i prestiti alle imprese ed agli acquirenti di abitazioni. E i loro prestiti non possono essere venduti rapidamente per raccogliere contante se non a prezzi di svendita.
In tempi normali, le banche possono gestire questa discrepanza perché i depositanti non cercano di ritirare il loro denaro tutti contemporaneamente. Ma in tempi anormali, se c’è la paura (giustificata o no) che la banca sia in difficoltà e possa non essere capace di onorare le sue promesse ai depositanti, di fatto molti di questi si precipiteranno a ritirare i loro fondi. E queste paure, giustificate o meno, possono divenire una profezia che si auto avvera, spingendo le banche al fallimento. Sapendo questo, ognuno cercherà di ritirare il proprio denaro se crede che gli altri stiano per fare la stessa cosa. Quello è un assalto agli sportelli.
Inoltre, gli assalti possono essere contagiosi: dopo il fallimento di una banca, i depositanti spesso fuggono anche da altre banche, portando ad un’ondata di assalti agli sportelli. Un’ondata epica di assalti agli sportelli nel 1930-31 fu quella che trasformò una ordinaria recessione nella Grande Depressione.
Gli assalti agli sportelli dei tempi andati sono stati rari a partire dal 1933, quando venne introdotta l’assicurazione presso la Federal Deposit Insurance Corporation per proteggere i depositanti dai fallimenti delle banche (sebbene i depositanti siano assicurati soltanto sino a 250.000 dollari, come i clienti della Silicon Valley hanno di recente appreso). Ma la lezione del 2008 fu che gli istituti che non sono ufficialmente banche possono giocare ruoli simili a banche nell’economia e, come ho detto, fare esperienza del sostanziale equivalente degli assalti agli sportelli.
In particolare, la Lehman Brothers non prendeva depositi. Ma emetteva repo – titoli sul debito con la scadenza di un giorno – che molte tesorerie delle società utilizzavano come un posto per parcheggiare i loro fondi, perché ciò sembrava sicuro e offriva tassi di interesse leggermente più alti dei depositi bancari. I fondi raccolti tramite i repo venivano investiti in titoli garantiti da ipoteche. Poi, all’improvviso, i repo non sembrarono più sicuri, e avvenne di fatto un assalto agli sportelli.
C’è qualche discussione sulla misura in cui la crisi del 2008 debba essere considerata come un “assalto ai repo”. Ma i repo ed altre forme del “sistema bancario ombra” furono chiaramente centrali nella storia.
Le crisi di liquidità non debbono riguardare le banche, convenzionali o ombra. Nel 2011, l’economista belga Paul De Grauwe sostenne che la crisi dell’area euro allora in corso non era, come molti credevano, il risultato di livelli insopportabili di debito. Era piuttosto una crisi di liquidità che si auto avverava.
De Grauwe suggeriva che gli investitori erano indisponibili a fare prestiti ad alcuni governi europei, non perché essi fossero fondamentalmente insolventi, ma perché potevano essere costretti al default per mancanza di contante – e la ragione per la quale potevano esaurire il contante era esattamente che nessuno glielo avrebbe prestato. La sua analisi venne convalidata nel 2012 quando Mario Draghi, Presidente della Banca Centrale Europea, pronunciò tre parole – “qualsiasi cosa serva” – che gli investitori intesero significare che la BCE avrebbe garantito che questi governi non fossero costretti al default. E la crisi dell’euro rapidamente svanì.
Ho discusso delle crisi di liquidità perché esse si sono prospettate frequentemente nella storia. Tuttavia, le pressioni nei mercati finanziari statunitensi in questo momento non sembrano riguardare una crisi di liquidità, almeno sinora. Piuttosto, sembrano consistere in un deterioramento degli equilibri patrimoniali.
Richieste di margine [3] ed altre crisi degli equilibri patrimoniali
Liz Truss divenne Primo Ministro del Regno Unito il 6 settembre del 2022. Lasciò il suo incarico 49 giorni dopo, non essendo riuscita a sopravvivere ad un cespo di lattuga la cui sfioritura il tabloid The Star trasmetteva a fianco del suo ritratto [4]. Quello che ella provocò fu una crescita dei tassi di interesse britannici ed una caduta della sterlina dopo aver annunciato un piano economico costruito sulla magia del tagli delle tasse.
I suoi progetti erano una pessima economia e avrebbero accresciuto il deficit del bilancio del Regno Unito. Ma il Regno Unito [5], come gli Stati Uniti, sono una nazione avanzata, che nella propria valuta di solito prende prestiti, che solitamente le danno una gran quantità di margini per gestire deficit. Dunque, cosa accadde?
La risposta sembra riguardi i fondi pensione. I fondi pensione britannici contengono una gran quantità di “gilts” – titoli a lungo termine sul debito pubblico. Ma nello sforzo di realizzare rendimenti più elevati, essi contengono anche altri asset, più rischiosi, che coprono quei rischi con derivati finanziari [6]. Il bilancio della Truss, che spingeva in alto i tassi di interesse, riduceva il valore delle garanzie che erano state collocate per assicurare quei derivati. I venditori dei derivati chiesero che venissero aggiunte maggiori garanzie, cosa che essi potevano fare solo vendendo gilts. E le loro vendite spinsero in basso i prezzi delle obbligazioni e persino più in alto i tassi di interesse.
La Banca di Inghilterra, l’equivalente britannico della Federal Reserve, intervenne per limitare il danno. La prossima settimana dirò di più sulle risposte politiche alle crisi finanziarie. Ma le fortune politiche della Truss non si sono più riprese.
Il confronto tra la Truss ed il cespo di lattuga sarà ricordato come un classico esempio di crisi degli equilibri patrimoniali. Mentre l’economia del Regno Unito prese un colpo, altre crisi degli equilibri patrimoniali sono state molto più spaventose. Nel passato 1998 l’intera economia mondiale fu scossa dal collasso di Long Term Capital Management (LTCM), un fondo speculativo che aveva fatto grandi scommesse su asset rischiosi, per la maggior parte fatte con fondi presi a prestito. Quando LTCM perse pesantemente su investimenti russi, i suoi disperati tentativi di raccogliere contante vendendo i suoi asset provocarono un crollo dei prezzi degli asset in tutto il pianeta.
Il ‘panico’ della LTCM venne alla fine contenuto da una manifestazione di fiducia da parte dei dirigenti statunitensi. I lettori di una certa età possono ricordare questa copertina di una rivista:
La prossima settimana parlerò su quando e come gli interventi ufficiali possono prevenire i panici finanziari.
Come possono le perdite di un singolo investitore, come LTCM, o di una classe di investitori, come i fondi pensione britannici, provocare vasti declini nei prezzi degli asset? Perché altri investitori non intervengono per acquistare i ribassi e di conseguenza fermare il contagio?
Di solito io ragiono di queste cose attraverso le lenti fornite da Andrei Shleifer e Robert Vishny nel loro saggio del 1997 “I limiti dell’arbitraggio”. Andrei Shleifer e Vishny mettevano in evidenza che gli arbitri, coloro che acquistano gli asset sottovalutati, sono tipicamente “investitori altamente specializzati che usano il capitale di altre persone”. Mentre gli arbitri per la maggior parte si basano sul denaro di altre persone per acquistare i ribassi, quegli stessi investitori hanno bisogno di mettere un po’ del loro capitale come garanzia.
Il problema è che il vasto declino dei prezzi di quegli asset restringe lo stesso capitale degli arbitri e di conseguenza riduce la loro capacità di acquistare i ribassi. Di fatto, come i fondi pensionistici britannici nel 2022 o la LTCM nel 1998, essi possono essere costretti a vendere quando dovrebbero acquistare. Quindi il contagio si diffonde.
Un inciso: ho fatto riferimento alla Silicon Valley Bank. Quello che è accaduto in quel caso non è stato tanto un assalto agli sportelli quanto una faccenda di equilibri patrimoniali. La banca, che era diventata il luogo preferito dei confratelli della tecnologia per parcheggiare il loro denaro, aveva sofferto ampie perdite nel mentre i tassi di interesse crescevano e i prezzi delle obbligazioni scendevano. A quel punto i presunti soggetti del denaro intelligente appresero che i loro depositi per la maggior parte eccedevano il massimo assicurato dalla FDIC. Essi vennero messi in salvo, ma questo fu un ammonimento che persino le banche tradizionali possono costituire rischi.
Ma torniamo alle crisi della LTCM e del genere di fondi pensioni del Regno Unito: esse sembrano qualcosa di simile a quanto può stare avvenendo in questo momento con i fondi speculativi statunitensi. Ma di ciò parleremo la prossima settimana, nel qual tempo potrebbe essere accaduto altro.
Tutto quello che ho detto sinora riguarda gli investitori come i fondi pensionistici e i fondi speculativi. Come si adattano a ciò le crisi dei mercati emergenti come l’Indonesia? La risposta è che i rilevanti equilibri patrimoniali in quel caso erano quelli delle imprese indonesiane, molte delle quali avevano preso prestiti in dollari. Quando crollò la rupia, i loro debiti misurati nella valuta nazionale esplosero, costringendo molte di esse alla bancarotta e riducendo la capacità di investire dell’intero settore imprenditoriale. La profonda recessione che ne conseguì – così profonda che corrispose ad una depressione – convalidò le paure degli investitori stranieri. Dunque anche quella fu una crisi di equilibri patrimoniali, che coinvolse un diverso complesso di protagonisti.
Non penso che il regime tariffario di Trump provocherà un tale grave terremoto economico in America. Ma la scorsa settimana abbiamo sicuramente avvertito delle scosse, ed è lungi dall’essere chiaro che questa saga sia terminata.
[1] Il Rose Garden, dove Trump giorni orsono ha tenuto la conferenza stampa con l’annuncio della sospensione di una parte delle nuove tariffe è un giardino della Casa Bianca. È situato tra lo Studio Ovale e la West Wing.
[2] Promemoria per il ‘momento di Willy il Coyote’:
[3] Margin call è una notifica che viene inviata a un trader quando il saldo del suo conto scende al di sotto del livello richiesto per mantenere aperta una posizione. In questo caso, il trader viene chiamato a ricostituire il margine di garanzia.
[4] Effettivamente accadde. Una incredibilmente dettagliata ricostruzione della vicenda del “cespo di lattuga” su Wikipedia, lingua inglese, sotto il titolo “Liz Truss lattuce”.
[5] Una volta per tutte: il Regno Unito è la nazione che incorpora quattro paesi (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord); la Gran Bretagna è l’isola maggiore che comprende tre di quei quattro paesi, esclusa l’Irlanda del Nord; l’Inghilterra è solo uno di quei tre paesi, quello più meridionale dell’isola maggiore. Dunque, se non sbaglio, quando gli americani o gli altri usano il termine “Britain” – che è una abbreviazione di “Great Britain” – per indicare il Regno Unito (come fa Krugman nella frase sopra), sbagliano. Invece, noi italiani di solito sbagliamo indicando con il termine Inghilterra l’intero Regno Unito.
Ovviamente, anche in italiano può essere conveniente utilizzare l’abbreviazione “britannico/a” – come quando, nelle frasi successive, si parla di “fondi pensione britannici”. Non sarebbe ragionevole chiamarli “fondi pensione “gran-britannici”! Ciononostante, anche lì si commette un errore se il termine di riferisce ad oggetti che riguardano tutto il Regno Unito (suppongo che i fondi pensione siano gli stessi in Irlanda del Nord). È un errore veniale, che ci possiamo permettere, ma che probabilmente provoca qualche irritazione negli irlandesi.
[6] Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante nota anche come “underlying asset“. Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, gli indici) o reale (come ad esempio il caffè, il cacao, l’oro, il petrolio, ecc).
Gli strumenti finanziari derivati possono essere simmetrici o asimmetrici. Nel primo caso entrambi i contraenti (acquirente e venditore) si impegnano ad effettuare una prestazione alla data di scadenza, viceversa, nei derivati asimmetrici, soltanto il venditore è obbligato a soddisfare la volontà del compratore. Nei derivati asimmetrici, infatti, il compratore, pagando un prezzo (detto premio), acquisisce il diritto di decidere in data futura se effettuare oppure no la compravendita del bene sottostante. (Borsa Italiana)
[7] I tre personaggi della copertina di TIME sono, da sinistra: Robert Robin (Segretario al Tesoro), Alan Greenspan (Presidente della Federal Reserve) e Lawrence Summers (Vice Segretario al Tesoro).
Il terzo-mondismo dell’America, di Paul Krugman (dal blog di Krugman, 11 aprile 2025)
aprile 12, 2025
Apr. 11, 2025
The Third-Worlding of America
Paul Krugman
Source: CNBC
Oops, they’re doing it again.
Major news media organizations sanewashed Donald Trump all through the 2024 campaign, cleaning up his incoherence and downplaying his extreme policy positions. Aaron Rupar reminds us of this:
It’s hard to know how much that contributed to his victory, but it must have been a factor.
But the desire to see Trump as reasonable is a more widely shared syndrome which isn’t confined to the media. It was abetted by the business world, which was gripped by “euphoria” after he won, despite clear signs that he would implement destructive economic policies.
Remarkably, the sanewashing continues despite the unprecedented craziness of the past 10 days. Many observers assert that Trump has backed down on tariffs and will speedily make a bunch of trade deals. The first assertion is just false, while the second is very unlikely.
In fact, savvy traders have realized that there’s no coherent economic strategy. There’s an old line about military analysis: “Amateurs talk about tactics, but professionals talk about logistics.” Well, when it comes to taking the pulse of financial markets, amateurs talk about stocks, but professionals talk about bond and currency markets. That’s because bond and currency markets are generally less driven by emotion. There’s no “meme gambling investing” in bond and currency markets. And these markets are both signaling major loss of faith in America.
First, about tariffs: It’s true that for the time being Trump has scaled back some of the tariffs displayed on his big piece of cardboard last week. For example, unless we have another policy swerve, the European Union will now face a 10 percent tariff over the next three months rather than a 20 percent tariff. But the tariff on China, our third-biggest trading partner after Canada and Mexico, has gone from 34 percent to more than 130 percent. And we still have high tariffs on steel, aluminum and so on. In effect, observers who claim that tariffs have gone down are missing the biggest part of the story.
Economists who have actually run the numbers, like those at the Yale Budget Lab, estimate that the April 9 tariff regime will raise consumer prices more than the April 2 regime because of the extraordinarily high tariff rate on Chinese imports. Specifically, the budget lab estimates that the latest version of Trump’s trade war will raise consumer prices by 2.9 percent. This is roughly ten times the probable impact of the infamous Smoot-Hawley tariff of 1930.
It’s hard to overstate the craziness of announcing a radical tariff plan, then announcing a quite different but equally radical plan just a week later. Furthermore, the claim that the wild zigzags in policy were always part of Trump’s plan just adds to the destruction of the administration’s credibility.
But are these tariffs just an opening gambit for trade negotiations? I doubt it. Bear in mind that Trump and Peter Navarro, his tariff guru, start from the premise that other countries are cheating, that they’re taking advantage of America and treating us unfairly. In fact, however, most of them aren’t. Take the case of the European Union. The EU imposes an average tariff on U.S. goods of just 1.7%, and there aren’t any significant hidden barriers.
So what are we supposed to be negotiating about? Nations can’t promise to lower their trade barriers when there aren’t any barriers. Navarro has been claiming that value-added taxes are de facto tariffs, but they aren’t, and EU nations literally can’t afford to give them up.
I guess other countries might make fake concessions that Trump can claim as fake victories. This is what he did with China during his first term, claiming that it had made significant concessions — claims which were, in the end, false. In fact, American soybean farmers have never fully recovered the loss of market share. And remember too how Trump made minor changes to NAFTA and claimed to have negotiated a whole new trade pact.
However, Trump is now clearly high on his own supply. Even with the April 9 tariff regime, Trump is imposing high tariff rates on our three largest trading partners. Currency and bond market traders — no fools they — are certainly not acting as if we’re on a path to successful deals.
For example, economic theory and history both say that the imposition of tariffs normally leads to a stronger currency unless other countries retaliate. During his confirmation hearing Scott Bessent, the incoming Treasury secretary, argued that a 10 percent tariff would lead to something like a 4 percent rise in the dollar. But not this time. Instead of going up, the dollar has plunged.
Source: xe.com
The obvious explanation is that crazy policies have shaken investors’ faith in America, which has traditionally been viewed as a safe haven.
The topic of how Trump’s policies have messed with the bond markets – including the market for US Treasuries — is too difficult for me to cover today, but here’s more. The key point is that massive tariffs have disrupted the plumbing of the financial system, leading to soaring interest rates on U.S. government debt. That’s abnormal: rising odds of a recession usually lead to falling long-term interest rates, because the prospect of a recession raises the likelihood of future cuts by the Fed, which controls short-term rates. This time, however, rates are spiking, especially for very-long-term instruments like 30-year bonds, shown at the top of this post.
The common thread in currency and bond markets is that, thanks to Trump, dollar assets — traditionally the foundation of the global financial system — are no longer perceived as safe.
The combination of interest rates soaring amid a slump and the currency plunging despite rising interest rates isn’t what we normally expect for advanced countries, let alone the owner of the world’s leading reserve currency. It is, however, what we often see in emerging-market economies. That is, investors have started treating the United States like a third-world economy.
Did I see this coming? No, not really. Unlike the sanewashers, I knew that Trump’s policies would be irresponsible and destructive. However, even I didn’t expect him to destroy credibility accumulated over 80 years in less than three months. But he has.
And even if Trump were to backtrack on everything he’s done, we wouldn’t get the lost credibility back. The whole world, sanewashers aside, now knows that America is run by a mad king, surrounded by enablers, who can’t be trusted to behave rationally.
I don’t know how this ends. In fact, I don’t know what policy will be next week. But that’s basically the point.
Il terzo-mondismo dell’America,
di Paul Krugman
Fonte: CNBC [1]
Ops, sta di nuovo accadendo.
Le principale agenzie giornalistiche hanno edulcorato [2] Donald Trump per tutto il corso della campagna elettorale del 2024, ripulendo le sua incoerenze e minimizzando le sue posizioni politiche estreme. Aaron Rupar ce lo ricorda con questo esempio:
Harris e Trump sposano le tariffe, sebbene i loro approcci siano diversi .
Sia i democratici che i repubblicani stanno esprimendo sostegno alle tariffe per proteggere l’industria americana, rovesciando decenni di pensiero in materia di commercio a Washington.
È difficile capire quanto ciò abbia contribuito alla sua vittoria, ma esso deve essere stato un fattore.
Ma il desiderio di considerare Trump ragionevole è una sindrome più ampiamente condivisa, che non è confinata ai media. Essa è stata favorita dal mondo delle imprese, che dopo la sua vittoria venne preso da “euforia”, nonostante chiari segni che avrebbe messo in atto politiche economiche distruttive.
In modo rilevante, l’edulcorazione prosegue nonostante la follia senza precedenti dei dieci giorni passati. Molti osservatori sostengono che Trump abbia fatto marcia indietro sulle tariffe e farà velocemente un mucchio di accordi commerciali. Il primo giudizio è semplicemente falso, mentre il secondo è altamente improbabile.
Nei fatti, gli operatori esperti hanno compreso che non c’è alcuna coerente strategia economica. C’è un vecchio detto a proposito dell’analisi militare; “I dilettanti parlano di tattiche ma i professionisti parlano di logistica”. Ebbene, quando si tratta di prendere il polso dei mercati finanziari, i dilettanti parlano di azioni ma i professionisti parlano di obbligazioni e di mercati valutari. Questo perché le obbligazioni ed i mercati valutari in generale sono meno guidati dalle emozioni. Nelle obbligazioni e nei mercati valutari non ci sono “investimenti da suggestione da gioco d’azzardo”. E questi mercati stanno entrambi segnalando una importante perdita di fiducia nell’America.
Anzitutto, sulle tariffe: è vero che per il momento Trump ha ridotto alcune delle tariffe mostrate nel suo grande spettacolo di cartone della settimana passata. Ad esempio, a meno che non ci sia un altro scarto politico, adesso l’Unione Europea sarà di fronte ad una tariffa del 10 per cento per i prossimi tre mesi, anziché una tariffa del 20 per cento. Ma la tariffa sulla Cina, il nostro più grande partner commerciale dopo il Canada ed il Messico, è passata dal 34 per cento a più del 130 per cento. E abbiamo ancora tariffe sull’acciaio, sull’alluminio e via dicendo. In sostanza, gli osservatori che sostengono che le tariffe sono calate stanno perdendo la parte più grande della storia.
Gli economisti che hanno effettivamente fatto i conti, come quelli al Budget Lab di Yale, stimano che il regime tariffario del 9 aprile eleverà i prezzi al consumo più del regime tariffario del 2 aprile a causa del tasso tariffario straordinariamente alto sulle importazioni cinesi. In particolare, il Budget Lab stima che l’ultima versione della guerra commerciale di Trump aumenterà i prezzi al consumo del 2,9 per cento. Questo corrisponde grosso modo a circa dieci volte il probabile impatto della famigerata tariffa Smoot-Hawley del 1930.
È difficile esagerare la follia dell’annunciare un piano tariffario radicale e poi annunciare un piano tariffario abbastanza diverso ma egualmente radicale la settimana dopo. Inoltre, l’argomento che i selvaggi zigzag in politica sono sempre stati parte del progetto di Trump semplicemente aumenta la distruzione della credibilità della amministrazione.
Ma queste tariffe sono solo uno stratagemma di apertura dei negoziati commerciali? Lo dubito. Si tenga a mente che Trump e Peter Navarro, il suo guru tariffario, partono dalla premessa che gli altri paesi stanno imbrogliando, che si avvantaggiano sull’America e ci trattano ingiustamente. Di fatto, tuttavia, non è quello che fanno la maggior parte di loro. Si prenda il caso dell’Unione Europea. L’UE impone una tariffa media sui prodotti statunitensi soltanto dell’1,7 per cento e non ci sono alcune significative barriere nascoste.
Dunque, cosa si suppone di negoziare? Navarro non può promettere di abbassare le loro barriere commerciali quando non c’è alcuna barriera. Navarro sta sostenendo che le tasse sul valore aggiunto sono tariffe di fatto, ma non lo sono e le nazioni dell’UE non possono letteralmente permettersi di rinunciarvi.
Suppongo che altri paesi potrebbero fare false concessioni che Trump possa presentare come false vittorie. È quello che fece con la Cina durante il suo primo mandato, sostenendo che essa aveva fatto concessioni significative – argomenti che, alla fine, risultarono falsi. Di fatto, i coltivatori americani di soia non si sono mai pienamente ripresi dalla perdita di quote di mercato. E si ricordi anche come Trump fece cambiamenti secondari al NAFTA e sostenne di aver negoziato un patto commerciale interamente nuovo.
Tuttavia, Trump è adesso chiaramente andato troppo oltre con la sua merce. Persino col regime tariffario del 9 aprile, Trump sta imponendo elevati tassi tariffari sui nostri tre più grandi partner commerciali. Gli operatori del mercato valutario e dei bond – loro non sono sciocchi – non stanno certamente agendo come se fossimo su un sentiero di accordi di successo.
Ad esempio, sia la teoria che la storia economica dicono che l’imposizione di tariffe conduce normalmente a valute più forti a meno che gli altri paesi non reagiscano. Durante la sua audizione di conferma Scott Bassent, il prossimo Segretario al Tesoro, ha sostenuto che una tariffa del 10 per cento porterebbe a qualcosa di simile ad un apprezzamento del 4 per cento del dollaro. Ma non è il caso di questa volta. Anziché salire, il dollaro è in caduta.
Fonte: we.com
L’ovvia spiegazione è che le politiche pazzesche hanno scosso la fiducia degli investitori sull’America, che tradizionalmente veniva considerata come un rifugio sicuro.
Il tema di come le politiche di Trump abbiano messo nei guai il mercato dei bond – compreso il mercato dei titoli del Tesoro statunitense – è troppo complesso perché lo possa esaminare oggi, ma in questa connessione c’è qualcosa di più [3]. Il punto cruciale è che le massicce tariffe hanno perturbato l’idraulica del sistema finanziario, portando a tassi di interesse sul debito governativo statunitense che si sono alzati in volo. Ciò è anormale: di solito le probabilità crescenti di una recessione portano ad una caduta dei tassi di interesse a lungo termine, giacché la prospettiva di una recessione accresce la probabilità di futuri tagli da parte della Fed, che controlla i tassi a breve termine. Questa volta, tuttavia, i tassi si stanno impennando, in particolare per gli strumenti a lunghissimo termine come i bond trentennali, mostrati in cima a questo post.
Il filo che accomuna i mercati valutari e dei bond è che, grazie a Trump, gli asset in dollari – tradizionalmente il fondamento del sistema finanziario globale – non sono più percepiti come sicuri.
La combinazione dei tassi di interesse in crescita nel mezzo di un calo e della caduta della valuta nonostante tassi di interesse crescenti non è quello che normalmente ci si aspetta da paesi avanzati, per non dire dal possessore della principale valuta di riserva del mondo. Tuttavia, è quello che spesso si osserva nelle economie dei mercati emergenti. Ovvero, gli investitori hanno cominciato a trattare gli Stati Uniti come un’economia del terzo mondo.
L’avevo previsto? No, no davvero. Diversamente dagli ‘edulcoratori’, sapevo che le politiche di Trump sarebbero state irresponsabili e distruttive. Tuttavia, anch’io non mi aspettavo che lui distruggesse in meno di tre mesi la credibilità accumulata nel corso di 80 anni. Ma lo ha fatto.
E persino se Trump facesse marcia indietro su ogni cosa che ha fatto, non riavremo la credibilità perduta. Il mondo intero, a parte i minimizzatori, adesso sa che l’America è governata da un re pazzo, circondato da complici, che non si può credere si comporti razionalmente.
Non so come andrà a finire. Di fatto, non so quale politica avremo la settimana prossima. Ma fondamentalmente il punto è proprio questo.
[1] Il diagramma mostra l’andamento dei rendimenti del titoli trentennali del Tesoro americani negli ultimi giorni. Sul finale di questo post, Krugman torna e spiega meglio il senso di quel diagramma. Si noti che è lo stesso tema dell’articolo che abbiamo in precedenza pubblicato di Adam Tooze.
Si tenga anche presente che con il termine “yields” – “rendimenti” – in questo caso ci si riferisce ai tassi di interesse; che i tassi di interesse salgano significa che gli “yields” salgono, perché sono essi e non altro la misura dei rendimenti delle obbligazioni.
[2] “To sanewash” è un neologismo americano e vien da pensare che un qualche rapporto con le vicende politiche attuali ce l’abbia (probabilmente il termine era preesistente, ma queste ultime lo hanno reso assai diffuso). Troppo letteralmente lo si potrebbe tradurre con “trattamento di salute mentale”; “edulcorare” è forse una soluzione un po’ riduttiva.
[3] La connessione è con un lungo articolo del 9 aprile di Nathan Tankus dal titolo “D’un tratto siamo entrati nel momento ‘Leheman Brothers’ di questa crisi”.
Una stupidità maligna ammazzerà l’economia mondiale? Di Paul Krugman (dal blog di Krugman. 3 aprile 2025)
aprile 5, 2025
Apr. 3, 2025
Will Malignant Stupidity Kill the World Economy?
Paul Krugman
 America created the modern world trading system. The rules governing tariffs and the negotiating process that brought those tariffs down over time grew out of the Reciprocal Trade Agreements Act, devised by FDR in 1934. The growth in international trade under that system had some negative aspects but was on balance very good for America and the world. It was, in fact, one of our greatest policy achievements.
America created the modern world trading system. The rules governing tariffs and the negotiating process that brought those tariffs down over time grew out of the Reciprocal Trade Agreements Act, devised by FDR in 1934. The growth in international trade under that system had some negative aspects but was on balance very good for America and the world. It was, in fact, one of our greatest policy achievements.
Yesterday Donald Trump burned it all down. Here’s what just happened to the average U.S. tariff rate:
Source: USITC and Yale Budget Lab
The tariffs Trump announced were higher than almost anyone expected. This is a much bigger shock to the economy than the infamous Smoot-Hawley tariff of 1930, especially when you bear in mind that international trade is about three times as important now as it was then.
The size of the tariffs, however, wasn’t the only shocking thing about the Rose Garden announcement. Arguably what we learned about how the Trump team arrived at those tariff rates — the sheer malignant stupidity of the whole thing — was even worse.
You might be tempted to dismiss complaints about the policy process as elitist snobbery. But credibility is a crucial part of policymaking. Businesses can’t plan if they have no idea what to expect next. Foreign governments won’t make policies that help America if they don’t expect us to respond rationally.
So what do we know about how the Trumpists arrived at their tariff plan? Trump claimed that the tariff rates imposed on different countries reflected their policies, but James Surowiecki soon noted that the tariffs applied to each country appeared to be derived from a crude formula based on the U.S. trade deficit with that country. Trump officials denied this, while at the same time the Office of the U.S. Trade Representative released a note confirming Surowiecki’s guess. Here’s their explanation:
Source: USTR
Ignore the Greek letters, which cancel each other out. This says that the assumed level of a country’s protectionism is equal to its trade surplus with America divided by its exports to America.
Trump also set minimum tariffs of 10 percent on everyone, which means among other things imposing tariffs on uninhabited islands.
There’s so much wrong with this approach that it’s hard to know where to start. But one easy thing to point out is that the Trump calculation only considers trade in goods, while ignoring trade in services. This is a big omission. Notably, the European Union runs a substantial surplus with us if you only look at trade in goods — but this is largely offset by an EU deficit in services trade:
Source: European Commission
So if Trump’s people had plugged all trade with the EU, not just trade in physical goods, into their formula they would have concluded that Europe is hardly protectionist at all.
Where is this stuff coming from? One of these days we’ll probably get the full story, but it looks to me like something thrown together by a junior staffer with only a couple of hours’ notice. That USTR note, in particular, reads like something written by a student who hasn’t done the reading and is trying to bullshit their way through an exam.
But it may be even worse than that. The Trump formula is apparently what you get if you ask ChatGPT and other AI models to make tariff policy.
ϵ*Ф*mi
ϵ*Ф*miϵ*Ф*mi
In my post immediately following the Trump announcement I speculated that Elon Musk’s Dunning-Kruger kids might be responsible for those tariff numbers. That now looks like a distinct possibility.
Who makes policy this way? The key point is that Trump isn’t really trying to accomplish economic goals. This should all be seen as a dominance display, intended to shock and awe people and make them grovel, rather than policy in the normal sense.
Again, I’m not being snobbish here. When the fate of the world economy is on the line, the malignant stupidity of the policy process is arguably as important as the policies themselves. How can anyone, whether they’re businesspeople or foreign governments, trust anything coming out of an administration that behaves like this?
Next thing you’ll be telling me that Trump’s people are planning military actions over insecure channels and accidentally sharing those plans with journalists. Oh, wait.
I’d like to imagine that Trump will admit that he messed up, cancel the whole thing, and start over. But he won’t, because that would spoil the dominance display. Ignorant irresponsibility is part of the message.
Una stupidità maligna ammazzerà l’economia mondiale?
Di Paul Krugman
L’America ha creato il moderno sistema commerciale del mondo. Le regole che governano le tariffe e le procedure dei negoziati che hanno abbassato quelle tariffe nel corso del tempo derivano dalla Legge sugli accordi commerciali reciproci, concepita da Franklin Delano Roosevelt nel 1934. La crescita del commercio internazionale sotto quel sistema è stata per alcuni aspetti negativa, ma nel complesso è stata molto positiva per l’America e per il mondo. Essa è stata, di fatto, una delle nostre maggiori realizzazioni politiche.
Ieri Donald Trump l’ha ridotta in cenere. Ecco cosa è appena successo al tasso tariffario medio statunitense:
Fonte: USITC e Yale Budget Lab.
Le tariffa che Trump ha annunciate sono più alte di quanto si aspettavano quasi tutti. Questo è uno shock all’economia molto più grande della famigerata tariffa Smoot-Hawley del 1930, in particolare se si tiene a mente che il commercio è oggi tre volte più importante di allora.
Le dimensioni delle tariffe, tuttavia, non sono l’unica cosa impressionante dell’annuncio al Rose Garden. Probabilmente ancora peggiore è stato quello che abbiamo appreso su come i collaboratori di Trump sono arrivati a quelle tariffe – la vera e propria velenosa stupidità dell’intera faccenda.
Potreste essere tentati di liquidare le lamentele sulla procedura politica come uno snobismo elitario. Ma la credibilità è una parte cruciale del procedimento politico. Le imprese non possono programmare se non hanno idea di quello che si aspettano successivamente. I governi stranieri non adotteranno politiche che aiutino l’America se non si aspettano da noi risposte razionali.
Dunque, cosa sappiamo su come i trumpiani sono arrivati al loro piano delle tariffe? Trump ha sostenuto che i tassi tariffari imposti su diversi paesi erano il riflesso delle loro politiche, ma James Surowiecki [1] ha subito osservato che le tariffe applicate a ciascun paese parevano derivare da una rozza formula basata sul deficit commerciale degli Stati Uniti con quel paese. I dirigenti di Trump lo hanno negato, mentre contemporaneamente l’ufficio della Rappresentanza Commerciale degli Stati Uniti (USTR) ha rilasciato una nota che confermava l’impressione di Surowiecki. Ecco la loro spiegazione:
Approccio di base
Si consideri un contesto nel quale gli Stati Uniti impongono una tariffa di un tasso Τ_i su un paese i e Ϫϒ_i rifletta il cambiamento nel tasso della tariffa. Ammettiamo che ϵ<0 rappresenti l’elasticità dei prezzi all’importazione, che Ф>0 rappresenti il passaggio dalle tariffe ai prezzi di importazione, che i>0 rappresentino le importazioni totali e che x_i>0 rappresentino le esportazioni totali. Allora la diminuzione nelle importazioni a seguito del cambiamento delle tariffe sarà pari a ϪΤ_i*ϵ*Ф*mi<0. Assumendo che il tasso di cambio di bilanciamento e gli effetti dell’equilibrio generale siano abbastanza piccoli da essere ignorati, la tariffa reciproca che determina un saldo commerciale bilaterale pari a zero soddisfa:
ϪΤi=xi – mi / ϵ*Ф*mi
[2]
Fonte: USTR
Si ignorino le lettere greche, che si annullano l’una con l’altra. Questo ci dice che il livello ipotizzato del protezionismo di un paese sia pari al suo surplus commerciale con l’America diviso per le sue esportazioni verso l’America.
Trump ha anche stabilito tariffe minime del 10 per cento, il che tra le altre cose comporta di imporre tariffe sulle isole disabitate.
In questo approccio c’è così tanto di sbagliato che è difficile capire da dove partire. Ma una cosa semplice da mettere in evidenza è che il calcolo di Trump considera soltanto il commercio di prodotti, mentre ignora il commercio in servizi. Questa è una grande omissione. In particolare, l’Unione Europea realizza un sostanziale surplus con noi soltanto se voi guardate al commercio in prodotti – ma questo è in gran parte bilanciato da un deficit dell’UE nel commercio in servizi:
Fonte: Commissione Europea
Dunque, se i collaboratori di Trump avessero inserito nella loro formula tutti i commerci con l’UE, non solo quelli in prodotti fisici, essi avrebbero dovuto concludere che l’Europa non è protezionista affatto.
Da dove viene fuori tutta questa roba? Uno di questi giorni probabilmente avremo l’intero racconto, ma a me sembra messo assieme da un componente giovane dello staff che abbia ricevuto appena un paio d’ore di preavviso. In particolare, quella nota dell’USTR recita qualcosa che è stato scritto da uno studente che non ha fatto le sue letture e sta cercando di superare un esame con tante sciocchezze.
Ma potrebbe essere anche peggio di così. La formula di Trump è a quanto pare quello che voi ottenete se chiedete a ChatGPT o ad altri modelli di Intelligenza Artificiale di definire un politica tariffaria.
In un post immediatamente a seguito dell’annuncio di Trump io ipotizzavo che i ragazzi Dunning-Kruger [3] di Elon Musk potrebbero essere responsabili di quei dati sulle tariffe. La qualcosa adesso appare come una chiara possibilità.
Chi fa politica in questo modo? Il punto centrale è che Trump non sta realmente cercando di realizzare obbiettivi economici. Questa dovrebbe essere tutta considerata come una manifestazione di dominio, intesa a impressionare ed a sbalordire le persone e a fare in modo che si pieghino, piuttosto che una politica nel senso normale.
Ancora una volta, in questo caso non c’è alcuno snobismo da parte mia. Quando il destino dell’economia mondiale è il gioco, una stupidità maligna nel procedimento politico è probabilmente importante quanto le politiche stesse. Come può qualcuno, che siano impresari o governi stranieri, credere a qualcosa che proviene da una amministrazione che si comporta come questa?
La prossima cosa che mi direte è che gli uomini di Trump stanno programmando azioni militari su canali insicuri e stanno accidentalmente condividendo questi piani con i giornalisti. Non c’è che aspettare [4].
Mi piacerebbe immaginare che Trump ammetta che si è incasinato, che cancelli tutta la faccenda e ricominci da capo. Ma non lo farà, perché rovinerebbe la sua manifestazione di dominio. L’ignorante irresponsabilità è parte del messaggio.
[1] James Surowiecki (1967) è un giornalista e scrittore statunitense. Fa parte dello staff del The New Yorker, in particolare cura una rubrica di affari e finanza chiamata “The Financial Page”.
[2] Purtroppo le lettere greche mi vengono assai imperfette …
[3] Ovvero, sotto l’effetto Dunning-Kruger (EDK), che è una distorsione cognitiva nella quale individui poco esperti e poco competenti in un campo tendono a sovrastimare la propria preparazione giudicandola, a torto, superiore alla media.
[4] Come è noto, l’ironia consiste nel fatto che la cosa – comunicare dettagliate iniziative militari in messaggi rivolti anche a giornalisti – è effettivamente accaduta in questi giorni.
Una nota sui deficit commerciali e sul settore manifatturiero, di Paul Krugman (dal blog di Krugman, 1 aprile 2025)
aprile 2, 2025
Apr. 1, 2025
A Note on Trade Deficits and Manufacturing
Paul Krugman
 I am supposedly on vacation in an undisclosed location, and for today I want to act like it — especially given that I’ll probably be spending a lot of time later this week reacting to the onset of full-on trade war. So this will be a relatively casual post.
I am supposedly on vacation in an undisclosed location, and for today I want to act like it — especially given that I’ll probably be spending a lot of time later this week reacting to the onset of full-on trade war. So this will be a relatively casual post.
Still, I thought it might be worth saying a bit more about why people like Maury Obstfeld, Jared Bernstein and yours truly are skeptical about the widespread narrative that the dollar’s role as a reserve currency is responsible for U.S. deindustrialization.
It’s not an argument on principle. U.S. trade deficits are surely affected by other countries’ policies, and the size of our manufacturing sector is affected by the size of our trade deficit. It is, instead, a numbers issue. Any way I cut it, the dollar’s reserve currency status is only part of the explanation of U.S. trade deficits. Even more important, trade deficits account for only a small fraction of the decline in manufacturing as a share of our economy.
On the first point: Last year China ran roughly a $1 trillion trade surplus, while the United States ran a roughly equal size trade deficit. So it may seem natural to assume that the first caused the second. But America is only about 40 percent of world GDP ex China, so why are we the sole counterpart to China’s surplus?
Many people assert that the answer is the dollar’s role as the preeminent reserve currency. But as I tried to argue, and Obstfeld explains with much more detail, this story doesn’t hold up when you look at it closely. To explain U.S. trade deficits we need to focus on reasons other than the dollar’s role, such as high productivity growth and relatively favorable demography, that foreigners invest in America.
Beyond that, how central are trade deficits to the relative decline of manufacturing? Most missives about trade and deindustrialization contain some version of this chart, showing the decline in manufacturing as a percentage of total employment:
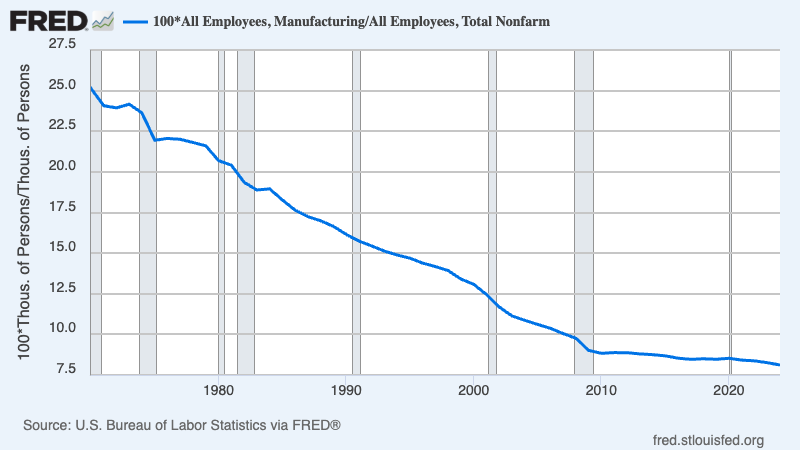
These missives then simply take it for granted that trade deficits must be responsible for the big decline in this percentage.
But trade deficits are, in fact, responsible for only a fairly small fraction of the long-run decline in the manufacturing share.
How do we know this? Two different ways: international comparisons and bottom-up number-crunching.
International comparisons: In terms of trade, Germany is the anti-America. As we have moved into trade deficit, Germany has moved into massive trade surplus. In fact, Germany’s surpluses are much larger as a share of its own GDP than China’s. Yet Germany has also seen a huge long-term decline in the manufacturing share of employment:
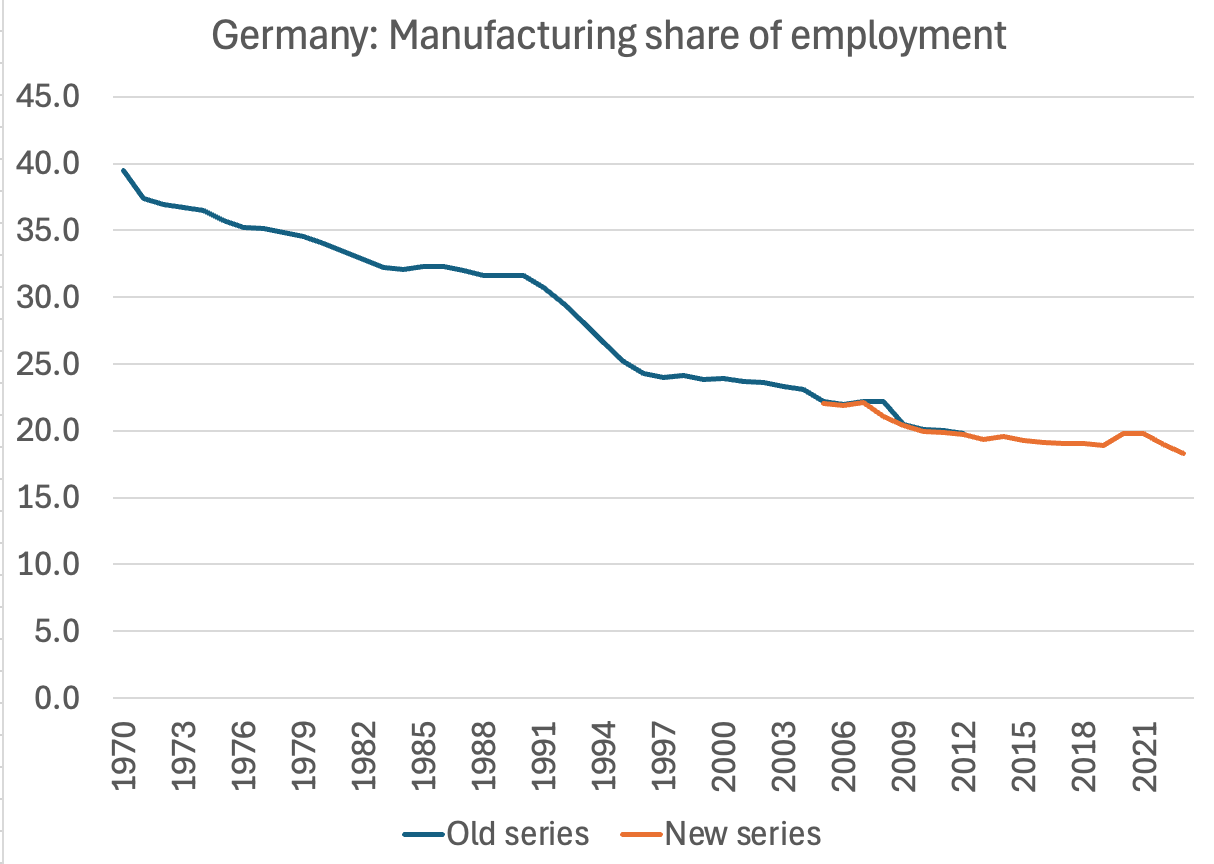
Source: FRED
(Data note: FRED offers two different series here, one that only runs up to 2012, another that starts in 2005. I’ve overlapped them, so you can see that they seem consistent.)
If Germany’s huge trade surpluses haven’t been enough to avoid a big shift away from manufacturing, even ending U.S. trade deficits (which Trump’s tariffs won’t achieve) wouldn’t make us a manufacturing-centric economy again.
Bottom-up number-crunching: Last year the U.S. ran a manufactures trade deficit of around 4 percent of GDP. Suppose we assume that this deficit subtracted an equal amount from spending on U.S. manufactured goods. In that case what would happen if we somehow eliminated that deficit?
Well, it would raise the share of manufacturing in GDP — currently 10 percent — by less than 4 percentage points, because manufacturing firms buy a lot of services. A rough estimate is that manufacturing value-added would rise by around 60 percent of the change in sales, or 2.5 percentage points, implying that the manufacturing sector would be around a quarter larger than it is.
But look at my first chart above. Manufacturing as a share of employment has fallen about 17 points since 1970. Complete elimination of the trade deficit would undo only around 2.5 points of that decline. So even if tariffs “worked,” which they won’t, they would fall far short of restoring manufacturing to its former glory.
I won’t do the full analysis right now, since as I said I’m supposed to be on vacation, but the difference between the German and U.S. shares of manufacturing in employment is roughly consistent with this calculation.
The fact is that the world needs fewer manufacturing workers than it used to, just as it no longer needs a lot of farmers, and even countries that run big surpluses in manufacturing trade can’t buck that trend. This doesn’t mean that we should abandon efforts to promote manufacturing where that makes sense. But we should do so with a realistic appreciation of the fact that we are going to be mainly a service economy no matter what, and that if we really want to help workers we have to make all jobs better, not dream of a return to an old-time economy.
Una nota sui deficit commerciali e sul settore manifatturiero,
di Paul Krugman
Si suppone che io sia in vacanza in una località segreta, e per oggi voglio comportarmi così – specialmente considerato che dovrò spendere nel seguito di questa settimana un bel po’ di tempo per reagire all’avvio della completa guerra commerciale. Dunque, questo sarà un post relativamente casuale.
Eppure, ho pensato valesse la pena di dire un po’ di più sulla ragione per la quale Maury Obstfeld, Jared Bernstein e il sottoscritto sono scettici sulla narrazione diffusa secondo la quale il ruolo del dollaro come moneta di riserva sarebbe responsabile della deindustrializzazione statunitense.
Non è un argomento di principio. I deficit commerciali statunitensi sono sicuramente influenzati dalle politiche di altri paesi, e le dimensioni del nostro settore manifatturiero sono influenzate dalla dimensione del nostro deficit commerciale. È, piuttosto, una questione di numeri. In ogni modo lo si consideri, lo status di valuta di riserva del dollaro è soltanto una parte della spiegazione dei deficit commerciali statunitensi. Ancora più importante, i deficit commerciali pesano soltanto per una piccola frazione del declino del settore manifatturiero come quota della nostra economia.
Sul primo punto: l’anno scorso la Cina ha avuto grosso modo un migliaio di miliardi di dollari di surplus commerciale, mentre gli Stati Uniti hanno avuto grosso modo una quantità uguale di deficit commerciale. Dunque può sembrare naturale considerare che il primo abbia provocato il secondo. Ma l’America è soltanto circa il 40 per cento del PIL mondiale esclusa la Cina, dunque perché saremmo l’unica controparte del surplus della Cina?
Molte persone sostengono che la risposta sia il dollaro come valuta di riserva dominante. Ma come ho cercato di sostenere, e come Obstfeld spiega con molto maggiore dettaglio, questo racconto non tiene quando osservato da vicino. Per spiegare i deficit commerciali statunitensi abbiamo bisogno di concentrarci su altre ragioni rispetto al ruolo del dollaro, come la crescita dell’alta produttività e la demografia relativamente favorevole, per le quali gli stranieri investono in America.
Oltre a ciò, quanto sono centrali i deficit commerciali nel declino reletivo del manifatturiero? La maggior parte delle comunicazioni sul commercio e sulla deinsutrializzazione contengono una qualche versione di questo diagramma, che mostra il declino del manifatturiero come percentuale della occupazione totale:
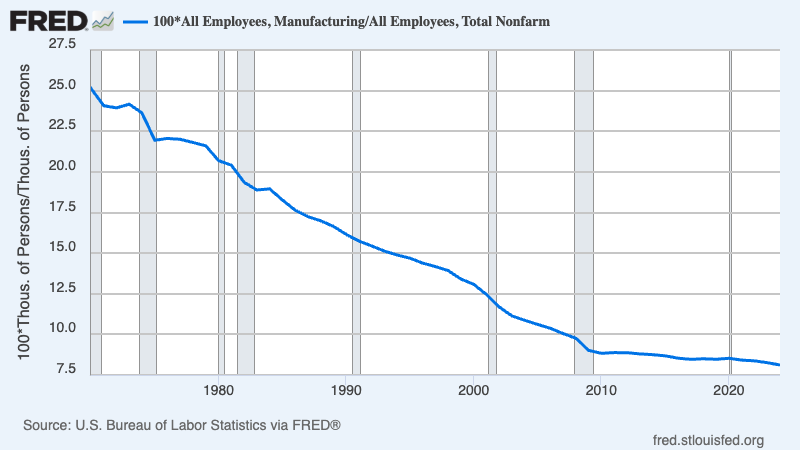
Poi queste comunicazioni semplicemente considerano come garantito che i deficit commerciali debbano essere responsabili del grande declino di questa percentuale.
Ma, di fatto, i deficit commerciali sono responsabili per una frazione abbastanza modesta del declino di lungo periodo nella quota del manifatturiero.
Come lo sappiamo? In due modi diversi: dai confronti internazionali e dalla elaborazione di numeri dal basso verso l’alto.
I confronti internazionali: in termini commerciali, la Germania è l’anti-America. Come noi ci siamo spostati verso il deficit commerciale, la Germania si è spostata verso un massiccio surplus commerciale. I surplus della Germania come quote del suo stesso PIL sono molto più ampi di quelli della Cina. Tuttavia la Germania ha conosciuto un vasto declino di lungo periodo nella quota del manifatturiero della occupazione:
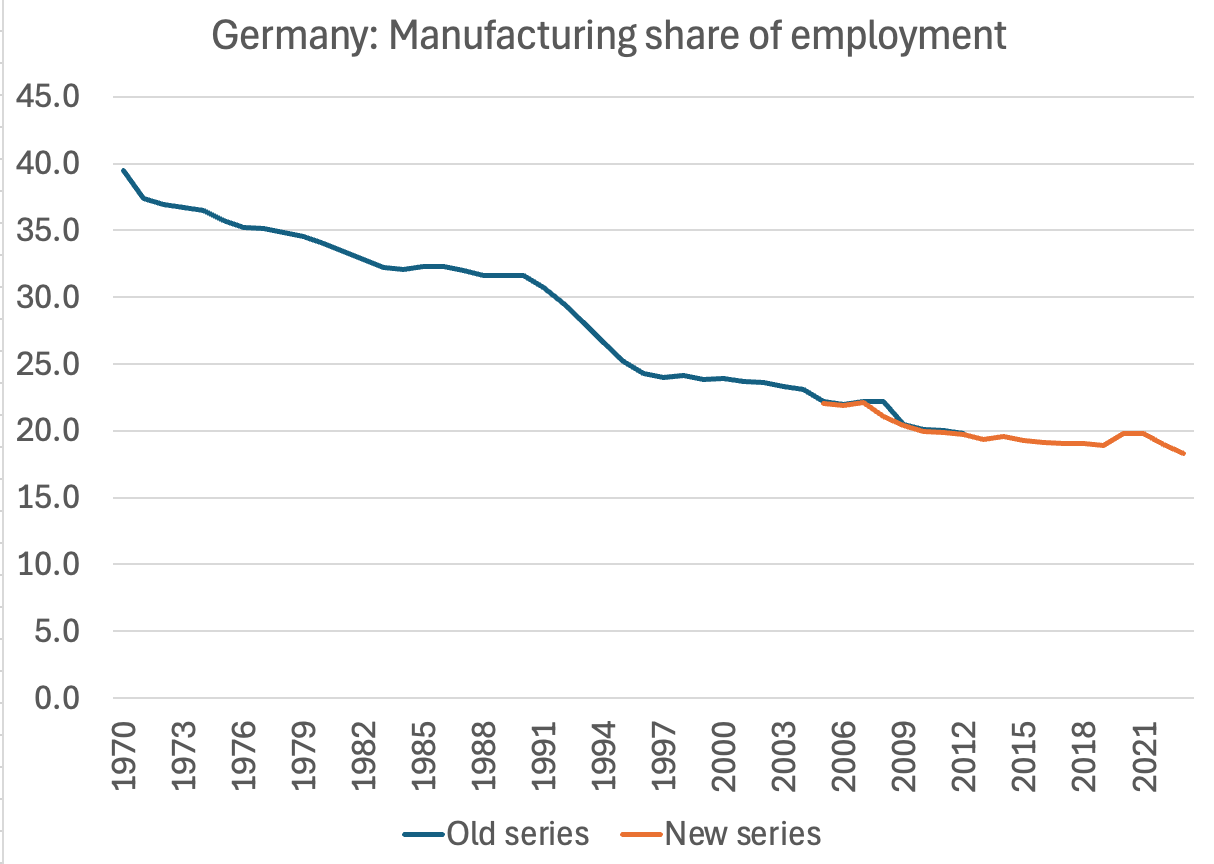
Fonte: FRED [2]
(Nota sui dati: in questo caso la FRED offre due serie di dati, uno che arriva solo al 2012, un altro che parte dal 2005. Io li ho sovrapposti, cosicché potete osservare che appaiono coerenti)
Se gli elevati surplus della Germania non sono stati sufficienti ad evitare un grande allontanamento dal manifatturiero, neanche la fine del deficit commerciali statunitensi (che le tariffe di Trump non realizzeranno) ci renderebbero nuovamente una economia manifatturiero-centrica.
La elaborazione dei numeri basso in alto: l’anno scorso gli Stati Uniti hanno avuto un deficit commerciale delle manifatture pari a circa il 4 per cento del PIL. Supponiamo di assumere che questo deficit abbia sottratto una eguale quantità di spesa sui prodotti manifatturieri statunitensi. In quel caso, cosa accadrebbe se in qualche modo eliminassimo quel deficit?
Ebbene, ciò accrescerebbe la quota del manifatturiero nel PIL – attualmente al 10 per cento – di meno di 4 punti percentuali, giacché le imprese manifatturiere acquistano una gran quantità di servizi. Una stima grossolana è che il valore aggiunto manifatturiero crescerebbe per circa il 60 per cento del cambiamento nelle vendite, ovvero di 2,5 punti percentuali, comportando che il settore manifatturiero sarebbe di un quarto più grande di quello che è.
Ma si osservi il mio primo diagramma sopra. Il manifatturiero come quota dell’occupazione è sceso di circa 17 punti dal 1970. La completa eliminazione del deficit commerciale annullerebbe soltanto 2,5 pumnti percentuali di quel declino. Dunque, persino se le tariffe “funzionassero”, il che non accadrà, esse sarebbero assolutamente insufficienti a ripristinare la passata gloria del manifatturiero.
Non farò adesso una analisi completo, dal momento che come ho detto si suppone che io sia in vacanza, ma la differenza tra le quote tedesca e statunitense del manifatturiero sull’occupazione, sono grosso modo coerenti con questo calcolo.
Il fatto è che il mondo ha bisogno di minori lavoratori manifatturieri di quanti ne aveva nel passato, proprio come non ha più bisogno di grandi quantità di coltivatori, e persino i paesi che gestiscono grandi surplus nel commercio manifatturiero non possono opporsi a questa tendenza. Questo non significa che dovremmo abbandonare gli sforzi per promuovere il manifatturiero laddove abbia senso. Ma dovremmo farlo con una considerazione realistica del fatto che ci stiamo indirizzando ad essere principalmente una economia di servizi, non importa quali, e che se vogliamo davvero aiutare i lavoratori dobbiamo rendere migliori tutti i posti di lavoro, anziché sognare il ritorno ad un’economia dei tempi andati.
[1] Il diagramma mostra l’evoluzione dal 1970 al 2024 degli occupati nel settore manifatturieri sul totale degli occupati (che sono passati dal 25 per cento a circa l’8 per cento). Si noti che sono esclusi gli occupati nell’agricoltura.
[2] Il contenuto del diagramma è identico a quello precedente: l’evoluzione, circa nello stesso periodo (1970-2021), del settore manifatturiero sulla occupazione totale. Sennonché nel 1970 il dato della Germania era al 40 per cento, contro il 25 per cento degli USA, e nel 2021 era sceso a circa il 18 per cento, contro circa l’8 per cento degli USA.
Il nostro governo sta sperimentando un rapido ‘disassemblamento’ fuori programma, di Paul Krugman (dal blog di Krugman, 17 febbraio 2025)
febbraio 21, 2025
Feb.17, 2025
Our Government Is Experiencing a Rapid Unscheduled Disassembly
Paul Krugman
 Last month SpaceX carried out a test launch of its in-development Starship rocket. Liftoff was achieved, but as the company later announced, “Starship experienced a rapid unscheduled disassembly during its ascent burn.” In other words, it exploded.
Last month SpaceX carried out a test launch of its in-development Starship rocket. Liftoff was achieved, but as the company later announced, “Starship experienced a rapid unscheduled disassembly during its ascent burn.” In other words, it exploded.
It would be wrong to think of this explosion as a disaster; new products often experience failures during testing. That is, after all, why we test them. Still, the euphemistic language reeks of unwillingness to take responsibility and admit that things didn’t go as planned. But then again, what would you expect from a company owned by Elon Musk?
And here’s the thing: If a rocket blows up, you can build a new rocket and try again. “Move fast and break things” is sometimes an OK approach if the things in question are just hardware, which can be replaced. But what if the object that experiences “rapid unscheduled disassembly” is something whose continued functioning is crucial to people’s lives — say, something like the U.S. government?
This isn’t a hypothetical question: Musk, with backing from Donald Trump, is blowing up significant parts of the U.S. government as you read this. And we can already see the shape of multiple potential disasters.
The Muskenjugend — the mostly very young people Musk has hired to work at the Department of Government Efficiency, which isn’t actually a government department in any legal sense but which Trump has effectively given huge and probably unconstitutional power to remake federal agencies — generally seem to share three characteristics.
First, they all seem to be extreme right-wing ideologues: whenever journalists investigate the social media trail of one of Musk’s operatives, what they find is horrifying. For example, Marko Elez, who had access to the Treasury Department’s central payments system, had in the recent past advocated racism and eugenics.
Second, they don’t know anything about the government agencies they’re supposedly going to make more efficient. That’s understandable. The federal government has around 2 million workers, many — I would say the vast majority — performing important public services, in a huge variety of fields. You can’t parachute into a government agency and expect to know in a matter of days which if any programs and employees are dispensable.
But the third characteristic of the Muskenjugend is that, like Musk himself, they’re arrogant. They believe that they can parachute into agencies and quickly identify what should be cut.
So last week, when the Trump administration began laying off large numbers of probationary workers, the only real questions were how quickly it would become clear that essential government functions were being compromised and just how scary the damage would be.
And the answers were that the damage became obvious almost immediately, and some of it looks very scary indeed.
A word about language: the term “probationary workers” can sound as if we’re talking about problem cases, people who’ve had poor performance reviews or something. But all it means is employees who were hired relatively recently, usually within the past year, and as a result have weaker job protection than their more senior colleagues.
So what would be your worst nightmare about large, hastily announced job cuts? Maybe firing the people responsible for keeping our nuclear weapons secure? Sure enough, on Thursday night, according to CNN’s reporting, Trump officials fired more than 300 staffers at the National Nuclear Security Administration, apparently unaware that this agency oversees America’s nukes. (Maybe the name should have been a giveaway?)
The next day, realizing the enormity of the error, the agency tried to reinstate those workers — but was having trouble getting in touch, because the terminated workers had already been locked out of their government email accounts.
Trump officials also summarily fired 3400 workers at the National Forest Service, which plays a critical role in fighting forest fires. The administration said that no firefighters were laid off, but right now — before fire season begins — is when the service should be trying to prevent fires by, among other things, clearing vegetation that can feed those fires. That work has now been hobbled, in some cases brought to a complete halt. (Remember when Trump blamed California for devastating fires, claiming that the state hadn’t raked enough leaves?)
There have been large layoffs at the Centers for Disease Control and Prevention, just as America is experiencing a serious spike in ordinary flu cases and alarm bells are ringing about a potential bird flu pandemic. Under political pressure, the CDC has been withholding reports. So we might not even know about the next pandemic until it’s well underway.
Large layoffs have struck at the Department of Health and Human Services, including, according to CBS, half the officers of the Epidemic Intelligence Service, sometimes called the “disease detectives,” who play a crucial role in identifying public health threats. There have been layoffs at the FDA, which monitors the safety of food additives and medical devices.
And according to the union, several hundred workers have been fired at the Federal Aviation Administration.
The list goes on. But peering through the details, the overall strategy is clear: Musk and his minions decided to summarily fire as many federal workers as they could without making any effort to find out what these workers do and whether it’s important.
Despite Musk’s escalating claims, these firings won’t save tens of billions of dollars. Moreover, DOGE has mandated large layoffs at the IRS — creating an open season for wealthy tax evaders which will eventually increase the budget deficit.
So what is this about? Think of it as austerity theater: suddenly getting rid of thousands of federal workers looks strong and decisive to people who don’t understand what it will do. Remember, just a few weeks ago workers all across the federal government received a mass email urging them to take a buyout offer and “move from lower productivity jobs in the public sector to higher productivity jobs in the private sector.” The new wave of layoffs probably reflects the fact that not many workers took the offer, realizing, correctly, that it was almost surely a scam.
Well, it seems all too likely that Americans are about to learn the real costs of austerity theater. Many of the suddenly laid off workers were providing essential services. Nor should we underestimate the demoralization the vindictive layoffs have created even among those workers who still have their jobs (so far.)
So when we experience our next wave of devastating forest fires, when significant numbers of Americans begin dying from preventable diseases and faulty medical devices, remember: These disasters will be partly the fault of arrogant, ignorant men who decided to smash up a reasonably functional government.
Il nostro governo sta sperimentando un rapido ‘disassemblamento’ fuori programma,
di Paul Krugman
Il mese scorso, SpaceX ha eseguito un lancio di prova del suo missile in sviluppo Starship. Il decollo è stato realizzato, ma come ha annunciato successivamente la società, “Starship ha subito un rapido non programmato disassemblamento durante la sua accensione in salita”. In altre parole, è esploso.
Sarebbe sbagliato pensare che questa esplosione sia un disastro: i nuovi prodotti spesso sperimentano fallimenti durante le prove. Quella, dopo tutto, è la ragione per la quale si fanno i test. Eppure, il linguaggio eufemistico puzza un po’ di indisponibilità a prendersi la responsabilità e ad ammettere che le cose non sono andate come programmato. Ma, d’altronde, cosa vi aspettereste da un società il cui padrone è Elon Musk?
E il punto è proprio lì: se un missile esplode, potete costruire un nuovo missile e riprovare. “Muoversi in fretta e rompere tutto” è talvolta un approccio che funziona se le cose sono soltanto materiali, che possono essere sostituite. Ma che dire se l’oggetto che sperimenta “un rapido disassemblamento fuori programma” è qualcosa il cui regolare funzionamento è cruciale per la vita delle persone – diciamo, qualcosa come il governo degli Stati Uniti?
Questa non è una domanda ipotetica: nel mentre leggete questo articolo, Musk, con il sostegno di Donald Trump, sta facendo saltare in aria parti significative del governo statunitense. E possiamo già vedere lo spettro di molteplici potenziali disastri.
I Muskenjugend – le per la maggior parte giovanissime persone che Musk ha assunto al Dipartimento dell’Efficienza del Governo, che non è effettivamente un dipartimento del governo in nessun senso legale ma al quale Trump ha di fatto conferito il vasto e probabilmente incostituzionale potere di ricostruire le agenzie federali – sembrano in generale condividere tre caratteristiche.
La prima: quei giovani sembrano essere tutti ideologicamente di estrema destra: ogni qual volta i giornalisti indagano sul percorso sui social media di uno degli addetti di Musk, quello che scoprono è terrificante. Ad esempio, Marko Elez, che ha avuto accesso al sistema centrale dei pagamenti del Dipartimento del Tesoro, aveva sostenuto nel recente passato il razzismo e l’eugenetica.
La seconda: essi ignorano tutto delle agenzie governative che si suppone stiano andando a rendere più efficienti. Ciò è comprensibile. Il governo federale ha circa due milioni di lavoratori, molti dei quali – direi la vasta maggioranza – svolgono importanti servizi pubblici, in un’ampia varietà di campi. Non vi potete paracadutare in una agenzia governativa ed aspettarvi di riconoscere nel giro di giorni quali programmi ed impiegati sono superflui.
Ma la terza caratteristica dei Muskenjugend è che, come lo stesso Musk, essi sono arroganti. Loro credono davvero di poter essere paracadutati nelle agenzie e di identificare rapidamente cosa dovrebbe essere tagliato.
La scorsa settimana, quando l’amministrazione Trump ha cominciato a licenziare ampi numeri di addetti per un periodo di prova, la uniche vere domande riguardavano in quanto tempo sarebbe diventato chiaro che funzioni essenziali di governo stavano venendo compromesse e quanto sarebbe stato allarmante il danno.
E le risposte erano che il danno diventava evidente quasi immediatamente, e una parte di quel danno era in effetti davvero allarmante.
Una parola sulle terminologia: l’espressione “lavoratori in periodo di prova” può far sembrare che stiamo parlando di casi problematici, persone che hanno avuto esami con prestazioni modeste o qualcosa del genere. Ma tutto quello che significa è che gli addetti sono stati assunti in un periodo relativamente recente, di solito nel corso dell’anno passato, ed hanno di conseguenza una più debole protezione del posto di lavoro dei loro colleghi più anziani.
Quale potrebbe essere, dunque, l’incubo peggiore sugli ampi tagli frettolosamene annunciati dei posti di lavoro? Forse licenziare le persone responsabili per mantenere in sicurezza le nostre armi nucleari? Guarda caso, secondo un resoconto della CNN, giovedì notte i dirigenti di Trump hanno licenziato più di 300 dipendenti della Amministrazione per la Sicurezza Nucleare Nazionale, in apparenza nella inconsapevolezza che l’agenzia controlla le testate nucleari dell’America (il nome non avrebbe dovuto essere un indizio?)
Il giorno successivo, comprendendo l’enormità dell’errore, l’agenzia ha cercato di riassumere quei lavoratori – ma ha avuto difficoltà a mettersi in contatto, perché i lavoratori scaduti erano già stati bloccati nella contabilità email del loro governo.
I dirigenti di Trump hanno anche sommariamente licenziato 3.400 lavoratori del Servizio Forestale Nazionale, che svolge un ruolo fondamentale nel combattere gli incendi delle foreste. L’amministrazione ha riferito che non è stato licenziato nessun vigile del fuoco, ma questo periodo – prima che inizi la stagione degli incendi – è quello in cui il servizio dovrebbe cercare di prevenire gli incendi, tra le altre cose ripulendo la vegetazione che può alimentarli. Quella attività adesso è stata impedita, in alcuni casi portata ad un completo blocco (si ricordi quando Trump diede la colpa alla California per gli incendi devastanti, sostenendo che lo Stato non aveva rastrellato abbastanza il fogliame?)
Ci sono stati ampi licenziamenti nei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), proprio mentre l’America sta sperimentando un serio picco nei casi di influenza ordinaria e stanno suonando segnali di allarme su una potenziale pandemia di influenza aviaria. Sottoposti a pressioni politiche, i CDC non stanno fornendo rapporti. Così potremmo anche non saper niente della prossima pandemia finché essa non sarà pienamente in corso.
Vasti licenziamenti hanno colpito il Dipartimento della Salute e dei Servizi alla Persona, compresa, secondo la CBS, una metà dei dirigenti del Servizio di Indagine Epidemica, talvolta chiamati “i detective delle malattie”, che giocano un ruolo cruciale nell’identificare le minacce alla salute pubblica. Ci sono stati licenziamenti alla Food and Drug Administration, che monitora la sicurezza degli additivi sugli alimenti e dei dispositivi sanitari.
E secondo il sindacato, varie centinaia di lavoratori sono stati licenziati alla Amministrazione Federale della Aviazione.
La lista non finisce qua. Ma osservando i dettagli, la strategia complessiva è chiara: Musk ed i suoi galoppini hanno deciso di licenziare sommariamente tanti lavoratori federali quanti possono, senza fare alcuno sforzo per scoprire cosa fanno questi lavoratori e se tutto ciò è importante.
Nonostante le crescenti pretese di Musk, questi licenziamenti non salveranno decine di miliardi di dollari. Per di più, il DOGE ha disposto ampi licenziamenti alla Agenzia delle Entrate – aprendo una stagione per i ricchi evasori fiscali che alla fine accrescerà il deficit di bilancio.
Dunque, cosa riguarderà tutto questo? Si può paragonare ad una rappresentazione di austerità: liberarsi all’improvviso di migliaia di lavoratori federali può apparire una misura forte e decisiva alle persone che non comprendono cosa provocherà. Si ricordi, solo poche settimane fa i lavoratori in tutto il governo federale ricevettero in massa comunicazioni che li spingevano ad accettare una proposta a “spostarsi da posti di lavoro a bassa produttività nel settore pubblico verso posti di lavoro a più alta produttività nel settore privato”. La nuova ondata di licenziamenti riflette probabilmente il fatto che non molti lavoratori aderirono all’offerta, comprendendo giustamente che essa era quasi certamente un imbroglio.
Ebbene, sembra sin troppo probabile che gli americani stiano per apprendere i costi reali dell’austerità. Molti dei lavoratori licenziati all’improvviso stavano fornendo servizi essenziali. Non dovremmo neppure sottovalutare la demoralizzazione che i licenziamenti vendicativi hanno creato anche tra quei lavoratori che hanno ancora (sino ad adesso) il loro posto di lavoro.
Dunque, quando sperimenteremo la nostra prossima ondata di incendi dei boschi, quando un numero significativo di americani comincerà a morire per malattie prevenibili e per attrezzature sanitarie difettose, si ricordi: questi disastri saranno in parte la colpa di persone arroganti e ignoranti che hanno deciso di sfasciare un governo ragionevolmente funzionale.
Come danneggiare il settore manifatturiero statunitense (persino la minaccia delle tariffe farà un gran danno). Di Paul Krugman (da paulkrugmansubstack, 28 gennaio 2025)
gennaio 29, 2025
Jan. 28, 2025
How To Damage US Manufacturing. Even the threat of tariffs will do a lot of harm
Paul Krugman
Just one day after his inauguration, Donald Trump suggested that he intended to impose 25 percent tariffs on Canada and Mexico by Feb. 1 — that is, by this coming weekend.
My sense is that financial markets discounted his statement, precisely because these tariffs would be such an obviously self-destructive move. Surely, investors probably reasoned, Trump would find some excuse for calling the tariffs off. For example, Mexico and Canada might make some vacuous statements about cracking down on drugs and migrants, and Trump would declare victory. Or maybe the tariffs would go on for a few days, then be reversed in return for some symbolic concessions.
But as I’ve been saying for a while, you shouldn’t assume that someone who understands how tariffs work has Trump’s ear, or at any rate is willing to tell him anything he doesn’t want to hear. And on Monday the Wall Street Journal reported that Trump aides want to impose tariffs first, and only then negotiate for concessions.
So it looks quite likely that Trump will indeed impose high tariffs on our neighbors a few days from now. I don’t know that this will happen, and even if he does he may find some reason to reverse the tariffs a few days later. But I don’t think people fully realize how damaging even temporary tariffs on Canada and Mexico would be.
For one thing, the North American Free Trade Agreement — which Trump renamed the U.S.-Mexico-Canada Agreement after some mostly cosmetic changes — is, in effect, a contract that everyone assumed was binding. NAFTA wasn’t a declaration of principles or intentions; it was a formal pact permanently eliminating most tariffs and other barriers to trade across our northern and southern borders.
Now a U.S. president is threatening to ignore this pact and unilaterally slap on high tariffs. In which case you have to ask, what’s the point of negotiating with the United States? What’s an agreement worth if a U.S. president can decide to ignore the agreement whenever he feels like it?
Of course, the loss of U.S. credibility extends to areas far beyond economics. In the future, what country in its right mind will trust U.S. guarantees that it will protect that nation’s security?
But back to economics: the crucial thing to understand about NAFTA is that it wasn’t really about free trade, per se. Tariffs were already low before the agreement went into effect. What NAFTA did — or what everyone thought it did — was guarantee that tariffs would stay low, thereby allowing businesses to make investments on that basis.
To help explain what NAFTA did, let me lift a few charts from a very helpful 2003 Congressional Budget Office analysis issued on the agreement’s 10th anniversary.
First: U.S. tariffs on Mexican products were very low — around 3 percent — well before NAFTA was enacted, let alone before it went into effect:
Source: CBO
Mexico, on the other hand, used to have very high tariffs. Like many developing countries, it spent several decades after World War II following a strategy of “import-substituting industrialization.” This meant trying to build a manufacturing base aimed at serving the domestic market, with tariffs and import quotas protecting domestic industry from foreign competition. By the 1980s, however, many economists and policymakers had soured on this strategy, and were looking instead at the success of South Korea and other Asian economies that pursued “outward-looking” strategies, exporting manufactured goods to the world market.
This change in economic thinking had large real-world consequences. Mexico, in particular, radically changed its economic policies, drastically reducing tariffs:
Source: CBO
It’s notable, however, that most of this tariff reduction took place before NAFTA, basically between 1985 and 1988.
I guess I should mention that while Mexico was very successful at turning itself into a manufacturing exporter, it has been far less successful at turning that achievement into rapid growth in per capita income and living standards. But the puzzle of Mexico’s disappointing growth is a topic for another day.
For now, my point is that the United States and Mexico had fairly free trade with each other, with low tariff barriers, before NAFTA went into effect at the start of 1994. So you might have expected the agreement to make little difference. In fact, however, NAFTA was followed by rapid growth in cross-border trade:
Source: CBO
Why did this happen? There’s no great secret involved. Much international trade is the result of long-term planning. To create something like the modern North American auto industry, a deeply integrated system in which various components of a finished car may be manufactured in all three countries, with parts sometimes crossing the border seven or eight times, businesses needed to make a lot of cross-border investments and carefully restructure the geography of their production.
They were only willing to make those investments and engage in that kind of long-term planning because NAFTA gave them confidence that more or less free trade in North America was a settled issue. Now, suddenly, it seems that this confidence was misplaced.
So even if Trump only imposes tariffs briefly, we can expect companies to start planning for an era in which solemn trade agreements are treated like mere suggestions, subject to revision or abrogation at the whim of whoever sits in the White House. This will lead to a gradual reduction of the geographical integration of North American industry — a gradual shift toward national self-sufficiency. And this in turn will degrade our industrial efficiency and competitiveness.
If Trump really does impose those tariffs and keeps them in place, the economic disruption will be immense. But even if he doesn’t, the United States has already suffered a damaging loss of credibility. And credibility, once lost, is hard to regain.
Come danneggiare il settore manifatturiero statunitense (persino la minaccia delle tariffe farà un gran danno).
Di Paul Krugman
Appena un giorno dopo la sua inaugurazione, Donald Trump ha affermato che intende imporre tariffe del 25 per cento sul Canada e sul Messico dal primo febbraio – ovvero, dalla prossima settimana.
La mia sensazione è che i mercati finanziari non abbiano dato credito al suo discorso, proprio perché queste tariffe sarebbero una mossa così evidentemente auto distruttiva. Probabilmente gli investitori hanno pensato che Trump avrebbe trovato qualche scusa per annullare le tariffe. Ad esempio, il Messico ed il Canada avrebbero potuto fare alcune vuote dichiarazioni sul dare un giro di vite sulle droghe e sugli emigranti, e Trump avrebbe dichiarato vittoria. Oppure le tariffe sarebbero andate avanti per pochi giorni e poi annullate in cambio di alcune concessioni simboliche.
Ma come sto dicendo da un po’, non dovreste dare per scontato che qualcuno che sa come funzionano le tariffe parli a Trump, o in ogni caso sia disponibile a dirgli qualcosa che egli non vuole ascoltare. E lunedì il Wall Street Journal ha riferito che i collaboratori di Trump intendono per prima cosa imporre le tariffe e solo in seguito negoziare per concessioni.
Dunque, pare abbastanza probabile che Trump effettivamente imporrà elevate tariffe sui nostri vicini entro pochi giorni. Non so se questo accadrà e neanche se egli potrà trovare qualche ragione per annullare le tariffe dopo pochi giorni. Ma non penso che le persone comprendano pienamente quanto sarebbero dannose persino tariffe temporanee sul Canada e sul Messico.
Da una parte, l’Accordo del Libero Commercio Nord Americano – che Trump rinominò Accordo Stati Uniti-Messico-Canada dopo alcuni cambiamenti cosmetici – è, in effetti, un contratto che tutti supponevano fosse vincolante. Il NAFTA non era una dichiarazione di princìpi o di intenzioni; era un patto formale che eliminava permanentemente le tariffe o altre barriere al commercio alle nostre frontiere settentrionali o meridionali.
Adesso un Presidente sta minacciando di ignorare questo patto e di imporre unilateralmente alte tariffe. Nel qual caso ci si deve chiede quale sia la ragione per negoziare con gli Stati Uniti? Qual è il valore di un accordo se un Presidente degli Stati Uniti può decidere di ignorare l‘accordo ogni volta che gli aggrada?
Naturalmente, la perdita di credibilità statunitense si estende ad aree che vanno ben oltre l’economia. Nel futuro, quale paese in normali condizioni mentali avrà fiducia sulle garanzie statunitensi nella protezione della sicurezza di quella nazione?
Ma torniamo all’economia: la questione cruciale da intendere sul NAFTA è che esso di per sé non riguardava realmente il libero commercio. Le tariffe erano già basse prima che l’accordo entrasse in pratica. Quello che il NAFTA fece – o che tutti pensavano che facesse – era che le tariffe sarebbero rimaste basse, di conseguenza permettendo alle imprese di fare su quella base gli investimenti.
Per contribuire a spiegare in cosa consisteva il NAFTA, consentitemi di esporre poche tabelle da una utilissima analisi del 2003, che l’Ufficio Congressuale del Bilancio (CBO) pubblicò nel decimo anniversario dell’accordo.
La prima: le tariffe sui prodotti messicani erano molto basse – circa il 3 per cento – ben prima che venisse promulgato il NAFTA, per non dire prima che esso entrasse in pratica:
Fonte: CBO
Il Messico, d’altra parte, era solito avere tariffe molto alte. Come molti paesi in via di sviluppo, esso spese vari decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale nel perseguire una strategia di “industrializzazione in sostituzione delle importazioni”. Questo comportava cercare di costruire una base manifatturiera destinata al servizio del mercato interno, con tariffe e quote di imprtazione che proteggevano l’industria nazionale dalla competizione straniera. A partire dagli anni ‘980, tuttavia, molti economisti e politici avevano preso le distanze da questa strategia, e osservavano piuttosto il successo della Corea del Sud e di altri paesi asiatici che perseguivano strategie “rivolte all’esterno”, esportando beni manifatturieri sul mercato mondiale.
Questo cambiamento nel pensiero economico ebbe ampie conseguenze nel mondo reale. In particolare il Messico cambiò le sue politiche economiche, riducendo drasticamente le tariffe:
Fonte: CBO
È tuttavia rilevante che la maggior parte di questa riduzione delle tariffe si attuò prima del NAFTA, fondamentalmente tra il 1985 ed il 1988.
Suppongo che dovrei ricordare che mentre il Messico ebbe certamente successo nel trasformarsi in un esportatore manifatturiero, esso ebbe molto minore successo nel trasformare quella realizzazione in una rapida crescita del reddito procapite e dei livelli di vita. Ma il mistero della deludente crescita del Messico è un tema che rimando ad un altro giorno.
Per adesso, il mio argomento è che gli Stati Uniti e il Messico avevano un commercio discretamente libero l’uno con l’altro, con basse barriere tariffarie, prima che il NAFTA entrasse in pratica agli inizi del 1994. Dunque, ci si sarebbe aspettati che l’accordo facesse poca differenza. Di fatto, tuttavia, il NAFTA venne seguito da una rapida crescita nel commercio transfrontaliero:
Finte: CBO
Perché accadde questo? Non c’è un particolare segreto da spiegare. Buona parte del commercio internazionale è il risultato di una pianificazione a lungo termine. Per creare qualcosa come la moderna industria automobilistica nord americana, un sistema profondamente integrato nel quale varie componenti di un veicolo finito possono essere prodotte in tutti e tre i paesi, con parti che talvolta attraversano la frontiera sette o otto volte, le imprese avevano bisogno di fare una grande quantità di investimenti transfrontalieri e di ristrutturare scrupolosamente la geografia della loro produzione.
Essi furono disponibili a fare quegli investimenti ed a impegnarsi in quel genere di programmazione a lungo termine, perché il NAFTA aveva dato loro fiducia che un commercio più o meno libero nel Nord America era una questione risolta. Adesso, all’improvviso, sembra che questa fiducia fosse mal riposta.
Dunque, se persino Trump imponesse le tariffe solo per un breve periodo, possiamo aspettarci che le società comincino a programmare per un’epoca nella quale i solenni accordi commerciali sono trattati come mere allusioni, soggette a revisione o ad abrogazione a capriccio di chiunque sieda alla Casa Bianca. Questo porterà ad una graduale riduzione dell’integrazione geografica dell’industria nord americana – un graduale spostamento verso l’autosufficienza nazionale. E questo a sua volta comporterà un degrado per la nostra efficienza industriale e competitività.
Se Trump imporrà davvero quelle tariffe e le manterrà in funzione, la turbativa economica sarà immensa. Ma anche se non lo farà, gli Stati Uniti hanno già sofferto una dannosa perdita di credibilità. E la credibilità, una volta persa, è difficile da riguadagnare.
In elogio della California, di Paul Krugman (da Krugman wonks out, 13 gennaio 2025)
gennaio 15, 2025
Jan 13, 2025
In Praise of California
 One of the unwritten rules of American politics is that it’s OK to sneer at and smear our big cities and the people who live in them, while it’s an outrageous act of disrespect to suggest that there’s anything wrong with the Heartland. And many people believe the smears; visitors to New York are often shocked to find that one of the safest places in America isn’t the hellscape they were told to expect.
One of the unwritten rules of American politics is that it’s OK to sneer at and smear our big cities and the people who live in them, while it’s an outrageous act of disrespect to suggest that there’s anything wrong with the Heartland. And many people believe the smears; visitors to New York are often shocked to find that one of the safest places in America isn’t the hellscape they were told to expect.
These delusions of dystopia are sometimes funny, but they can have real consequences. As you read this, much of America’s second-largest city is an actual hellscape. But many politicians, from the president-elect on down, are showing zero sympathy, insisting that California — which in its own way gets trash-talked as much as New York —somehow brought this disaster on itself by being too liberal, too woke, or something. And this lack of sympathy may translate into refusal to provide adequate disaster aid.
Somehow I doubt that Florida will get the same treatment when (not if) it has its next big natural disaster. (The Biden administration responded with complete, unconditional support to regions hit by Hurricane Helene and other storms, although that hasn’t stopped Republican politicians, like Governor Bill Lee of Tennessee, from lying and claiming that aid was delayed.)
At a fundamental level the case for helping California get through this is moral: Americans should help Americans in their hour of need. But this also seems like a good time to remind people just how much the Golden State contributes to American greatness.
Before I get there: Yes, California has problems, some of them big. There are pockets of social disorder, although the fact that so many luxury homes are burning tells us that many people who could live anywhere find greater Los Angeles a highly desirable place to be. More important, California suffers terribly from NIMBYism, which has led to grossly inadequate home construction, crippling housing costs and a lot of homelessness.
But California is nonetheless an economic and technological powerhouse; without it America would be a lot poorer and weaker than it is.
Most narrowly, at a time when Donald Trump is making nonsensical claims that America is subsidizing Canada via our bilateral trade deficit, California is literally subsidizing the rest of the United States, red states in particular, through the federal budget.
The Rockefeller Institute regularly calculates states’ balance of payments — the difference between the amount the federal government spends in a state and the amount the state pays in federal taxes. Here’s what per capita balances looked like in 2022, the most recent year available (blue means a state receives more than it gives, orange the reverse):
California paid in a lot more than it got back — $83 billion in total. So did Washington state and much of the Northeast. Most red states were in the reverse position, getting much more from DC than they paid in return. And yes, it’s ironic that states that are so dependent on transfers from other states — if West Virginia were a country, it would in effect be receiving foreign aid equal to more than 20 percent of its GDP — vote overwhelmingly for politicians trying to eviscerate the programs they depend on.
Even some Republicans have noticed how blue states subsidize red states — here’s a New York Republican lashing out at South Carolina.
Now, for the most part this cross-subsidization doesn’t reflect political favoritism. Remember, the federal government is an insurance company with an army, and while military spending has some regional tilt, health and retirement spending per capita across most states is roughly the same. I’m not going to redo the numbers, but here’s a chart I made a few years back, with 2016 data. It shows that the amount of federal spending per capita in a state is almost unrelated to the state’s income, but federal receipts are much higher in richer states, so rich states subsidize poorer states:
California, in particular, pays a lot in federal taxes because it’s so much richer and more productive than most of the rest of America. Here’s real GDP per capita in 2023 for selected states and groupings of states:
I included Ohio because on Friday an Ohio congressman declared that California shouldn’t receive disaster relief until it changes its forestry management (are there forests in Los Angeles?) He probably doesn’t know that Ohio is, in effect, heavily subsidized, year after year, by California.
High productivity in California (and New York, also included) plays a significant role in making America richer; the nation excluding these powerhouses would have about 6 percent lower GDP per capita.
California makes an especially large contribution to U.S. technological dominance. As I noted a month ago, 8 of America’s top 9 technology companies — all of them if you count pre-Cybertruck Tesla — are based either in Silicon Valley or in Seattle.
And while Hollywood doesn’t dominate films and TV the way it once did, Los Angeles still plays a major role in America’s cultural influence (and still generates a lot of income.)
So how should we think about the disaster in Los Angeles? As far as I can tell, there’s nothing either the city or the state could have done to prevent it. There’s a good case to be made that we should never have allowed a huge metropolitan area to emerge in a place that was vulnerable to Santa Ana-fed firestorms even before climate change vastly increased the risks. And of course we should have begun acting to limit climate change decades ago.
But this is all hindsight, with no relevance to where we are now — which is that an American city and an American state desperately need all the help we can deliver. It shouldn’t matter whether they’ve earned it. If the United States of America doesn’t take care of its own citizens, wherever they live and whatever their politics, we should drop “United” from our name. As it happens, however, California — a major driver of U.S. prosperity and power — definitely has earned the right to receive help during a crisis.
Unfortunately, it looks all too possible that essential aid will be held up or come with onerous strings attached. If so, shame on everyone responsible.
In elogio della California,
di Paul Krugman
Una delle regole non scritte della politica americana è che va tutto bene a irridere ed a infangare le nostre grandi città e le persone che ci vivono, mentre è un atto oltraggioso di mancanza di rispetto suggerire che ci sia qualcosa di sbagliato nel cuore del paese. E molte persone credono a queste calunnie: i visitatori di New York sono spesso sbigottiti dallo scoprire che uno dei luoghi più sicuri dell’America non è quel paesaggio infernale che gli era stato detto di aspettarsi.
Queste visioni di distopia sono spesso spiritose, ma possono avere conseguenze reali. Nel mentre state leggendo, la seconda più grande città dell’America è effettivamente un paesaggio infernale. Ma molti politici, dal Presidente eletto in giù, stanno mostrando una partecipazione pari a zero, insistendo che la California – che per suo conto viene descritta come spazzatura al pari di New York – in qualche modo si è procurata questo disastro da sola essendo troppo liberale, radicale, o qualcosa del genere. E questa mancanza di partecipazione può tradursi in un rifiuto a fornire un adeguato aiuto nel disastro.
In qualche modo dubito che la Florida avrà lo stesso trattamento quando (non se) avrà il suo prossimo grande disastro naturale (l’Amministrazione Biden rispose con un completo, incondizionato sostegno alle regioni colpite dall’uragano Helene o da altre tempeste, sebbene questo non abbia impedito a politici repubblicani, come il Governatore Bill Lee del Tennessee, dal dire menzogne e sostenere che quell’aiuto venne stato dato in ritardo).
Fondamentalmente, l’argomento per aiutare la California a superare la crisi è di natura morale: gli americani dovrebbero aiutare gli americani nel loro momento del bisogno. Ma questa sembra anche una buona occasione per ricordare alle persone quanto il Golden State abbia contribuito alla grandezza dell’America.
Prima di arrivare a quel punto: sì, la California ha problemi, alcuni grandi. Ci sono sacche di disordine sociale, sebbene il fatto che così tante case di lusso stiano bruciando ci dice che molte persone che potrebbero vivere altrove trovino l’area metropolitana di Los Angeles come un posto altamente desiderabile dove vivere. Più importante ancora, la California soffre di un tremendo nymbismo, che ha portato ad una clamorosamente inadeguata costruzione di abitazioni, con effetti opprimenti sul costo delle case e una gran quantità di senza tetto.
Ma ciononostante la California è una potenza economica e tecnologica; senza di essa l’America sarebbe più povera e più debole di quanto è.
In modo più ravvicinato, in un tempo nel quale Donald Trump sta avanzando pretese insensate secondo le quali l’America sta sussidiando il Canada tramite il nostro deficit commerciale bilaterale, la California sta letteralmente sussidiando il resto degli Stati Uniti, gli Stati repubblicani in particolare, attraverso il bilancio federale.
Il Rockfeller Institute calcola regolarmente le bilance dei pagamenti degli Stati – la differenza tra quanto lo Stato federale spende in uno Stato e quanto quello Stato paga di tasse federali. Ecco come apparivano i bilanci procapite nel 2022, il più recente anno disponibile (il blu mostra che uno Stato riceve più di quanto paga, l’arancione è il contrario):
La California ha pagato molto di più di quanto abbia ricevuto – 83 miliardi di dollari in totale. Altrettanto ha fatto lo Stato di Washington e buona parte del nord-est. La maggior parte degli Stati repubblicani erano nella condizione opposta, ottenendo da Washington molto di più di quello che in cambio pagavano. Ed è vero, è paradossale che gli Stati che sono così dipendenti dai trasferimenti degli altri Stati – se la Virginia Occidentale fosse un paese, essa starebbe in effetti ricevendo una aiuto estero pari a più del 20 per cento del suo PIL – votino massicciamente per politici che tentano di sventrare i programmi dai quali dipendono.
Persino alcuni repubblicani hanno notato quanto gli Stati democratici sussidino gli Stati repubblicani – ecco in questa connessione (testo inglese) un repubblicano di New York che attacca la Carolina del Sud.
Ora, per la maggior parte questo sussidio trasversale non riflette un favoritismo politico. Si ricordi che il governo federale è come una compagnia assicuratrice con un esercito, e mentre la spesa per un esercito subisce alcune inclinazioni regionali, la spesa procapite sanitaria e per le pensioni nella maggioranza degli Stati è grosso modo la stessa. Non ho intenzione di rifare i conti, ma ecco un diagramma di pochi anni orsono, con i dati del 2016. Esso mostra che la quantità della spesa procapite federale è quasi disconnessa dal reddito dello Stato, ma le ricevute fiscali sono molto più alte negli Stati più ricchi, cosicché gli Stati ricchi sussidiano quelli più poveri:
In particolare, la California paga una gran quantità di tasse federali perché è molto più ricca e molto più produttiva del resto dell’America. Ecco il PIL reale procapite nel 2023 per Stati selezionati e raggruppamenti di Stati.
Ho incluso l’Ohio perché venerdì un congressista dell’Ohio ha dichiarato che la California non dovrebbe ricevere sussidi per il disastro finché non cambia la sua gestione forestale (ci sono foreste a Los Angeles?) Lui probabilmente non sa che, anno dopo anno, l’Ohio è pesantemente sussidiato dalla California.
L’alta produttività in California (ed a New York, anch’essa inclusa) gioca un ruolo significativo nel rendere l’America più ricca; escludendo queste potenze, la nazione avrebbe circa un PIL procapite più basso del 6 per cento.
La California fornisce un contributo particolarmente grande al dominio tecnologico statunitense. Un mese fa notavo che 8 delle 9 maggiori società tecnologiche dell’America – tutte se considerate la Tesla precedente a Cybertruck – hanno base o nella Silicon Valley o a Seattle.
E se Hollywood non domina nei film e nelle TV come un tempo, Los Angeles gioca ancora un ruolo importante nell’influenza culturale americana (e genera ancora una gran quantità di reddito).
Dunque, come dovremmo ragionare sul disastro di Los Angeles? Per quanto posso dire, non c’è niente che la città o lo Stato avrebbero potuto fare per prevenirlo. Si può avanzare un buon argomento su fatto che non avremmo mai dovuto permettere che una vasta area metropolitana sorgesse in un luogo che era vulnerabile ai grandi incendi alimentati da Santa Ana, persino prima che il cambiamento climatico accrescesse grandemente i rischi. E ovviamente avremmo dovuto cominciare ad agire per limitare il cambiamento climatico decenni orsono.
Ma questo è tutto con il senno di poi, con nessuna attinenza a dove siamo oggi – ovvero ad una città americana e ad uno Stato americano che hanno disperatamente bisogno di tutto l’aiuto che possiamo fornire. Se gli Stati Uniti non si prendono cura dei loro propri cittadini, dovunque essi vivano e qualsiasi sia la loro politica, potremmo scaricare “Uniti” dal nostro nome. Si dà il caso, tuttavia, che la California – un fattore importante della prosperità e della potenza degli Stati Uniti – si sia con certezza guadagnata il diritto a ricevere aiuto durante una crisi.
Sfortunatamente, pare anche troppo possibile che un aiuto essenziale venga ritardato o arrivi con allegati onerosi vincoli. Se così fosse, la vergogna ricadrebbe su tutti i responsabili.
[1] A sinistra i primi due sono gli Stati di New York e della California; segue il dato medio degli Stati Uniti, il dato degli Stati Uniti senza New York e California e il dato dello Stato dell’Ohio. I dati sono espressi in migliaia di dollari di PIL procapite (ovvero tra più di 80 e 90 mila per gli Stati più ricchi e circa 60 mila per il resto degli Stati Uniti.
Il mio ultimo articolo: trovare speranza in un’epoca di rancore, di Paul Krugman (New York Times, 9 dicembre 2024)
dicembre 13, 2024
Dec. 9, 2024
My Last Column: Finding Hope in an Age of Resentment
By Paul Krugman
This is my final column for The New York Times, where I began publishing my opinions in January 2000. I’m retiring from The Times, not the world, so I’ll still be expressing my views in other places. But this does seem like a good occasion to reflect on what has changed over these past 25 years.
What strikes me, looking back, is how optimistic many people, both here and in much of the Western world, were back then and the extent to which that optimism has been replaced by anger and resentment. And I’m not just talking about members of the working class who feel betrayed by elites; some of the angriest, most resentful people in America right now — people who seem very likely to have a lot of influence with the incoming Trump administration — are billionaires who don’t feel sufficiently admired.
It’s hard to convey just how good most Americans were feeling in 1999 and early 2000. Polls showed a level of satisfaction with the direction of the country that looks surreal by today’s standards. My sense of what happened in the 2000 election was that many Americans took peace and prosperity for granted, so they voted for the guy who seemed as if he’d be more fun to hang out with.
In Europe, too, things seemed to be going well. In particular, the introduction of the euro in 1999 was widely hailed as a step toward closer political as well as economic integration — toward a United States of Europe, if you like. Some of us ugly Americans had misgivings, but initially they weren’t widely shared.
Of course, it wasn’t all puppies and rainbows. There was, for example, already a fair bit of proto-QAnon-type conspiracy theorizing and even instances of domestic terrorism in America during the Clinton years. There were financial crises in Asia, which some of us saw as a potential harbinger of things to come; I published a 1999 book titled “The Return of Depression Economics,” arguing that similar things could happen here; I put out a revised edition a decade later, when they did.
Still, people were feeling pretty good about the future when I began writing for this paper.
Why did this optimism curdle? As I see it, we’ve had a collapse of trust in elites: The public no longer has faith that the people running things know what they’re doing, or that we can assume that they’re being honest.
It was not always thus. Back in 2002 and ’03, those of us who argued that the case for invading Iraq was fundamentally fraudulent received a lot of pushback from people refusing to believe that an American president would do such a thing. Who would say that now?
In a different way, the financial crisis of 2008 undermined any faith the public had that governments knew how to manage economies. The euro as a currency survived the European crisis that peaked in 2012, which sent unemployment in some countries to Great Depression levels, but trust in Eurocrats — and belief in a bright European future — didn’t.
It’s not just governments that have lost the public’s trust. It’s astonishing to look back and see how much more favorably banks were viewed before the financial crisis.
And it wasn’t that long ago that technology billionaires were widely admired across the political spectrum, some achieving folk-hero status. But now they and some of their products face disillusionment and worse; Australia has even banned social media use by children under 16.
Which brings me back to my point that some of the most resentful people in America right now seem to be angry billionaires.
We’ve seen this before. After the 2008 financial crisis, which was widely (and correctly) attributed in part to financial wheeling and dealing, you might have expected the erstwhile Masters of the Universe to show a bit of contrition, maybe even gratitude at having been bailed out. What we got instead was “Obama rage,” fury at the 44th president for even suggesting that Wall Street might have been partly to blame for the disaster.
These days there has been a lot of discussion of the hard right turn of some tech billionaires, from Elon Musk on down. I’d argue that we shouldn’t overthink it, and we especially shouldn’t try to say that this is somehow the fault of politically correct liberals. Basically it comes down to the pettiness of plutocrats who used to bask in public approval and are now discovering that all the money in the world can’t buy you love.
So is there a way out of the grim place we’re in? What I believe is that while resentment can put bad people in power, in the long run it can’t keep them there. At some point the public will realize that most politicians railing against elites actually are elites in every sense that matters and start to hold them accountable for their failure to deliver on their promises. And at that point the public may be willing to listen to people who don’t try to argue from authority, don’t make false promises, but do try to tell the truth as best they can.
We may never recover the kind of faith in our leaders — belief that people in power generally tell the truth and know what they’re doing — that we used to have. Nor should we. But if we stand up to the kakistocracy — rule by the worst — that’s emerging as we speak, we may eventually find our way back to a better world.
Il mio ultimo articolo: trovare speranza in un’epoca di rancore,
di Paul Krugman
Questo è il mio articolo finale per il New York Times, dove cominciai a pubblicare le mie opinioni nel gennaio del 2000. Mi sto congedando dal Times, non dal mondo, dunque continuerò ad esprimere i miei punti di vista in altri luoghi. Ma questa sembra una buona occasione per riflettere su cosa è cambiato in questi 25 anni.
Quello che mi colpisce, guardando indietro, è come erano ottimiste molte persone, sia qua che in gran parte del mondo occidentale, e in quale misura quell’ottimismo sia stato sostituito da rabbia e da rancore. Non sto solo parlando dei membri della classe lavoratrice che si sentono traditi dalle élites; in questo momento, alcune delle persone più arrabbiate e risentite in America – persone che sembra assai probabile abbiano molta influenza nella prossima amministrazione Trump – sono miliardari che non si sentono ammirati a sufficienza.
È difficile trasmettere quanto la maggior parte degli americani fosse a suo agio nel 1999 e agli inizi del 2000. I sondaggi mostravano un livello di soddisfazione per l’indirizzo del paese che pare surreale per gli standard di oggi. La mia sensazione è che quello che accadde nelle elezioni del 2000 fu che molti americani considerarono la pace e la prosperità garantite, dunque votarono il personaggio con cui pareva ci fosse più divertimento a passare il tempo. [1]
Anche in Europa le cose sembravano andare per il meglio. In particolare, l’introduzione dell’euro nel 1999 fu ampiamente accolta come un passo verso una più stretta integrazione politica ed economica – verso gli Stati Uniti d’Europa, se preferite. Alcuni di noi, gli americani sgradevoli, avevano dei timori, ma all’inizio essi non erano ampiamente condivisi.
Naturalmente, non erano tutte rose e fiori. C’era già, ad esempio, negli anni di Clinton una discreta dose di teorie della cospirazione del genere proto-QAnon [2] e persino casi di terrorismo interno. Ci furono le crisi finanziarie in Asia, che alcuni di noi considerarono come un presagio di cose in arrivo; io pubblicai un libro dal titolo “Il ritorno delle depressioni economiche”, sostenendo che cose simili potevano avvenire anche da noi; un decennio dopo feci uscire una edizione rivista, quando ciò accadde.
Eppure, le persone sembravano sentirsi abbastanza bene quanto al futuro quando cominciai a scrivere per questo giornale.
Perché questo ottimismo si guastò? Per come la vedo io, abbiamo avuto un collasso nell’affidamento alle classi dirigenti; l’opinione pubblica non ha più fiducia che le persone che gestiscono le cose sappiano quello che stanno facendo, o che si possa dar per scontato che siano oneste.
Non è sempre stato così. Nel passato 2002 e 2003, coloro tra noi che sostennero che l’argomento per l’invasione dell’Iraq era fondamentalmente fraudolento ricevettero molta opposizione da parte di persone che rifiutavano di credere che un Presidente americano potesse fare cose simili. Chi lo sosterrebbe oggi?
In un modo diverso, la crisi finanziaria del 2008 minò ogni fiducia che l’opinione pubblica aveva sul fatto che i governi sapessero gestire le economie. L’euro come valuta sopravvisse alla crisi europea che toccò il punto massimo nel 2012, il che spedì in qualche paese la disoccupazione ai livelli della Grande Depressione, ma la fiducia negli eurocrati – e la convinzione di un luminoso futuro per l’Europa – non crollarono altrettanto.
Non si tratta solo del fatto che i governi hanno perso la fiducia dell’opinione pubblica. È stupefacente tornare indietro e constatare quanto le banche erano considerate più favorevolmente prima della crisi finanziaria.
E non era tanto tempo fa che i miliardari della tecnologia erano ampiamente ammirati in tutto l’arco dello spettro politico, alcuni ottenendo la considerazione di eroi popolari. Ma adesso sia loro che alcuni dei loro prodotti sono di fronte alla disillusione e peggio ancora; l’Australia ha persino messo a bando l’uso dei social media ai ragazzi sotto i 16 anni.
Il che mi riporta al mio argomento che alcune delle persone più risentite oggi in America sembrano essere i miliardari arrabbiati.
L’abbiamo visto già nel passato. Dopo la crisi finanziaria del 2008, che venne ampiamente (e giustamente) attribuita in parte agli intrallazzi finanziari, ci si poteva aspettare che i passati Signori dell’Universo mostrassero un po’ di contrizione, forse persino di gratitudine per essere stati tratti in salvo. Quello che avemmo fu invece la “rabbia verso Obama”, la collera verso il 44° Presidente per aver persino suggerito che Wall Street poteva in parte essere incolpata del disastro.
Questi giorni c’è stato molto dibattito per la svolta a destra di alcuni miliardari della tecnologia, da Elon Musk in giù. Io direi che non dovremmo fasciarci troppo la testa, e che specialmente non dovremmo cercar di dire che questa è in qualche modo responsabilità dei liberali del politicamente corretto. Fondamentalmente essa deriva dalla meschinità dei plutocrati che erano abituati a crogiolarsi nell’approvazione dell’opinione pubblica e adesso stanno scoprendo che tutto il denaro del mondo non può costringervi ad amarli.
C’è dunque un modo per venir fuori dalla sgradevole collocazione nella quale siamo finiti? Quello che io credo è che mentre il risentimento può portare al potere le persone sbagliate, nel lungo periodo non può mantenercele. In qualche momento l’opinione pubblica comprenderà che la maggior parte dei politici che si scagliano contro le élites, in effetti, sono le élites da ogni punto di vista significativo, e comincerà a ritenerli responsabili per il loro fallimento nel mantenere le promesse. E a quel punto l’opinione pubblica potrà essere disponibile ad ascoltare le persone che non cercano di farsi forti dell’autorità, non fanno false promesse, ma cercano di dire la verità meglio che possono.
Potremo non recuperare mai quel genere di fiducia nei nostri leader – la convinzione che le persone al potere in generale dicono la verità e sanno quello che stanno facendo – a cui eravamo abituati. Non dovremmo neanche farlo. Ma se resistiamo alla cachistocrazia – il governo dei peggiori – che sta emergendo mentre parliamo, forse alla fine torneremo ad un mondo migliore.
[1] Alle elezioni del 2000, la sfida oppose il candidato repubblicano George W. Bush e il vicepresidente democratico uscente Al Gore. In termini di voto popolare prevalse quest’ultimo, ma i voti elettorali, 271 contro 266, furono favorevoli a Bush e ne determinarono l’elezione.
[2] Teoria cospirazionista diffusa negli Stati Uniti a partire dall’ottobre 2017 sul sito web 4chan dall’utente anonimo Q (da cui per metonimia deriva la denominazione), sulla base della quale esisterebbe un deep state globalizzato, organizzato in una rete mondiale composta da celebrità di Hollywood, miliardari e politici democratici dediti alla pedofilia e al satanismo, contro cui il presidente D. Trump condurrebbe una strenua lotta per smascherarne le trame occulte e stabilire un Nuovo ordine mondiale. (Treccani)
Trump può ridurre il deficit commerciale? Di Paul Krugman (da Stone Center, 12 novembre 2024)
novembre 15, 2024
November 12, 2024
Can Trump Reduce the Trade Deficit?
By Paul Krugman
Well, we’ve had our election, and everything is about to change. It’s an understatement to say that I’m not happy about the results. But one (very small) consolation comes from an observation by my old teacher Evsey Domar: bad times can lead to interesting economic analysis.
So as we watch the international economic order (and much else) come apart, I’m going to spend some time returning to my roots and trying to figure out how trade wars and other shocks may play out. For now the Times isn’t allowing me to do a proper newsletter/blog (but watch this space), so initially I’ll be posting items here, on the Stone Center site, linking to them via social media.
First up: Trump has long been obsessed with tariffs, in large part because he believes that America’s trade deficit means that we’re a victim. Never mind all the reasons that’s a bad diagnosis: can/will Trump’s policies actually reduce the trade deficit?
Conventional wisdom among economists says no, for very good reasons. But some aspects of that conventional wisdom have been nagging at me. In what follows I’ll argue that Trumpism may indeed reduce the U.S. trade deficit, but not for reasons Trump will like. Mainly, the U.S. trade deficit is the counterpart of large capital inflows into the United States, and barriers to trade in goods also end up impeding the mobility of capital. So Trump’s policies may crater international capital flows, sharply reducing foreign investment in the United States, and the counterpart of that reduced inflow will be a smaller trade deficit.
I’ll get to that argument in due course. But first some of the conventional arguments about why tariffs won’t reduce the trade deficit.
Tariffs and trade balances: Conventional wisdom, partial equilibrium
Many discussions both of Trump’s past tariffs and of his plans for the future argue that they’ll be counterproductive using partial equilibrium analysis. If any non-economists are reading this, what I mean is that they focus only on direct effects and don’t take into account indirect macroeconomic effects of tariffs, especially their impact on the value of the dollar.
Even so, there are two big reasons to be skeptical that tariffs, even at the high rates Trump is talking about, would do much to reduce trade deficits.
First, the modern U.S. economy is deeply embedded in global value chains; manufacturing, in particular, relies heavily on imported inputs. The most conspicuous example is production of cars. There really isn’t, at this point, a U.S. auto industry; there’s a North American auto industry, in which the production process involves complex webs of suppliers spread across the United States, Mexico, and Canada. High tariffs across the board would sharply raise production costs, so that it’s quite plausible that manufacturing output and employment would actually fall.
Second, U.S. tariffs will be met with substantial retaliation and/or emulation. My guess is that the Trump people have an exaggerated sense of U.S. economic power — similar, in a way, to the exaggerated sense of U.S. military power that was so widespread before we invaded Iraq.
The truth is that there are three trading superpowers in the world today: America, China, and the European Union. The U.S. is somewhat bigger than the others in terms of dollar GDP, although our economy is smaller than China’s once you adjust for purchasing power. But nobody is dominant.
And while Europe is frustratingly unable to act collectively on many issues, the EU is a customs union in which common external tariffs are set in Brussels. So Europe will react as a unit to Trump’s tariffs — and the reaction is likely to be strong. As for China, it matched the U.S. more or less tit for tat during the first Trump trade war, and there’s every reason to believe that this will happen again.
The one thing you might say is that because America imports more than it exports, foreign tariffs on U.S. exports might not fully offset the effects of U.S. tariffs on our imports. This will, however, be cold comfort to, say, U.S. farmers, who do depend greatly on exports. And then there are those macroeconomic, general equilibrium effects.
Conventional wisdom: General equilibrium
I think it’s safe to say that most economists don’t believe that Trump’s tariffs would reduce the trade deficit even if it weren’t for retaliation and the effects on supply chains. Our skepticism comes down to a basic accounting identity:
Trade balance + Net investment income + Net capital inflows = 0
The sum of the first two terms is the current account balance, which you can think of as the trade balance broadly defined. And you can’t reduce the current account deficit unless capital inflows fall — like gravity, it’s the law. Try to squeeze the trade deficit by imposing tariffs that reduce imports, and it will be like pushing on a balloon: the deficit will just expand somewhere else.
How does this work in practice? Usually through the exchange rate. Impose tariffs on U.S. imports, and even if you assume that there isn’t effective foreign retaliation, the dollar will just rise, making U.S. exports less competitive.
This isn’t just theory. A few years ago Furceri, Hannan, Ostry and Rose (2019) did a massive study of the effects of tariffs in many countries, whose results they summarized thusly (emphasis mine below):
“We find that tariff increases lead, in the medium term, to economically and statistically significant declines in domestic output and productivity. Tariff increases also result in more unemployment, higher inequality, and real exchange rate appreciation, but only small effects on the trade balance.”
Despite this evidence, however, the proposition that Trump can’t reduce the trade deficit has, as I said, been nagging at me. Why? Because I don’t think we can take net capital inflows as given.
Tariffs and capital flows
What drives international capital flows? The textbook story is that capital flows to equalize rates of return across countries. And I do mean textbook. Figure 1 is taken from the Krugman/Wells principles textbook:
Figure 1: Textbook capital flows, from Krugman and Wells
In case you’re wondering about the countries named, we deliberately used 19th century capital flows as a motivating example rather than wade directly into modern disputes.
Now, the United States has run sustained current account deficits, the counterpart of sustained capital inflows:
Figure 2: Money incoming, from IMF
What draws that money in? If I had to give a single reason, it would be demography. Every advanced country has an aging population, with growth in the working-age population slow or even negative; but between somewhat higher fertility and immigration, the demographic slowdown has been less in the U.S. than elsewhere:
Figure 3: The U.S. demographic advantage, from OECD
Obviously this advantage will abruptly go into reverse if Trump actually carries out mass deportations; financial markets are currently betting on higher interest rates because of exploding deficits, but a shrinking labor force would cut the other way. Even Potemkin deportations, which some of my business contacts expect — a few showy roundups that don’t shut down areas like agriculture and meatpacking, which are highly dependent on undocumented immigrants — would deter future immigration. I guess we’ll see.
But my main new argument here is that a tariff-ridden world would also be a world with greatly reduced capital flows; since the U.S. trade deficit is the counterpart of large capital inflows, a global reduction in capital mobility would also squeeze our trade deficit, although it would largely do so by reducing overall investment in the U.S. economy.
The idea that barriers to trade in goods also inhibit capital movements isn’t new, although there hasn’t been a lot of research. The best writeup I’m aware of is a 2001 paper by Obstfeld and Rogoff, which uses that argument to attempt to explain a number of puzzles in international macroeconomics.
It’s a great paper, but to be honest, their formal model isn’t the most elegant thing ever. That isn’t a criticism: I’ve been trying to come up with a slicker version and haven’t succeeded so far.
But maybe I can help a bit with the intuition, starting with a reductio ad absurdum.
Imagine that there were a thriving economy with well-developed capital markets on Mars. Alas, there wouldn’t be much scope for productive trade with that economy: the costs of transporting goods back and forth would be prohibitive. But sending strings of ones and zeroes — which is basically what money is in the modern economy — wouldn’t be all that hard. So couldn’t capital flow from Earth to Mars, or vice versa?
No. Net capital flows are the counterpart of imbalances in physical trade. We can only meaningfully transfer capital to Mars if it lets the Martians buy something real from us, which they can’t. And if Earth investors somehow managed to take ownership of Martian assets, they would eventually want to convert those assets into real goods they can consume back on Earth, which they couldn’t. No trade in goods means no trade in capital.
A more, um, down to earth and less extreme story — basically the one Obstfeld and Rogoff told — goes like this:
Suppose that country A, for whatever reason, offers a higher real rate of return on investments than country B. We would then expect capital to flow from B to A. However, this capital flow must have a rise in A’s trade deficit as a counterpart. And because the doctrine of immaculate transfer is false, the inward capital flow must affect the trade balance via a real appreciation of A’s currency.
Eventually, however, the capital inflows will trail off and investors will begin repatriating their returns. When this happens, A’s real exchange rate will depreciate, cutting into the real return for B’s investors in terms of their own consumption. Anticipating this, capital inflows will fall short of the amount required to equalize real rates of return. If you like, the picture in Figure 1 is oversimplified.
Where do tariffs enter the story? The amount by which the exchange rate must appreciate to accommodate a given inflow of capital depends on how many goods are tradable. If only a small part of production can be exported and a small part of consumption imported, you’d need a very, very strong dollar to produce the kind of trade deficits America currently has. And because what goes up must eventually come down, a U.S. economy with limited trade would be unable to attract foreign investment at current rates.
Again, in my Martian example, where nothing is tradable, no level of the exchange rate can accommodate capital flows. We’re not going all the way there, but a tariff-ridden world with much less trade than we currently have would also be a world with much smaller capital flows. And because the U.S. trade deficit is the counterpart of large capital flows, a global trade war probably would reduce that deficit — not by helping U.S. firms compete with foreigners, but by largely shutting down international movements of capital.
It still seems likely that Trump will be sorely disappointed in his efforts to reduce the trade deficit. But to the extent that he succeeds, it will be for bad, economically destructive reasons: damaging the world trading system will also greatly damage international capital markets.
Trump può ridurre il deficit commerciale?
Di Paul Krugman
Ebbene, abbiamo avuto le nostre elezioni e ogni cosa sta per cambiare. Questo è un eufemismo per dire che sono tutt’altro che felice dei risultati. Ma una consolazione (assai piccina) viene da una osservazione del mio vecchio insegnante Evsey Domar: i tempi brutti possono portare a analsi economiche interessanti.
Dunque, nel mentre assistiamo all’ordine economico internazionale (ed a molto altro) che va in pezzi, ho intenzione di trascorrere un po’ di tempo tornando alle mie radici e cercando di immaginare cosa possono produrre le guerre commerciali ed altri shock. Per adesso il Times non mi permette di fare una vera e propria newsletter o blog (ma tenete d’occhio questo spazio), dunque inizialmente pubblicherò qua i miei articoli, sul sito dello Stone Center, collegandomi ad essi attraverso i social media.
Iniziamo dal primo: da lungo tempo Trump è stato ossessionato dalle tariffe, in gran parte perché egli crede che il deficit commerciale dell’America significhi che noi siamo vittime. Lasciamo perdere tutte le ragioni per le quali quella è una pessima diagnosi: le politiche di Trump possono o intendono effettivamente ridurre quel deficit commerciale?
Il punto di vista convenzionale tra gli economisti dice di no, per ottime ragioni. Ma alcuni aspetti di quella saggezza convenzionale mi sono risultati fastidiosi. In quello che segue sosterrò che il trumpismo può effettivamente ridurre il deficit commerciale statunitense, ma per ragioni che non farebbero piacere a Trump. Il deficit commerciale statunitense è principalmente in corrispondenza con ampi flussi di capitale verso gli Stati Unti, e le barriere al commercio dei prodotti finiscono anche con l’ostacolare la mobilità dei capitali. Dunque le politiche di Trump possono provocare voragini nei flussi internazionali dei capitali, riducendo bruscamente gli investimenti stranieri negli Stati Uniti, e il corrispondente di quel ridotto afflusso sarebbe un deficit commerciale minore.
Avanzerò quell’argomento a tempo debito. Ma dapprima alcuni degli argomenti convenzionali sul perché le tariffe non ridurranno il deficit commerciale.
Le tariffe e gli equilibri commerciali: la saggezza convenzionale, l’equilibrio parziale
Molti interventi sia sulla tariffe passate di Trump che sui suoi piani per il futuro sostengono che esse saranno controproducenti utilizzando l’analisi dell’equilibrio parziale. Se alcuni non-economisti stanno leggendo tutto questo, quello che io intendo è che essi si concentrano soltanto sugli effetti diretti e non mettono nel conto gli effetti macroeconomici indiretti sulle tariffe, particolarmente il loro impatto sul valore del dollaro.
Anche così, ci sono due grandi ragioni per essere scettici che le tariffe, persino con gli alti tassi di cui Trump sta parlando, farebbero molto per ridurre i deficit commerciali.
Anztutto, la moderna economia statunitense è profondamente integrata nelle catene globali del valore; la manifattura in particolare si basa pesantemente su prodotti importati. L’esempio più cospicuo è la produzione di automobili. In realtà, a questo punto non esiste una industria automobilistica statunitense; c’è un’industria dell’auto nordamericana, nella quale il processo produttivo comprende complessi intrecci di fornitori all’interno degli Stati Uniti, del Messico e del Canada. Alte tariffe su tutta la linea alzerebbero bruscamente i costi di produzione, cosicché è abbastanza plausibile che la produzione manifatturiera e l’occupazione effettivamente si ridurrebbero.
In secondo luogo, le tariffe andrebbero incontro ad una sostanziale ritorsione e/o emulazione. La mia impressione è che i collaboratori di Trump abbiano una percezione esagerata della potenza economica statunitense – simile, in un certo senso, alla impressione esagerata della potenza militare statunitense, che era così generalizzata prima che invadessimo l’Iraq.
La verità è che ci sono nel mondo odierno tre superpotenze commerciali: l’America, la Cina e l’Unione Europea. Gli Stati Uniti sono in qualche modo più grandi degli altri in termini di PIL in dollari, sebbene la nostra economia sia più piccola di quella della Cina una volta che si corregge sulla base del potere di acquisto. Ma nessuno è dominante.
E mentre l’Europa è incapace in modo frustrante ad agire collettivamente su molti aspetti, l’Unione Euroea è un’unione doganale nella quale le comuni tariffe esterne sono stabilite a Bruxelles. Dunque, l’Europa reagirà in modo unitario alle tariffe di Trump – e la reazione è probabile che sia forte. Come per la Cina, durante la prima guerra commerciale di Trump essa più o meno si mise alla pari degli Stati Uniti restituendo pan per focaccia, ci sono tutte le ragioni per credere che questo accadrà di nuovo.
L’unica cosa che si potrebbe dire è che, poiché l’America importa più di quanto esporti, le tariffe estere sulle esportazioni statunitensi potrebbero non bilanciare pienamente le tariffe statunitensi sulle nostre importazioni. Questa, tuttavia, sarà una magra consolazione, ad esempio, per gli agricoltori statunitensi, che dipendono davvero grandemente dalle esportazioni. E poi ci sono quegli effetti macroeconomici dell’equilibrio generale.
La saggezza convenzionale: l’equilibrio generale
Penso sia sicuro affermare che la maggior parte degli economisti non crede che le tariffe di Trump ridurrebbero il deficit commerciale anche se ciò non avvenisse per le ritorsioni e per gli effetti sulle catene dell’offerta. Il nostro scetticismo deriva da una identità contabile fondamentale:
Equilibrio commerciale + reddito netto degli investimenti + flussi in ingresso netti di capitale = 0
La somma dei primi due termini è l’equilibrio di conto corrente, che potete immaginarlo come la bilancia commerciale definita in senso ampio. E non potete ridurre il deficit di conto corrente senza che diminuisca il flusso in ingresso di capitale – come la gravità, la legge è quella. Provare a strizzare il deficit commerciale imponendo tariffe che riducano le importazioni, e sarà come fare pressione su un pallone: il deficit semplicemente si allargherà da qualche altra parte.
Ma come questo funziona in pratica? Normalmente attraverso il tasso di cambio. Imponete le teriffe sulle importazioni statunitensi, ed anche se ipotizzate che non ci sia alcuna ritorsione estera, il dollaro semplicemente salirà, rendendo le esportazioni statunitensi meno competitive.
Non si tratta soltanto di teoria. Pochi anni fa Furceri, Hannan, Ostry e Rose (2019) fecero uno studio imponente sugli effetti delle tariffe in molti paesi, i cui risultati sintetizzarono nel modo seguente (le sottolineature sotto sono mie):
“Scopriamo che gli aumenti dele tariffe portano, nel medio termine, a cali economicamente e statisticamente significativi nella produzione interna e nella produttività. Gli aumenti tariffari risultano anche in maggiore disoccupazione, più elevata ineguaglianza e crescita del tasso di cambio reale, ma soltanto in effetti minori sulla bilancia commerciale.”
Nonostante queste prove, tuttavia, l’affermazione che Trump non può ridurre il deficit commerciale, come ho detto, è divenuta per me un po’ asfissiante. Perché? Perché non penso che si possano assumere come dati i flussi netti di capitale.
Le tariffe ed i flussi di capitale
Cosa guida i flussi internazionali di capitale? La spiegazione dei libri di testo è che i flussi di capitale eguagliano i tassi di rendimento nei vari paesi. E intendo davvero i libri di testo. La Tabella 1 è presa dal libro di testo sui principi di Krugman/Wells:
Tabella 1: i flussi dei capitali sui libri di testo, da Krugman e Wells [1]
Nel caso vi stiate chiedendo la ragione della scelta dei due paesi, abbiam deliberatamente utilizzato come esemplificazione i flussi di capitale del 19° secolo, anziché immischiarci direttamente nelle dispute moderne.
Ora, gli Stati Uniti hanno gestito rilevanti deficit di conto corrente, che corrispondono a rilevanti flussi in ingresso di capitali:
Tabella 2: denaro in arrivo (fonte FMI)
Cosa attira il denaro? Se dovessi fornire un’unica ragione, essa sarebbe la demografia. Ogni paese avanzato ha una popolazione che invecchia, con una crescita lenta o persino negativa della popolazione in età lavorativa; ma tra una fertilità in qualche modo superiore e l’immigrazione, il rallentamento demografico è stato inferiore negli Stati Uniti che non altrove:
Tabella 3: il vantaggio demografico statunitense (fonte OCSE)
Ovviamente, questo vantaggio si rovescerà bruscamente se Trump in effetti mette in pratica deportazioni di massa; i mercati finanziari stanno attualmente scommettendo su tassi di interesse più alti per effetto di una esplosione dei deficit, ma un forza lavoro che si restringe taglierebbe l’altra strada. Persino deportazioni Potemkin [2], che alcuni dei miei contatti nel mondo delle imprese si aspettano – alcuni spettacolari raduni che non arrestano l’attività di settori come l’agricoltura e la lavorazione delle carni, che sono altamente dipendenti dagli immigrati privi di documenti – scoraggerebbero l’immigrazione futura. Suppongo che lo scopriremo.
Ma il mio principale nuovo argomento è che un mondo sconvolto dalle tariffe sarebbe anche un mondo con flussi di capitali grandemente ridotti; dal momento che il deficit commerciale statunitense è l’altra faccia di ampi flussi in ingresso di capitali, una riduzione nella mobilità del capitale ridurrebbe anche il nostro deficit commerciale, sebbene lo farebbe riducendo gli investimenti complessivi nell’economia statunitense.
L’idea che le barriere al commercio dei prodotti inibiscano anche i movimenti dei capitali non è nuova, sebbene non ci sia stata molta ricerca. La migliore letteratura di cui sono al corrente è un saggio del 2001 di Obstfeld e Rogoff, che utilizza quell’argomento per tentare di spiegare un certo numero di misteri nella macroeconomia internazionale.
È un grande saggio, ma ad essere onesti il loro modello formale non è la cosa più elegante mai vista. Questa non è una critica: io sto cercando do venirne fuori con una versione più agile e sinora non ho avuto successo.
Ma forse posso aiutarmi un po’ con l’intuizione, a cominciare da una reductio ad absurdum.
Si immagini che ci sia su Marte un’economia prospera con mercati dei capitali ben sviluppati. Purtroppo, con quell’economia non ci sarebbe molta ragione per un commercio produttivo: i costi del trasportare avanti e indietro i prodotti sarebbero proibitivi. Ma spedire sequenze di uni e di zero – che è fondamentalmente quello che il denaro rappresenta nell’economia moderna – non sarebbe affatto difficile. Non potrebbe dunque il capitale fluire nello stesso modo dalla Terra a Marte, e viceversa?
No, non potrebbe. I flussi netti di capitale corrispondono a squilibri nel commercio materiale. Ragionevolmente, noi possiamo soltanto trasferire capitale su Marte se esso permette ai marziani di acquistare da noi qualcosa di reale, il che non potrebbero fare. E se gli investitori terrestri in qualche modo cercassero di acquisire la proprietà di asset marziani, alla fine essi vorrebbero convertire quegli asset in prodotti reali che essi possono consumare sulla Terra, la qualcosa non potrebbero fare. Nessun commercio di prodotti comporta nessun commercio di capitali.
Una maggiore, diciamo così, aderenza alla Terra ed una storia meno estrema – fondamentalmente quella che hanno raccontato Obstfeld e Rogoff – sarebbe la seguente:
Supponiamo che il paese A, per una qualsiasi ragione, offra un tasso reale di rendimento sugli investimenti più alto di quello del paese B. Ci aspetteremmo che il capitale flusca da B ad A. Tuttavia, questo flusso di capitale deve avere in corrispondenza una crescita del deficit commerciale di A. E poiché la dottrina dell’immacolato trasferimento è falsa [3], il flusso del capitale in ingresso deve influenzare la bilancia commerciale attraverso una rivalutazone reale della valuta di A.
Alla fine, tuttavia, i flussi dei capitali in ingresso diminuiranno e gli investitori cominceranno a rimpatriare i loro rendimenti. Quando questo accade, il tasso di cambio reale di A si deprezzerà, incidendo sul rendimento reale degli investitori di B nei termini del loro stesso consumo. Anticipando tutto questo, i flussi di capitale si ridurranno della quantità richiesta per eguagliare i tassi di rendimento. Se volete, il quadro nella Tabella 1 lo rappresenta in modo molto semplificato.
Dove le tariffe entrano effettivamente nella storia? La quantità nella quale il tasso di cambio deve rivalutarsi per corrispondere ad un dato flusso in ingresso del capitale dipende da quanti beni sono commerciabili. Se solo una piccoa parte della produzione può essere esportata ed una piccola parte del consumo importata, si ha bisogno di un dollaro davvero molto forte per produrre il tipo di deficit ommerciale che l’America ha attualmente. E poiché ciò che sale deve alla fine scendere, un’economia statunitense con un commercio limitato sarebbe incapace di attrarre investimenti stranieri ai tassi attuali.
Tornando al mio esempio marziano, dove niente è commerciabile, nessun livello di tasso di cambio può permettere i flussi dei capitali. Noi non ci stiamo dirigendo sino a quel punto, ma un mondo tormentato dalle tariffe con molto meno commercio di quello che abbiamo attualmente sarebbe un mondo con flussi di capitali molto minori. E poiché il deficit commerciale statunitense è in corrispondenza con un ampio flusso di capitali, una guerra commerciale globale probabilmente ridurrebbe quel deficit – non aiutando le imprese statunitensi a competere con gli stranieri, ma in gran parte facendo cessare i movimenti internazionali dei capitali.
Pare probabile che Trump resterà ancora molto deluso dai suoi sforzi per ridurre il deficit commerciale. Ma nella misura in cui avrà successo, ciò avverrà per negative ragioni, economicamente distruttive: danneggiare il sistema mondiale del commercio costituirà anche un gran danno per i mercati del capitale internazionali.
[1] Un tentativo di tradurre/illustrare la tabella con un linguaggio forse più semplice.
I due riquadri mostrano gli andamenti negli Stati Uniti e in Inghilterra nel 19° secolo; sull’asse verticale il tasso di interesse, su quello orizzontale la disponibilità di fondi mutuabili; le linee colorate dovrebbero rappresentare la disponibilità di capitali – la linea rossa di S credo stia per Risparmi/Savings – e per la tendenza ad indebitarsi – la linea blu di D starebbe per Deficit. Come si vede la tendenza ad indebitarsi degli Stati Uniti resterebbe identica, ma le diverse tendenze della disponibilità dei Risparmi provocano uno spostamento delle due economie verso il punto di equilibrio internazionale del tasso di interesse, al 4% della linea punteggiata. Sennonché, questi movimenti determinano nel caso degli Stati Uniti una necessità di maggiore flusso in ingresso di capitali, rappresentato dal segmento entro la parentesi graffa nella linea dei ‘fondi mutuabili’; mentre nel caso dell’Inghilterra l’effetto sarebbe una aumento dei flussi di capitali verso l’esterno, mostrato dal segmento della seconda parentesi graffa.
[2] Ovvero, organizzate più che altro in modo da fare spettacolo. Come i villaggi di cartapesta che si dice il ministro russo Potemkin organizzava lungo i percorsi dei viaggi della regina.
[3] È il titolo di un post di Krugman del gennaio di 2011, Proprio nel gennaio del 2011 cominciai le mie traduzioni di Krugman, ma purtroppo quella in particolare non la feci. Ma il testo inglese è il seguente:
The Doctrine of Immaculate Transfer
January 12, 2011 2:55 pm January 12, 2011 2:55 pm 52
Dave Altig at the Atlanta Fed weighs in on Martin Feldstein’s much-quoted paper arguing that the United States and China will soon reduce or eliminate their current account imbalances. I think it’s worth saying a bit more about this, because there’s a common fallacy here — not one Feldstein has fallen into, but which many others do. And talking about that fallacy is also a way to see why current yuan policy is a problem for the world.
So, start with the basic accounting rule, which says that a trade deficit means that a country is spending more than it earns. What Feldstein is saying is that with US consumers starting to save more, and possibly with Chinese consumers starting to save less, these underlying imbalances may be en route to dwindling or even disappearing. Not so sure about Chinese saving, but given that premise, OK.
The fallacy comes in when you say, “Well, given that it’s all about spending imbalances, exchange rate policy has nothing to do with it.” This is what John Williamson of the Institute for International Economics once dubbed the Doctrine of Immaculate Transfer. (Uh-oh, Erick Erickson’s gonna come after me …) It’s a popular fallacy, especially at the WSJ, although I’m not sure if it rises to zombie status.
Anyway, imagine for simplicity that America and China are the only two countries in the world. And imagine that as consumer habits change, American spending falls by $400 billion while Chinese spending rises by $400 billion. Trade imbalance gone, right?
No, it’s not that easy. If US residents cut spending by $400 billion, most of that reduction — say 75 percent — will come in reduced spending on US-produced goods and services (even that Chinese pair of pajamas you buy at WalMart has a lot of US value-added in distribution and retailing.) So that’s $300 billion in reduced demand for US output. Meanwhile, a much smaller fraction — say 15 percent — of that extra Chinese spending will fall on US goods. So we’re talking about, say, a $240 billion net fall in spending on US goods and services; correspondingly, we’re talking about a $240 billion rise in demand for Chinese goods and services.
If that’s the end of the story, then the spending shift produces a depressed economy in America and major inflationary pressures in China.
What’s needed to make it come out right is something to make both American and Chinese consumers switch some of their spending toward American goods — something like a rise in the dollar value of the yuan, which makes Chinese goods relatively more expensive. So the redistribution of world spending and exchange rate adjustment are complements, not substitutes.
Now, what matters is the relative price of Chinese and American goods, so there’s another way to get there — a combination of inflation in China and deflation in America. But that’s unpleasant on both sides.
Worse, what if China tries to head off inflation by raising interest rates while America can’t reduce rates, since it’s already at the zero lower bound? Then the result is contractionary for the world as a whole.
Any resemblance between this story and actual characters is, of course, entirely intentional.
The point is that Feldstein’s argument, if correct — I’m not entirely sure about that — is actually an argument for yuan revaluation, not an argument that it won’t be necessary.
Il grande taglio del tasso della Fed non è stato politico. Dal punto di vista economico era un’ovvietà. Di Paul Krugman (dal blog di Krugman, 19 settembre 2024)
settembre 24, 2024
Sept. 19, 2024
The Fed’s Big Rate Cut Wasn’t Political. It Was an Economic No-Brainer.
By Paul Krugman
In one sense, you could say that Wednesday’s decision by the Federal Reserve to cut rates was of minimal importance. The interest rate the Fed more or less directly controls — the federal funds rate — is the rate at which banks lend one another money overnight. And it’s hard to think of any businesses or consumers who will change their plans because the annualized interest rate on one-day borrowing has fallen a half a percentage point, from around 5.5 percent to around 5 percent — which means that if you borrow $1,000, your repayment the next day falls by 1.4 cents.
Yet it was a momentous move all the same. For one thing, Fed rate changes tend to percolate into longer-term interest rates that really do matter for the economy. For example, the series of rate hikes the Fed undertook in 2022 and 2023 drove 30-year fixed mortgage interest rates up to almost 8 percent from about 3 percent.
Even more important, by beginning to cut rates, the Fed — which began raising rates in 2022 in an attempt to control surging inflation — in effect declared its belief that the war on inflation has been won.
Why should we care what the Fed thinks? Let me tell you a secret: Jerome Powell, the Fed chair, and his colleagues don’t have any inside information about the state of the economy. (OK, they might have advance warning if, say, a major bank is about to fail.) Most of their decisions are based on the same data about unemployment, inflation and so on available to anyone with an internet connection.
It’s true that the Fed has some very smart economists on its staff. But there are plenty of smart economists outside the Fed, too. The implicit declaration that inflation has been defeated won’t come as news to anyone who has, for example, been following Mark Zandi at Moody’s or Jan Hatzius at Goldman Sachs, who have been telling us for months that inflation is under control.
Yet the Fed gains some perceived gravitas from its policy role, which means that its opinion carries special weight with investors and, perhaps more important, the general public.
So it matters that the Fed is now sounding the all-clear on inflation. But this good news raises two questions.
First, if inflation is, as Powell said in his news conference, close to the Fed’s target of 2 percent, why didn’t he and his colleagues cut rates even more?
The Fed committee that sets interest rates, which meets eight times a year, normally moves those rates gradually — a quarter point at a time. The big debate before this meeting was whether this would be a standard quarter-point cut or, what we actually got, a “jumbo” half-point cut.
But instead of thinking in terms of increments, suppose we just ask what interest-rate level makes sense at this point. Inflation appears to be under control; labor markets appear to be weakening, with unemployment still fairly low but up significantly from its low point last year and hiring falling off. Overall, as Powell said in his news conference, the labor market looks a bit cooler than it was on the eve of the pandemic.
Yet the overnight rate was 1.75 percent at the end of 2019. There are some iffy arguments to the effect that we can maintain full employment at a somewhat higher interest rate now; participants in Wednesday’s committee meeting projected on average that the interest rate will settle at 2.9 percent. But I haven’t seen any plausible case for a “neutral” rate higher than 4 percent at the most. Yet despite the jumbo cut, rates are still at 5 percent. Shouldn’t the Fed be moving more quickly to normalize rates (and minimize the risk of a recession)?
Second, will the Fed’s all-clear do anything to persuade more Americans to re-evaluate President Biden’s economic record? We did experience a temporary burst of inflation in the aftermath of the Covid-19 pandemic, but so did almost every other major economy, while we have generally had much stronger growth than our peers have. And as White House economists have pointed out, our success in getting inflation back down has defied the expectations of commentators who insisted that disinflation would require a big rise in unemployment.
I know that some people aren’t satisfied with returning to low inflation; they want to see us get the level of consumer prices back to what it was before the pandemic. But we can’t, and even trying would be a really bad idea. Over the past century, only one president has presided over a significant decline in consumer prices; his name was Herbert Hoover.
Wednesday’s Fed move is, of course, good for Kamala Harris. It will give consumers some direct relief on interest costs, and it will signal that high inflation is in the rear view mirror. And having Powell say, as he did in his news conference, that the economy is in “good shape” has to be helpful for a candidate who is part of the administration presiding over that economy.
And almost too predictably, Donald Trump jumped in to suggest that the Fed might be “playing politics.”
But while the Fed’s action will surely have political consequences, it wasn’t a political decision. The straight economic case for a rate cut was overwhelming; the case for a big cut was very strong. Not cutting would have been political. And the Fed didn’t let itself be bullied into inaction.
Il grande taglio del tasso della Fed non è stato politico. Dal punto di vista economico era un’ovvietà.
Di Paul Krugman
In un senso, si potrebbe affermare che la decisione di mercoledì della Fed di tagliare i tassi sia stata di importanza minima. Il tasso di interesse che la Fed controlla più o meno direttamente – il tasso sui finanziamenti federali – è il tasso al quale le banche prestano denaro l’una all’altra da un giorno all’altro. Ed è difficile pensare che una qualsiasi impresa o consumatore cambi i propri piani perché il tasso di interesse annualizzato sull’indebitamento di un giorno è calato di mezzo punto percentuale, da circa il 5,5 per cento a circa il 5 per cento – il che comporta che se prendete in prestito 1.000 dollari, la vostra restituzione il giorno successivo cala di 1,4 centesimi.
Tuttavia, essa è stata comunque una mossa fondamentale. Da una parte, i cambiamenti della Fed tendono a scaricarsi nei tassi di interesse a più lungo termine che sono realmente importanti per l’economia. Ad esempio: le serie di rialzi dei tassi che la Fed ha intrapreso nel 2022 e nel 2023 hanno spinto i tassi di interesse fissi sui mutui trentennali a quasi l’8 per cento, da circa il 3 per cento.
Ancora più importante, cominciando a tagliare i tassi, la Fed – che iniziò ad elevare i tassi nel 2022 nel tentativo di controllare l’inflazione in crescita – in sostanza ha dichiarato il suo convincimento che la guerra sull’inflazione è stata vinta.
Perché dovremmo curarci di quello che pensa la Fed? Permettetemi di rivelarvi un segreto: Jerome Powell, il Presidente della Fed, ed i suoi colleghi non hanno alcuna informazione riservata sullo stato dell’economia (è solo vero che essi potrebbero essere avvertiti in anticipo se, ad esempio, una banca importante è prossima a fallire). La maggior parte delle loro decisioni sono basate sui dati sulla disoccupazione, sull’inflazione e via dicendo disponibili per ciascuno con una connessione internet.
È vero che la Fed ha nel suo staff alcuni economisti molto intelligenti. Ma c’è una gran quantità di economisti intelligenti anche fuori dalla Fed. L’implicita affermazione che l’inflazione è stata sconfitta non rappresenterà una novità per nessuno che, ad esempio, sia venuto seguendo Mark Zandi di Moody’s o Jan Hatzius di Goldman Sachs, che ci stavano dicendo da mesi che l’inflazione era sotto controllo.
Tuttavia la Fed detiene una dignità percepita per il suo ruolo politico, il che comporta che la sua opinione comporta un peso particolare presso gli investitori e, forse più importante ancora, presso l’opinione pubblica generale.
Dunque, è importante che adesso la Fed dia il cessato allarme sull’inflazione. Ma questa buona notizia solleva due domande.
La prima domanda, se l’inflazione, come Powell ha detto nella sua conferenza stampa, è vicina all’obbiettivo della Fed del 2%, perché lui ed i suoi colleghi non hanno tagliato i tassi anche di più?
Il comitato della Fed che stabilisce i tassi di interesse, che si riunisce otto volte all’anno, normalmente sposta quei tassi gradualmente – un quarto di punto alla volta. Il grande dibattito prima di questo incontro era se questa volta sarebbe stato un consueto taglio di un quarto di punto, oppure quello che effettivamente abbiamo avuto, una taglio “jumbo” di mezzo punto.
Ma anziché pensare in termini di incrementi, supponiamo di chiederci semplicemente quale livello del tasso di interesse abbia senso a questo punto. L’inflazione sembra essere sotto controllo; i mercati del lavoro sembra stiano indebolendosi, con la disoccupazione ancora abbastanza bassa ma significativamente in rialzo dal suo punto basso dell’anno passato e le assunzioni che si riducono. Complessivamente, come ha detto Powell nella sua conferenza stampa, il mercato del lavoro sembra un po’ più freddo di quello che era alla vigilia della pandemia.
Tuttavia il tasso di interesse overnight [1] alla fine del 2019 era l’1,75 per cento. Ci sono alcuni argomenti dubbi secondo i quali adesso possiamo mantenere la piena occupazione ad un tasso di interesse un po’ più alto; i partecipanti all’incontro del comitato di mercoledì hanno previsto che il tasso di interesse in media si collocherà sul 2,9 per cento. Ma io non ho sentito alcun plausibile argomento per un tasso di interesse “neutrale” più elevato del 4 per cento al massimo. Tuttavia, nonostante il taglio jumbo, i tassi sono ancora al 5 per cento. La Fed non dovrebbe muoversi più rapidamente per normalizzare i tassi (e minimizzare il rischio di una recessione)?
La seconda domanda: il cessato allarme della Fed avrà un qualche effetto nel persuadere più americani a rivalutare la prestazione economica del Presidente Biden? Abbiamo avuto l’esperienza di uno scoppio temporaneo di inflazione a seguito della pandemia del Covid-19, ma ciò è accaduto a quasi tutte le altre importanti economie, mentre noi in generale abbiamo avuto una crescita molto più forte delle economie simili. E come gli economisti della Casa Bianca hanno messo in evidenza, il nostro successo nel riportare in basso l’inflazione ha sfidato le aspettative dei commentatori che insistevano che la disinflazione avrebbe richiesto una grande crescita della disoccupazione.
Io so che alcune persone non sono soddisfatte per il ritorno ad una bassa inflazione; vorrebbero vedere il livello dei prezzi al consumo tornare a quello che era prima della pandemia. Ma non possiamo, e persino provarci sarebbe una pessima idea. Nel secolo passato, soltanto un Presidente governò nel corso di un significativo declino dei prezzi al consumo; il suo nome era Herbert Hoover.
La mossa della Fed di mercoledì è, ovviamente, positiva per Kamala Harris. Essa darà ai consumatori un qualche sollievo diretto sui costi degli interessi, e segnalerà che l’alta inflazione è alle nostre spalle. Inoltre, avere Powell che dice, come ha detto nella conferenza stampa, che l’economia è in una “buona forma” non può non aiutare un candidato che è parte della amministrazione che ha governato su quella economia.
Ed anche troppo prevedibilmente, Donald Trump è saltato a suggerire che la Fed potrebbe stare “facendo politica”.
Ma mentre l’iniziativa della Fed avrà sicuramente conseguenze politiche, essa non è stata una decisione politica. La diretta argomentazione economica per un taglio dei tassi era schiacciante; l’argomento per un grande taglio era molto forte. Non fare tagli sarebbe stato politico. E la Fed non ha consentito di farsi intimidire sino all’inazione.
[1] Ovvero a ‘brevissimo termine’ – o ‘nottetempo’, la durata degli scambi monetari con finalità fondamentalmente di mera sistemazione contabile, tra le banche.
Gli immigrati sono il segreto del successo economico dell’America? Di Paul Krugman (dal blog di Krugman, 19 marzo 2024)
marzo 27, 2024
March 19, 2024
Are Immigrants the Secret to America’s Economic Success?
By Paul Krugman
When we accuse a politician of dehumanizing some ethnic group, we’re usually being metaphorical. The other day, however, Donald Trump said it straight out: Some migrants are “not people, in my opinion.”
Well, in my opinion, they are people. I’d still say that even if the migrant crime wave Trump and his allies harp on were real, and not a figment of their imagination (violent crime has in fact been plummeting in many cities). And I’d say it even if there weren’t growing evidence that immigration is helping the U.S. economy — indeed, that it may be a major reason for our surprising economic success.
But as it happens, there is a lot of evidence to that effect.
Some background here: When Covid struck, there were widespread concerns that it might lead to long-term economic “scarring.” Millions of workers were laid off; how many of them would either depart the labor force permanently or lose valuable skills? Investment and new business formation fell. It seemed plausible that even after the worst of the pandemic was behind us, America would have a smaller, less productive work force than previously expected.
None of that happened. If we compare the current state of the U.S. economy with Congressional Budget Office projections made just before the pandemic, we find that real G.D.P. has risen by about a percentage point more than expected, while employment exceeds its projected level by 2.9 million workers.
How did we do that? American workers and businesses turned out to be more resilient and adaptable than they were given credit for. Also, our policymakers didn’t make the mistakes that followed the 2008 financial crisis, when an underpowered fiscal stimulus was followed by a premature turn to austerity that delayed a full recovery for many years. Instead, the Biden administration went big on spending, probably contributing to a temporary burst of inflation but also helping to ensure rapid recovery — and at this point the inflation has largely faded away while the recovery remains.
Beyond that, the very surge in immigration that has nativists so upset has played a big role in increasing the economy’s potential.
The budget office recently upgraded its medium-term economic projections, largely because it believes that increased immigration will add to the work force. It estimates that the immigration surge will add about 2 percent to real G.D.P. by 2034.
But are immigrants taking jobs away from native-born Americans? No. A recent analysis by Goldman Sachs contains this really interesting chart:
Credit…Goldman Sachs
In case you’re wondering, “SA by GS” refers to the fact that official data aren’t adjusted for seasonal fluctuations, so Goldman Sachs has done its own seasonal adjustment.
This chart shows no rise in native-born unemployment during the immigration surge. It does show a rise in foreign-born unemployment, which I’ll come back to. But for now let’s just note that there is no good evidence that immigrants are taking away jobs from workers born in America.
Still, doesn’t immigration put downward pressure on wages? That sounds as if it could be true — in particular, you might think that immigrants with relatively little formal education compete with less educated native-born workers. I used to believe this myself.
But many (although not all) academic studies find that immigration has little effect on the wages of native-born workers, even when those workers have similar education levels. Instead of being substitutes for native-born workers, immigrants often seem to complement them, bringing different skills and concentrating in different occupations.
In some ways the current immigration surge, probably consisting mainly of less educated workers (especially among the undocumented), is a test case. Have wages for lower-wage workers declined? On the contrary, what we’ve seen recently is a surprising move toward wage equality, with big gains at the bottom:
Credit…Arindrajit Dube
Overall, then, immigration appears to have been a big plus for U.S. economic growth, among other things expanding our productive capacity in a way that reduced the inflationary impact of Biden’s spending programs.
It’s also important to realize that immigration, if it continues (and if a future Trump administration doesn’t round up millions of people for deportation), will help pay for Social Security and Medicare. C.B.O. expects 91 percent of adult immigrants between 2022 and 2034 to be under 55, compared with 62 percent for the overall population. That means a substantial number of additional workers paying into the system without collecting retirement benefits for many years.
Finally, let me return to that Goldman Sachs chart on unemployment rates, which shows no rise in unemployment among the native-born but a significant rise among the foreign-born. Believe it or not, that’s probably good news.
Goldman argues that the rise in foreign-born unemployment reflects a longstanding tendency for recent immigrants to have relatively high unemployment, presumably because it takes some time for many of them to get settled into sustained employment; unemployment is much lower among immigrants who have been here three years or more.
Why is this probably good news? The overall U.S. unemployment rate has crept up recently — not enough to trigger the Sahm rule, which links rising unemployment to recessions, but enough to make me and others a bit nervous.
Goldman argues, however, that this time is different. All of the rise in unemployment is among foreign-born workers — and this, they suggest, means that we aren’t seeing the kind of weakening in demand for labor that presages recessions. What we’re seeing instead, they argue, is an increase in labor supply, with many of the new workers taking some time to find their feet. If so, the Sahm rule, which has been spectacularly successful in the past, may currently be misleading.
I hope they’re right.
The bottom line is that while America’s immigration system is dysfunctional and really needs more resources — resources it would be getting if Republicans, pushed by Trump, hadn’t turned their backs on a bill they helped devise — the recent surge in immigration has actually been good for the economy so far, and gives us reason to be more optimistic about the future.
Gli immigrati sono il segreto del successo economico dell’America?
Di Paul Krugman
Quando accusiamo un politico di disumanizzare qualche gruppo etnico, di solito intendiamo dirlo in senso metaforico. L’altro giorno, tuttavia, Donald Trump ha detto esplicitamente: alcuni emigranti “secondo me, non sono persone”.
Ebbene, secondo me, sono persone. Lo direi comunque anche se fosse vera l’ondata di crimini degli emigranti su cui Trump ed i suoi soci sproloquiano, anziché essere una prodotto della loro immaginazione (i crimini violenti stanno di fatto precipitando in molte città). E lo direi se non ci fossero prove crescenti che l’immigrazione sta aiutando l’economia statunitense – al punto che essa può essere una importante ragione del nostro sorprendente successo economico.
Ma si dà il caso che ci siano un sacco di prove a tale proposito.
Ecco un po’ di contesto: quando colpì il Covid, ci furono diffuse preoccupazioni che esso avrebbe lasciato una “cicatrice” economica a lungo termine. Milioni di lavoratori venivano licenziati; quanti di loro sarebbero usciti permanentemente dalla forza lavoro o avrebbero perso apprezzabili competenze? Gli investimenti e la formazione di nuove imprese erano in caduta. Pareva plausibile che anche dopo che il peggio della pandemia fosse alle nostre spalle, l’America avrebbe avuto minore forza lavoro produttiva di quanto ci si aspettava in precedenza.
Non è accaduto niente del genere. Se confrontiamo l’attuale condizione dell’economia statunitense con le previsioni dell’Ufficio Congressuale del Bilancio pubblicate proprio prima della pandemia, scopriamo che il PIL reale è cresciuto più di un punto percentuale di quanto ci si aspettava, mentre l’occupazione supera il suo livello previsto di 2,9 milioni di lavoratori.
Come abbiamo realizzato tutto ciò? Si è scoperto che i lavoratori e le imprese americani sono più resilienti e adattabili di quanto venivano considerati. Anche se le nostre autorità non avessero fatto gli errori che seguirono alla crisi finanziaria del 2008, quando uno stimolo inadeguato della finanza pubblica venne seguito da un prematuro spostamento all’austerità che rinviò una completa ripresa per moti anni. Invece, l’Amministrazione Biden ha messo molto impegno sulla spesa, contribuendo probabilmente ad una temporanea fiammata di inflazione ma anche contribuendo a garantire una rapida ripresa – e a questo punto l’inflazione è in larga parte svanita mentre la ripresa rimane.
Oltre a ciò, proprio l’impennata nell’immigrazione che ha talmente fatto infuriare gli xenofobi ha giocato un grande ruolo nell’accrescere il potenziale dell’economia.
L’Ufficio del bilancio ha recentemente aggiornato le sue previsioni economiche di medio termine, in gran parte perché ritiene che quella accresciuta immigrazione aumenterà la forza lavoro. Esso stima che la crescita dell’immigrazione aumenterà del 2 per cento il PIL reale entro il 2034.
Ma gli immigrati non stanno togliendo posti di lavoro ai nativi americani? No. Una recente analisi a cura di Goldman Sachs contiene questo interessante diagramma:
Fonte: Goldman Sachs [1]
Nel caso ve lo stiate chiedendo, “SA by GS” (“correzione stagionale a cura di Goldman Sachs”) si riferisce al fatto che i dati ufficiali non sono corretti per le fluttuazioni stagionali, dunque Goldman Sachs lo ha fatto per conto proprio.
Questo diagramma non mostra alcuna crescita della disoccupazione tra i nativi americani durante l’impennata dell’immigrazione. Esso in effetti mostra una crescita della disoccupazione tra i nati all’estero, sulla quale tornerò. Ma per adesso ci sia permesso solo di osservare che non c’è alcuna buona prova che gli immigrati stiano togliendo posti di lavoro ai lavoratori nati in America.
Ma l’immigrazione non esercita una spinta verso il basso sui salari? Questo sembra poter esser vero – in particolare, si potrebbe pensare che gli immigrati con una istruzione formale relativamente piccola competano con i lavoratori nati in America meno istruiti. Anch’io ero solito crederlo.
Ma molti studi accademici (sebbene non tutti) scoprono che l’immigrazione ha poco effetto su salari dei nativi americani, anche quando quelli hanno livelli di istruzione simili. Anziché essere sostitutivi dei lavoratori nativi, gli immigrati sembrano spesso complementari, portando diverse competenze e concentrandosi in diverse occupazioni.
In alcuni sensi l’attuale impennata dell’immigrazione, consistendo probabilmente soprattutto di lavoratori meno istruiti (particolarmente tra quelli sprovvisti di documenti), è un banco di prova. Sono diminuiti i salari tra i lavoratori con paghe più basse? Al contrario, quello che abbiamo osservato di recente è un sorprendente spostamento verso l’eguaglianza salariale, con grandi miglioramenti nei settori più poveri:
Fonte: Arindrajit Dube [2]
Nel complesso, inoltre, l’immigrazione sembra essere stata un gran vantaggio per la crescita economica statunitense, ampliando tra le altre cose la nostra capacità produttiva in un modo che ha ridotto l’impatto inflazionistico dei programmi di spesa di Biden.
È anche importante comprendere che l’immigrazione, se continua (e se una futura Amministrazione Trump non raccoglierà milioni di persone per la deportazione), contribuirà a finanziare la Previdenza Sociale e Medicare. L’Ufficio Congressuale del Bilancio si aspetta che il 91 per cento degli immigrati adulti tra il 2022 ed il 2034 siano sotto i 55 anni, a confronto con il 62 per cento nella popolazione complessiva. Questo comporta un numero sostanziale di lavoratori aggiuntivi che versano contributi nel sistema senza ricevere sussidi pensionistici per molti anni.
Infine, fatemi tornare a quel diagramma di Goldman Sachs sui tassi di disoccupazione, che non mostra alcuna crescita della disoccupazione tra i nativi ma una significativa crescita tra i nati all’estero. Lo si creda o meno, questa è probabilmente una buona notizia.
Goldman sostiene che la crescita della disoccupazione tra i nati all’estero riflette una tendenza di lungo periodo per gli immigrati recenti ad avere una disoccupazione relativamente elevata, presumibilmente perché ci vuole un po’ di tempo perché molti di loro vengano sistemati in una occupazione duratura; la disoccupazione è molto più bassa tra gli immigrati che sono nel paesi da tre anni o più.
Perché questa è probabilmente una buona notizia? Il tasso di disoccupazione complessivo statunitense è cresciuto recentemente – non abbastanza da innescare la regola di Sahm [3], che stabilisce un collegamento tra disoccupazione in crescita e recessioni, ma sufficiente a rendere nervosi il sottoscritto ed altri.
Goldman sostiene, tuttavia, che questa volte le cose sono diverse. Tutta la crescita della disoccupazione si osserva tra i lavoratori nati all’estero – e questo, loro suggeriscono, comporta che non stiamo assistendo a quel genere di indebolimento della domanda per il lavoro che fa presagire recessioni. Stiamo assistendo invece ad un aumento dell’offerta di lavoro, con molti dei nuovi lavoratori ai quali occorre un po’ di tempo per riuscire ad integrarsi. Se così fosse, la regola di Sahm, che nel passato ha funzionato in modo spettacolare, attualmente potrebbe essere fuorviante.
Mi auguro che abbiano ragione.
La morale della favola è che mentre il sistema americano dell’immigrazione è disfunzionale ed ha realmente bisogno di maggiori risorse – risorse che si sarebbero ottenute se i repubblicani, spinti da Trump, non avessero voltato le spalle ad una proposta di legge che essi stessi avevano contribuito a concepire – la recente impennata dell’immigrazione è stata sinora effettivamente positiva per l’economia, e ci dà ragioni per essere più ottimisti sul futuro.
[1] Il diagramma indica con la linea blu scura il tasso di disoccupazione tra i lavoratori americani di nascita, e in linea celeste quello tra i lavoratori nati all’estero. Nell’ultimo anno la percentuale di disoccupati tra questi ultimi è aumentata di circa un punto e mezzo, mentre tra i primi è leggermente calata.
[2] La tabella distingue cinque comparti dei salariati americani, dai più poveri alla sinistra sino ai più ricchi all’estrema destra e mostra i cambiamenti nei salari reali nel periodo tra il dicembre 2019 ed il dicembre 2023. Come si vede i compensi dei più poveri sono aumentati del 9 per cento – il dato è al netto dell’inflazione e probabilmente è stato determinato dai contributi finanziari del Governo durante la pandemia – mentre per i ricchissimi sono diminuiti.
Si tenga conto che i salariati molto ricchi effettivamente esistono, per varie ragioni che sono spiegate dal fenomeno della cosiddetta “omoplutia” – analizzato in particolare da Branko Milanovic nel libro “Capitalismo contro capitalismo”. Per omoplutia (da homós «uguale», e ploûtos «ricchezza») si intende il fatto che, in particolare negli Stati Uniti, le persone più ricche non si distinguono solo per i maggiori possessi di capitale, ma anche dei compensi salariali.
Gli aiuti finanziari nella pandemia, essendosi espressi con “assegni” governativi diretti ed eguali ai beneficiari di salari, evidentemente hanno comportato in termini percentuali un maggiore aiuto al quintile più povero che non al quintile più ricco.
[3] Il principio fondamentale della regola di Sahm è che un aumento di almeno 0,5 punti percentuali nel tasso di disoccupazione rispetto al minimo degli ultimi 12 mesi indica la probabilità di una recessione imminente.
La cosiddetta ‘regola’ è una teoria economica formulata da Claudia Sahm, una economista statunitense, che ha cercato di identificare un indicatore semplice e efficace per prevedere l’arrivo di recessioni economiche negli Stati Uniti. Secondo questa regola, il tasso di disoccupazione è un indicatore chiave per anticipare l’inizio di un periodo recessivo.
Credere è come vedere, di Paul Krugman (dal blog di Krugman, 20 febbraio 2024)
febbraio 24, 2024
Feb. 20, 2024
Believing Is Seeing
By Paul Krugman
What was most startling about Tucker Carlson’s recent trip to Russia wasn’t his obsequious interview with Vladimir Putin but his gushing days afterward over how wonderful a place Moscow is. But then again, he was a special guest of the country that invented Potemkin villages (even if the original story is dubious), and making sure he saw only good stuff must have been easy.
Imagine, for example, that you brought people to New York and made sure that all they saw was the Upper East Side near the Metropolitan Museum of Art. They’d come away with the impression that New York is a very clean, spiffy-looking city.
The truth is that while parts of Moscow offer a small elite an opulent lifestyle, Russia as a whole is more than a bit ramshackle. Around a fifth of homes don’t even have indoor toilets. For many Russians, life is poor, nasty, brutish and short: Life expectancy is substantially lower than in the United States, even though America’s life expectancy has fallen and lags that of other advanced countries.
Anyway, while praising Moscow, Carlson trashed American cities, especially New York, where, he said, “you can’t use your subway” because “it’s too dangerous.” No doubt, there are some New Yorkers afraid to take the subway. Somehow, however, there were around 1.7 billion riders each year before the pandemic — yes, I take the subway all the time — and ridership, though still depressed by the rise of working from home, has been recovering rapidly.
It’s possible, of course, that Carlson has never ridden the New York subway, or at least not since the days when New York had about six times as many homicides each year as it does nowadays. In this he might be like Donald Trump, who probably hasn’t flown commercial in decades, declaring the other day that America’s airports — which have annoyingly long lines at security but have far more amenities than they used to — make us look like a “third world nation.”
Oh, and while New York’s subway stations don’t have chandeliers like Moscow’s and sometimes do have rats, the system does its job and, as I’ve written, plays a hugely positive role in the life of the city.
But right-wingers seem immovable in their conviction that New York is an urban hellscape — only 22 percent of Republicans consider it a safe place to live in or visit — despite the fact that it’s one of the safest cities in America.
More generally, there’s a striking disconnect between Americans’ perceptions about crime where they live — relatively few, from either party, consider it a serious problem — and their much more pessimistic assessment of the nation as a whole. This disconnect exists for both parties but is much wider for Republicans:
Credit…Gallup
This is part of a broader phenomenon. America has become a country in which, for many people, especially but not only on the political right, believing is seeing. Perceptions on issues from immigration to crime to the state of the economy are driven by political positions rather than the other way around.
To take a subject I’ve obviously spent a lot of time on: During the Biden years, most measures of consumer sentiment have been much lower than you might have expected, given standard measures of the economy’s performance. This is still true, even though sentiment has risen substantially over the past few months. There’s practically a whole genre of analysis devoted to arguing that people are actually right to feel bad about the economy because of something or other.
So here’s a pro tip: Ignore anyone who says that Americans are down on the economy without noting that the reality is that Republicans are down on the economy.
I wrote about this last week, but let me make the point again using slightly different data and graphics. The widely cited Michigan survey of consumers provides data on sentiment broken down by partisan affiliation, although it has been a regular monthly feature only since 2017. I prefer to focus on the current economic conditions index, since people might legitimately have different expectations, depending on who’s in charge. So here’s what this index looks like, using three-month moving averages to cancel some of the statistical noise:
Credit…University of Michigan
Democrats appear to feel that the economy now is about as good as it was in late 2019, which is what you might expect, given that the unemployment rate is about the same and inflation only slightly higher. Republicans, however, have gone from euphoria about the economy under Donald Trump to a very jaundiced view under President Biden.
What about independents? Never mind: For the most part, they lean toward one party or the other and behave like partisans.
Now, this comparison doesn’t prove that negative perceptions of the economy are all about partisanship — maybe things really are somewhat bad and Democratic partisanship is holding the numbers up — although Democrats don’t seem to experience the kind of mood swings when the White House changes hands that Republicans do. But at the very least, any discussion of economic sentiment that doesn’t take partisanship into account is missing a key part of the story.
As I wrote last week, the believing-is-seeing nature of public opinion may mean that perceptions of the economy, and perhaps crime, won’t matter very much for this year’s election: Americans who believe that things are terrible probably wouldn’t have voted Democratic, no matter what. But to take a longer view: How are we going to function as a country when large numbers of people just see a different reality from the rest of us?
Credere è come vedere,
di Paul Krugman
Quello che è stato più stupefacente nel recente viaggio di Tucker Carlson in Russia non è stata la sua ossequiosa intervista con Vladimir Putin ma le sue giornate successive inondate di complimenti su quanto Mosca sia un luogo meraviglioso. D’altra parte, egli era un ospite speciale di un paese che inventò i ‘villaggi Potemkin’ (anche se la storia originale è dubbia), e fare in modo che egli vedesse solo cose belle doveva esser facile.
Si immagini, ad esempio, di aver portato delle persone a New York e fatto in modo che tutto quello che vedevano fosse l’Upper East Side vicino al Museo dell’Arte Metropolitana. Esse se ne andrebbero con l’impressione che New York sia una città pulitissima e favolosa.
La verità è che mentre parti di Mosca offrono ad una piccola elite un opulento stile di vita, la Russia nel suo complesso è peggio che un po’ sgangherata. Circa un quinto delle abitazioni non hanno neanche i servizi igienici all’interno. Per molti russi, la vita è povera, sgradevole, rozza e breve: l’aspettativa di vita è sostanzialmente più bassa [1] che negli Stati Uniti, anche se l’aspettativa di vita dell’America è caduta e non tiene il passo con gli altri paesi avanzati.
In ogni modo, mentre elogia Mosca, Carlson riduce a spazzatura le città americane, particolarmente New York, per la quale egli dice: “non potete usare la vostra metropolitana” perché “è troppo pericolosa” Non c’è dubbio che ci sono alcuni newyorchesi che hanno paura di prendere la metropolitana. In un modo o nell’altro, tuttavia, ogni anno prima della pandemia circolavano circa 1,7 miliardi di viaggiatori – sì, io prendo sempre la metropolitana – e l’utenza, sebbene tuttora depressa dalla crescita del lavoro da casa, si sta riprendendo rapidamente.
È possibile, naturalmente, che Carlson non abbia mai viaggiato nella metropolitana di New York, almeno non dai giorni nel quali New York aveva ogni anno sei volte gli omicidi che ha oggi. In questo somiglierebbe a Donald Trump, che probabilmente non ha usato voli di linea da decenni, che l’altro giorno ha dichiarato che gli aeroporti americani – che hanno file fastidiosamente lunghe alla sicurezza ma hanno un comfort assai maggiore di quello che avevano un tempo – ci fanno assomigliare ad “una nazione del terzo mondo”.
Inoltre, mentre le stazioni della metropolitana di New York non hanno lampadari come quelle di Mosca e talvolta abbiano i topi, il sistema assolve al suo compito e, come ho scritto, gioca un ruolo altamente positivo nella vita della città.
Ma i personaggi della destra paiono inamovibili nella loro convinzione che New York sia un inferno urbano – solo il 22 per cento dei repubblicani lo considera un posto sicuro da vivere o da visitare – nonostante il fatto che essa sia una delle città più sicure in America.
Più in generale, c’è una impressionante disconnessione tra le percezioni degli americani sui crimini dove essi vivono – relativamente in pochi, in ambedue i partiti, lo considerano un problema grave – e il loro giudizio molto più pessimistico sulla nazione nel suo complesso. Questa disconnessione esiste per entrambi i partiti, ma è molto più ampia per i repubblicani:
Fonte: Gallup
Questo è un aspetto di un fenomeno più generale. L’America è diventata un paese nel quale, per molte persone, particolarmente ma non soltanto della destra politica, credere è come vedere. Le percezioni sui temi dall’immigrazione al crimine allo stato dell’economia sono guidate dalle posizioni politiche piuttosto che a partire da quello che si osserva.
Per prendere un tema sul quale come è noto ho passato un bel po’ di tempo: durante gli anni di Biden la maggior parte delle misurazioni sulle impressioni dei consumatori sono state molto più basse di quanto ci si poteva aspettare, considerate le misurazioni più comuni delle prestazioni dell’economia. Questo è ancora vero, anche se le impressioni sono sostanzialmente migliorate negli ultimi mesi. C’è praticamente un intero genere di analisi rivolte a sostenere che le persone hanno in effetti ragione ad avere impressioni negative sull’economia, per una ragione o per l’altra.
Ecco dunque un suggerimento: ignorate chiunque affermi che gli americani sono depressi sull’economia senza osservare che in realtà sono i repubblicani ad essere depressi sull’economia.
Ho scritto su questo la settimana scorsa, ma consentitemi di avanzare ancora l’argomento usando dati e grafici leggermente differenti. L’ampiamente citato Sondaggio Michigan sui consumatori fornisce dati sulle impressioni scomposti per la appartenenza partitica, per quanto questa sia stata una regolare caratteristica mensile soltanto a partire dal 2017. Io preferisco concentrarmi sull’indice delle condizioni economiche attuali, dato che le persone potrebbero legittimamente avere diverse aspettative, a secondo di chi è in carica. Dunque, ecco cosa mostra questo indice, utilizzando le serie medie trimestrali per cancellare alcune delle anomalie statistiche:
[2] Fonte: Università del Michigan
I democratici sembrano percepire che l’economia sia adesso all’incirca altrettanto positiva di quello che era alla fine del 2019, che è quanto vi aspettereste, considerato che il tasso di disoccupazione è quasi lo stesso e l’inflazione è solo leggermente superiore. Tuttavia, i repubblicani sono passati dall’euforia sull’economia sotto Donald Trump ad un punto di vista molto incattivito sotto il Presidente Biden.
Che dire degli indipendenti? Non contano: per la maggior parte essi inclinano verso un partito o l’altro e si comportano come gli appartenenti ai partiti.
Ora, questo confronto non prova che le percezioni negative sull’economia riguardino tutte la preferenza verso un partito – le cose potrebbero essere realmente in qualche modo negative e la faziosità dei democratici terrebbe i dati in alto – per quanto i democratici non sembrano conoscere quel genere di oscillazione dell’umore quando la Casa Bianca cambia il titolare che hanno i repubblicani. Ma alla fin fine, ogni discussione sulle percezioni economiche che non metta nel conto la faziosità si perde una parte fondamentale della storia.
Come ho scritto la settimana scorsa, la natura del “credere è come vedere” dell’opinione pubblica può comportare che le percezioni sull’economia, e forse sul crimine, non siano molto importanti per le elezioni di quest’anno: gli americani che credono che le cose siano terribili probabilmente non avrebbero votato per i repubblicani, a prescindere. Ma per assumere una prospettiva a più lungo termine: come siamo destinati a funzionare come nazione se un gran numero di persone precisamente vede una realtà diversa dal resto di noi?
[1] Per chi ne avesse maggiore curiosità, un mio Fact-checking:
Da “Lancet” si apprende che: “il quadro della salute della popolazione russa è molto preoccupante: la speranza di vita alla nascita è di 64 anni per gli uomini – il dato più basso tra tutti i paesi europei, 11 anni in meno rispetto alla media dei paesi UE – e 75 per le donne. [Ma …] nel 1988 la speranza di vita degli uomini russi era di 65 anni: a seguito del collasso dell’Unione Sovietica in pochi anni la longevità di questa popolazione si ridusse di ben 7 anni”. Ovvero, il colpo peggiore alla aspettativa di vita venne dalla grande crisi economica successiva al crollo del comunismo.
Inoltre: “in Russia anche le malattie infettive rivestono un ruolo importante nella mortalità, specialmente la TBC, il cui tasso d’incidenza è aumentato moltissimo dopo la caduta dell’Unione Sovietica (da 33 casi su 100.000 abitanti degli anni ’80 agli oltre 90 casi su 100.000 del 2012”.
Nel frattempo, il calo impressionante dell’aspettativa di vita negli Stati Uniti negli ultimi anni si legge nel seguente tabella (con i maschi in verde, le femmine in blu e i dati totali in celeste).
Quindi: in Russia l’aspettativa di vita per i maschi è oggi, dopo quel tracollo, 64 anni; per le femmine è 75 anni. Negli Stati Uniti è scesa a 78 anni per le donne e a 73 anni per gli uomini. In Europa, nel 2021, l’aspettativa di vita era 80,1 anni; 82,9 per le donne, 77,2 per gli uomini. Interessante che la differenza tra uomini e donne – il tasso di mortalità maggiore per i primi che non per le seconde – sia di cinque anni negli Stati Uniti ed in Europa, e di circa dieci anni in Russia.
Sia in Russia che negli Stati Uniti un peso abnorme delle morti deriva dalle malattie cardiovascolari (soprattutto fumo in un caso e obesità nell’altro), da dipendenze (soprattutto da alcool nel primo caso, anche da farmaci e droghe nel secondo), da morti violente (da suicidi, da omicidi e da incidenti stradali).
[2] I dati nella linea blu indicano le risposte degli intervistati democratici, quelli nella linea rossa le risposte dei repubblicani. Le misurazioni sull’asse verticale non è spiegato a cosa si riferiscano, ma indicano chiaramente dal livello 0 a quello 140 i limiti estremi del pessimismo e dell’ottimismo nei giudizi.
Cosa riguardò la Guerra Civile, di Paul Krugman (dal blog di Krugman, 2 gennaio 2024)
gennaio 8, 2024
Jan. 2, 2024
What the Civil War Was About
By Paul Krugman
Of course the Civil War was about slavery, and everyone knew it at the time. No, Nikki Haley, it wasn’t about states’ rights, except to the extent that Southern states were trying to force Northern states to help maintain slavery — something that, as I’ll explain in a bit, has echoes in the current fight over abortion rights.
So Haley deserves all the condemnation she received for initially refusing to acknowledge the obvious in a campaign stop last week.
But it may be worth delving a bit deeper into the background here. Why did slavery exist in the first place? Why was it confined to only part of the United States? And why were slaveholders willing to start a war to defend the institution, even though abolitionism was still a fairly small movement and they faced no imminent risk of losing their chattels?
Let me start with an assertion that may be controversial: The American system of chattel slavery wasn’t motivated primarily by racism, but by greed. Slaveholders were racists, and they used racism both to justify their behavior and to make the enslavement of millions more sustainable, but it was the money and the inhumane greed that drove the racist system.
Back in 1970, the M.I.T. economist Evsey Domar published a classic paper titled “The Causes of Slavery or Serfdom: A Hypothesis,” which started with a historical observation that probably surprised most of his readers. Everybody knew that czarist Russia was a nation where serfs were tied to the land, but Russian serfdom, it turned out, wasn’t an ancient institution dating back to the depths of medieval history. It was, instead, introduced in the 16th and 17th centuries — after gunpowder finally gave peasant infantry the military upper hand over nomadic horse-archers, allowing the Russian Empire to expand into vast, fertile new territories.
As Domar pointed out, there’s little reason to enserf or enslave a worker (not quite the same thing, but let’s leave that aside) if labor is abundant and land is scarce, so that the amount that worker could earn if he ran away barely exceeds the cost of subsistence. But if land becomes abundant and labor scarce, the ruling class will want to pin workers in place so they can forcibly extract the difference between the value of what workers can produce — strictly speaking, their marginal product — and the cost of keeping them alive.
Hence the rise of serfdom as Russia expanded east and the rise of slavery as Europe colonized the New World.
In fact, the real historical puzzle is why high wages didn’t always lead to widespread slavery or serfdom. As Domar pointed out, serfdom in the West had more or less withered away by around 1300, because Western Europe was overpopulated, given the technologies of the time, which in turn meant that landowners didn’t need to worry that their tenants and workers would leave in search of lower rents or higher wages. But the Black Death caused populations to crash and wages to soar. In fact, for a while, real wages in Britain reached a level they wouldn’t regain until around 1870:
Credit…FRED
Yet serfdom wasn’t reimposed, for reasons that aren’t entirely clear. One thought, however, is that holding people captive in order to steal the fruits of their labor isn’t easy. (Escaped serfs were a significant issue in Russia, as were escaping and rebelling slaves in America — the Second Amendment was largely about making it easier to hold slaves down. A slave rebellion led in 1848 to emancipation on St. Croix, where President Biden spent his most recent vacation.) Which brings us to the story of the U.S. Civil War.
Labor was scarce in pre-Civil War America, so free workers earned high wages by European standards. Here are some estimates of real wages in several countries as a percentage of U.S. levels on the eve of the Civil War:
Credit…Williamson 1995
Notice that Australia — another land-abundant, labor-scarce nation — more or less matched America; elsewhere, workers earned much less.
Landowners, of course, didn’t want to pay high wages. In the early days of colonial settlement, many Europeans came as indentured servants — in effect, temporary serfs. But landowners quickly turned to African slaves, who offered two advantages to their exploiters: Because they looked different from white settlers, they found it hard to escape, and they received less sympathy from poor white workers who might otherwise have realized that they had many interests in common. Of course, white Southerners also saw slaves as property, not people, and so the value of slaves factored into the balance sheet of this greed-driven system.
So, again, the dynamic was one in which greedy slaveholders used and perpetuated racism to sustain their reign of exploitation and terror.
Because U.S. slavery was race-based, however, there was a limited supply of slaves, and it turned out that slaves made more for their masters in Southern agriculture than in other occupations or places. Black people in the North were sold down the river to Southern planters who were willing to pay more for them, so slavery became an institution peculiar to one part of the country.
As such, slaves became a hugely important financial asset to their owners. Estimates of the market value of slaves before the Civil War vary widely, but they were clearly worth much more than the land they cultivated and may well have accounted for a majority of Southern wealth. Inevitably, slaveholders became staunch defenders of the system underlying their wealth — ferocious and often violent defenders (remember bleeding Kansas), because nothing makes a man angrier than his own, probably unacknowledged suspicion that he’s actually in the wrong.
Indeed, slaveholders and their defenders lashed out at anyone who even suggested that slavery was a bad thing. As Abraham Lincoln said in his Cooper Union address, the slave interest in effect demanded that Northerners “cease to call slavery wrong, and join them in calling it right.”
But Northerners wouldn’t do that. There were relatively few Americans pushing for national abolition, but Northern states, one by one, abolished slavery in their own territories. This wasn’t as noble an act as it might have been if they had been confiscating slaveholders’ property, rather than in effect waiting until the slaves had been sold. Still, it’s to voters’ credit that they did find slavery repugnant.
And this posed a problem for the South. Anyone who believes or pretends to believe that the Civil War was about states’ rights should read Ulysses S. Grant’s memoirs, which point out that the truth was almost the opposite. In his conclusion, Grant noted that maintaining slavery was difficult when much of the nation consisted of free states, so the slave states in effect demanded control over free-state policies. “Northern marshals became slave catchers, and Northern courts had to contribute to the support and protection of the institution,” he wrote.
This should sound familiar. Since the Supreme Court overturned Roe v. Wade, states that have banned abortion have grown increasingly frantic over the ability of women to travel to states where abortion rights remain; it’s obvious that the right will eventually impose a national abortion ban if it can.
For a long time, the South did manage to exercise that kind of national control. But industrialization gradually shifted the balance of power within the United States away from the South to the North:
Credit…Statista
So did immigration, with very few immigrants moving to slave states.
And the war happened because the increasingly empowered people of the North, as Grant wrote, “were not willing to play the role of police for the South” in protecting slavery.
So yes, the Civil War was about slavery — an institution that existed solely to enrich some men by depriving others of their freedom. And there’s no excuse for anyone who pretends that there was anything noble or even defensible about the South’s cause: The Civil War was fought to defend an utterly vile institution.
Cosa riguardò la Guerra Civile,
di Paul Krugman
Ovviamente, la Guerra Civile riguardò la schiavitù. E tutti lo sapevano a quel tempo. Dunque no, Nikki Haley [1], essa non riguardò i diritti degli Stati, se non nella misura nella quale gli Stati del Sud stavano cercando di costringere quelli del Nord ad contribuire a conservare la schiavitù – qualcosa che, come spiegherò tra un momento, ha somiglianze con la attuale battaglia sui diritti all’aborto.
Dunque, la Haley merita tutte le condanne che ha ricevuto per avere, la scorsa settimana, in una interruzione della campagna elettorale [2], rifiutato di riconoscere ciò che è ovvio.
Ma, in questo caso, può valer la pena scavare un po’ più nel profondo del contesto. Anzitutto: perché esisteva la schiavitù? Perché era confinata soltanto in una parte degli Stati Uniti? E perché i possessori d schiavi furono disponibili ad avviare una guerra per difendere tale istituto, anche se l’abolizionismo era ancora un movimento abbastanza modesto ed essi non erano di fronte ad alcun rischio imminente di perdere i loro schiavi [3]?
Permettetemi di partire da un giudizio che potrebbe essere controverso: il sistema americano dello schiavismo non era motivato principalmente dal razzismo, ma dalla avidità. I possessori di schiavi erano razzisti, e utilizzavano il razzismo sia per giustificare il loro comportamento che per rendere la schiavizzazione milioni di persone più sostenibile, ma fu il denaro e l’avidità disumana a guidare il sistema razzista.
Nel passato 1970, l’economista del MIT Evsey Domar pubblicò un classico saggio dal titolo “Le cause della schiavitù e della servitù: una ipotesi”, che prendeva le mosse da una osservazione storica che probabilmente sorprese la maggior parte dei suoi lettori. Tutti sapevano che la Russia zarista era una nazione nella quale i servi erano legati alla terra, ma la servitù russa, si scopriva, non era una istituzione antica che risaliva alle profondità della storia medievale. Era stata piuttosto introdotta nel 16° e 17° secolo – quando la polvere da sparo diede alla fanteria dei contadini la carta vincente sugli arcieri a cavallo nomadi, permettendo all’Impero Russo di espandersi in vasti nuovi territori fertili.
Come Domar metteva in evidenza, ci sono poche ragioni per asservire o schiavizzare un lavoratore (non è proprio la stessa cosa, ma lasciamola da parte) se il lavoro è abbondante e la terra è scarsa, cosicché la somma che il lavoratore potrebbe guadagnare se fuggisse eccederebbe appena il costo della sussistenza. Ma se la terra diventa abbondante e il lavoro scarso, la classe dominante vorrà bloccare i lavoratori sul loro posto, in modo tale da poter forzatamente sfruttare la differenza tra il valore di quello che i lavoratori possono produrre – strettamente parlando, il loro valore marginale – e il costo di mantenerli in vita.
Da qua la crescita della servitù quando la Russia si espanse ad Oriente e la crescita della schiavitù quando l’Europa colonizzò il Nuovo Mondo.
Di fatto, il vero enigma storico è perché alti salari non hanno sempre portato ad una generalizzata schiavitù o servitù. Come Domar metteva in evidenza, la servitù in Occidente si era più o meno attenuata attorno al 1300, giacché l’Europa Occidentale era sovrapopolata, date le tecnologie del tempo, il che a sua volta comportava che i proprietari terrieri non avevano bisogno di preoccuparsi se i loro affittuari o braccianti se ne fossero andati in cerca di affitti più bassi o di salari più alti. Ma la Morte Nera spinse le popolazioni al crollo ed i salari ad impennarsi. Di fatto, per un certo periodo, i salari reali in Inghilterra raggiunsero un livello che non avrebbero riacquistato sino a circa il 1870:
Fonte: FRED [4]
Tuttavia, la servitù non venne di nuovo imposta, per ragioni che non sono interamente chiare. Una tesi, tuttavia, è che mentenere le persone in cattività allo scopo derubarle dei frutti del loro lavoro non è facile (i servi che fuggivano furono un tema significativo in Russia, come lo furono le fughe e le ribellioni degi schiavi in America – il Secondo Emendamento riguardava in gran parte il rendere più facile il tener fermi gli schiavi. Una ribellione degli schiavi portò nel 1848 alla loro emancipazione a St. Croix, dove il Presidente Biden ha trascorso le sue recenti vacanze). Il che ci riporta alla storia della Guerra Civile statunitense.
Il lavoro era scarso in America prima della Guerra Civile, cosicché i lavoratori liberi guadagnavano salari elevati per gli standard europei. Esistono alcune stime dei salari reali in vari paesi come percentuale dei livelli statunitensi alla viglia della Guerra Civile:
Fonte: Williamson 1995 [5]
Su noti che l’Australia – un’altra nazione abbondante di territorio e scarsa di lavoro – più o meno eguagliava l’America; altrove, i lavoratori guadagnavano molto meno.
Ovviamente, i proprietari terrieri non intendevano pagare alti salari. Nei primi giorni dell’insediamento coloniale, molti europei arrivavano come servitori a contratto – il sostanza, servi temporanei. Ma i proprietari terrieri presto si indirizzarono verso gli schiavi africani, che ai loro sfruttatori offrivano due vantaggi: dato che avevano sembianze diverse dai coloni bianchi, per loro era difficile fuggire e ricevevano scarsa simpatia dei lavoratori bianchi poveri, che altrimenti avrebbero potuto comprendere di avere molti interessi in comune. Naturalmente, i sudisti bianchi consideravano anche gli schiavi come proprietà, non come persone, e così il valore degli schiavi giocò una parte nel bilancio patrimoniale di questo sistema fondato sull’avidità.
Dunque, ancora un volta, la dinamica fu quella di avidi proprietari di schiavi che usavano e perpetuavano il razzismo per sorreggere il loro regno di sfruttamento e di terrore.
Poiché la schiavitù era basata sulla razza, tuttavia, ci fu un’offerta limitata di schiavi e si scoprì che gli schiavi rendevano di più per i loro padroni nell’agricoltura del Sud che in altre occupazioni o località. Le persone di colore del Nord venivano vendute lungo il fiume ai proprietari delle piantagioni del Sud che per loro erano diposte a pagare di più, cosicché la schiavitù divenne un’istituzione peculiare di una parte del paese.
Come tali, gli schiavi divennero un asset finanziario grandemente importante per i loro proprietari. Le stime sul valore di mercato degli schiavi variavano grandemente, ma avevano chiaramente molto più valore delle terra che coltivavano e potevano ben essere considerati come la parte prevalente della ricchezza del Sud. Inevitabilmente, i proprietari di schiavi divennero convinti difensori del sistema su quale si basava la ricchezza del Sud – difensori feroci e spesso violenti (si ricordi il sanguinario Kansas), poiché niente rende un uomo più infuriato del suo stesso sospetto, il più delle volte non ammesso, di essere effettivamente nel torto.
In effetti, i proprietari di schiavi e i loro sostenitori aggredivano chiunque persino suggerisse che la schiavitù era una cosa negativa. Come disse Abramo Lincoln nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione all’Istituto Cooper, l’interesse per gli schiavi in sostanza chiedeva ai nordisti “di smettere di chiamare la schiavitù come una cosa sbagliata, e di unirsi a loro nel definirla giusta”.
Ma i nordisti non l’avrebbero fatto. Ci furono relativamente pochi americani a spingere per la sua aboliziona nazionale, ma gli Stati nordisti, uno dopo l’altro, abolirono la schiavitù nei loro territori. Questo non fu un atto altrettanto nobile di quello che avrebbe potuto essere la confisca delle proprietà dei proprietari di schiavi, anziché in sostanza l’attendere finché gli schiavi non fossero stati venduti. Eppure, è un titolo di merito verso gli elettori che essi avessero trovato la schiavitù ripugnante.
E questo cosituiva un problema per il Sud. Chiunque creda o finga di credere che la Guerra Civile riguardò diritti degli Stati dovrebbe leggersi le memorie di Ulysses S. Grant, che evidenziano come la verità fosse quasi quella opposta. Nella sua conclusione, Grant osservava che mantenere la schiavitù era difficile quando la maggior parte della nazione consisteva di Stati liberi, cosicché gli Stati schiavisti in effetti chiedevano il controllo sulle politiche degli Stati liberi. Egli scriveva: “Gli sceriffi del Nord divennero cacciatori di schiavi fuggiaschi, e i tribunali del Nord dovettero contribuire al sostegno ed alla protezione dell’istituzione”.
Questo dovrebbe ricordarci qualcosa di familiare. Dal momento in cui la Corte Suprema ha rovesciato la sentenza Roe contro Wade [6], gli Stati che hanno messo al bando l’aborto sono diventati sempre più frenetici sulla possibilità che le donne viaggino verso Stati nei quali il diritto all’aborto permane; è evidente che alla fine, se potesse, la destra imporrebbe una messa al bando nazionale dell’aborto.
Per un lungo tempo il Sud cercò di esercitare quella sorta di controllo nazionale. Ma gradualmente l’industrializzazione spostò l’equilibrio del potere all’interno degl Stati Uniti dal Sud al Nord:
Fonte: Statista [7]
Lo stesso accadde per l’immigrazione, con molti pochi immigrati che si spostarono negli Stati schiavisti.
E la guerra avvenne perché la popolazione sempre più potente del Nord, come scriveva Grant: “non era disponibile a giocare il ruolo della polizia a favore del Sud” nella protezione della schiavitù.
Dunque è un fatto che la Guerra Civile riguardò la schiavitù – un istituzione che esisteva unicamente per arricchire alcuni uomino privando gli altri della loro libertà. E non c’è alcuna scusante per chiunque pretenda che ci fosse qualcosa di nobile o anche di difendibile nella causa del Sud: la Guerra Civile venne combattuta [dal Sud] per difendere un’istituzione del tutto abietta.
[1] Nimrata Randhawa, detta Nikki e coniugata Haley (Bamberg, 20 gennaio 1972), è una politica statunitense, membro del Partito Repubblicano e rappresentante permanente alle Nazioni Unite dal 27 gennaio 2017 al dicembre 2018; è stata governatrice della Carolina del Sud dal 2011 al 2017 e membro della Camera dei rappresentanti della Carolina del Sud dal 2005 al 2011.
Nel febbraio 2023 Haley ha annunciato la propria candidatura alle primarie del Partito Repubblicano del 2024 per la presidenza degli Stati Uniti nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2024.
Wikipedia.
[2] Il riferimento è alla parte iniziale della campagna elettorale, che attualmente impegna i repubblicani nelle primarie per la scelta di un loro candidato (primarie alle quali Trump in sostanza non partecipa, pur essendo considerato quasi
da tutti come il designato quasi certo).
[3] È interessante che la parola inglese “chattel” significhi sia “bene mobile “ – ovvero gioielli, automobili, mobili etc., ma non case o fabbriche – che anche “schiavo”. L’etimo di “chattel” è lo stesso di quello di “cattle” (“bestiame”) ed ha origine nel latino medioevale e nel francese antico. Peraltro ha la stessa radice di “capitale”; il termine “chattel slavery”, che designa il sistema schiavistico, non è semplicemente una ripetizione dello stesso concetto. Essa significa in sostanza che la schiavitù comporta il completo possesso di una persona su un’altra, alla stregua di un ‘capitale mobile’ . Una analogia, viene da pensare, marxista, che peraltro legittima ampiamente il termine “proletariato”, ad indicare la classe che poteva esercitare una forma di ‘possesso’ solo sulla propria prole.
[4] Il diagramma mostra l’evoluzione dei salari reali procapite in rapporto all’Indice dei Prezzi al Consumo, che crebbero dal 1300 e toccarono il livello più alto nel secolo tra il 1400 ed il 1500, livello che avrebbero raggiunto solo verso la fine del diciannovesimo secolo.
[5] Quindi, nel 1860, i salari reali erano attorno al 40-50% dei livelli americani in Francia e in Inghilterra, mentre erano un po’ superiori al 100% in Australia.
[6] Lo scorso venerdì 24 giugno la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato la storica sentenza Roe v. Wade, che stabiliva il diritto costituzionale all’aborto negli Stati Uniti dal 1973, riportando il paese indietro di oltre 50 anni.
[7] La tabella mostra la situazione nell’anno 1861 – ovvero agli inizi della Guerra Civile, che ebbe inizio il 12 aprile 1861 e terminò il 23 giugno del 1865 – in termini di migliaia di unità di fabbriche (in blu) e di lavoratori occupati nelle fabbriche (in nero). La grande maggioranza si collocava nel territori che continuarono a chiamarsi Stati Uniti (a sinistra del diagramma); gli Stati secessionisti, che presero il nome di Stati della Confederazione, e gli Stati di confine tra i due raggruppamenti (nel centro e a destra del diagramma) rappresentavano già nel 1861 una modesta minoranza.
Chi mette l’embargo a chi? Di Paul Krugman (dal blog di Krugman, 2 agosto 2022)
agosto 17, 2022
Aug. 2, 2022
Who’s Embargoing Whom?
By Paul Krugman
The other day, my CUNY and Stone Center colleague Branko Milanovic suggested that it would be interesting to “compare Napoleon’s continental blockade against Great Britain to the current sanctions against Russia.” As it happened, I was already on the topic. I had just read Andrew Roberts’s “Napoleon: A Life” and was thinking about the parallels.
The parallels are not, in fact, very good. But laying out the differences is itself, I believe, a useful exercise, and there are other historical examples of trade embargoes in times of war that come closer to what’s happening now.
So, for those not familiar with the history, a potted summary: At the beginning of the 19th century, Britain and France were locked in a peculiar stalemate — the British unbeatable at sea, France very nearly unbeatable on land. Napoleon tried to break this stalemate with economic warfare, closing the ports of Europe to British commerce. But his blockade was leaky, and his attempts to plug the leaks led him into disastrous military ventures — first a bloody quagmire in Spain, then a catastrophic invasion of Russia.
What does this have to do with the current situation? Not much. Let’s fast-forward to 2022.
The conventional wisdom on Feb. 24, I think, was that Russia would win a quick military victory in Ukraine, but then face a cash shortage as the West embargoed its exports. This has not come to pass.
On the military side, Russia’s attempt at a quick seizure of Ukraine’s major cities ended with huge losses and a humiliating retreat. Russia then shifted to a grinding, artillery-driven battle of attrition in the Donbas but gained only a few square miles of ground, again at the cost of heavy losses. That attack more or less stalled out in mid-June, and more recently Western weapons seem to have tipped the balance of power in Ukraine’s favor, although the front lines remain static, at least for now.
On the other hand, Western attempts to restrict Russian exports have been a bust. Russian oil is still finding its way to world markets, and if anything, the country appears to be flush with cash.
But while Russia is having no problem selling stuff, it’s having a lot of trouble buying stuff. Sanctions on Russia’s exports have, as I said, been a bust, but sanctions on its imports — refusal to sell Russia essential goods — have been more successful than, as far as I know, anyone expected. Even nations that aren’t part of the coalition imposing sanctions, including China, have sharply cut their exports to Russia:
The world won’t sell to Russia.Credit…Peterson Institute for International Economics
And this cutoff of imports appears to be hammering the Russian economy:
Russian industry is hurting.Credit…Sonnenfeld et al.
None of this would have made sense in the Napoleonic era, because international trade was much simpler then. Sanctions appear to be restricting Russian industry because so much modern trade consists not of consumer goods but of industrial inputs. That wasn’t true in, say, 1810, with the main exception being cotton — which didn’t come from areas Napoleon controlled.
Also, in 1810, there weren’t many multinational businesses. Today, a company that manufactures goods in China — even if it’s Chinese-owned — is probably reluctant to sell potentially strategic goods to Russia out of fear that it may find itself sanctioned in other, more important markets, like the United States and the European Union.
So economic sanctions against Russia appear to have been surprisingly effective, just not in the way everyone expected. That said, there are no indications I’m aware of that the economic cost of the sanctions is leading to any moderation in Russian policy. What they’re doing instead is crimping Russia’s military production, which is a real problem for Putin, given the continuing inflow of Western weapons into Ukraine.
But wait, that’s not the end of the story, because there’s another de facto embargo underway. Early in the war, supporters of Ukraine pleaded with European nations — Germany in particular — to stop buying Russian natural gas; they didn’t. But now Russia is, in effect, sanctioning its own gas exports. It’s not an explicitly announced policy, but Russia has been reducing deliveries to European markets, pretty clearly in an attempt to damage the European economy and increase political pressure for Europe to stop supporting Ukraine.
I find this chart, which shows the price of natural gas in the Netherlands — the European benchmark — fascinating:
Military frustration leads to a gas squeeze? Credit…ICE
Gas prices spiked in February with the Russian invasion, but quickly subsided to more or less the pre-invasion level. They didn’t begin a sustained rise until mid-June. I don’t think it’s a coincidence that this upward break corresponds with the point when even the Russians realized that their Donbas offensive wasn’t going to produce a decisive breakthrough.
Everything suggests that this was when Russia began limiting gas deliveries. In effect, Russia, not the West, is now the player trying to use economic warfare as a substitute for its inability to prevail on the battlefield.
The closest historical parallel I can find is the embargo on cotton exports imposed by the Confederacy early in the Civil War, in an attempt to force Britain to intervene on the side of the South. This embargo didn’t last long, but by the time it was repealed, it was moot: The Union navy was blockading Southern ports anyway. Needless to say, the embargo didn’t work.
Will Russia’s ploy work better? I wish I could be more sure than I am about European resolve, especially given high inflation and the high risk of recession (which is higher there than it is in the United States). On the other hand, the nations that seem most likely to waver, especially Germany and Italy, have been lagging in their arms deliveries anyway; Russia’s stealth gas embargo is unlikely to deter crucial shipments from the United States, Britain and Poland, among others.
The truth is that it is hard to find historical examples of successful economic warfare unless you count blockades that were themselves a form of military action — like the U.S. submarine campaign that devastated Japan’s economy during World War II. In the end, the war in Ukraine will probably be decided on the battlefield.
Chi mette l’embargo a chi?
Di Paul Krugman
L’altro giorno, il mio collega al CUNY ed allo Stone Center Branko Milanovic ha suggerito che sarebbe interessante “confrontare il blocco continentale contro la Gran Bretagna di Napoleone alle attuali sanzioni contro la Russia”. Si dà il caso, che mi occupassi già dell’argomento. Ho appena letto “Napoleone: una vita” di Andrew Roberts e stavo pensando a quel confronto.
Di fatto, le affinità non sono particolarmente rilevanti. Ma credo che esporre le differenze sia di per sé un esercizio utile, e ci sono altri esempi storici di embarghi in tempi di guerra che si avvicinano a quanto sta accadendo oggi.
Dunque, per coloro che non hanno familiarità con la storia, una riassunto sommario: agli inizi del diciannovesimo secolo l’Inghilterra e la Francia erano bloccate in un singolare punto morto – gli inglesi imbattibili sul mare, la Francia quasi imbattibile sulla terra. Napoleone cercò di forzare questo punto morto con una guerra economica, chiudendo i porti dell’Europa al commercio inglese. Ma questo blocco aveva delle perdite, e i suoi tentativi di tappare le perdite lo portarono a disastrose avventure militari – dapprima un sanguinoso pantano in Spagna, poi una invasione catastrofica della Russia.
Cosa ha a che fare tutto questo con la situazione attuale? Non molto. Arriviamo al 2022.
Penso che, il 24 febbraio, il senso comune dicesse che la Russia avrebbe ottenuto una rapida vittoria militare in Ucraina, ma poi si sarebbe misurata con una scarsità di contante quando l’Occidente avesse messo l’embargo sulle sue esportazioni. Non è quello che è accaduto.
Sul versante militare, il tentativo della Russia di una rapida conquista di importanti città dell’Ucraina si è conclusa con vaste perdite e con una umiliante ritirata. Allora la Russia si è spostata su una estenuante battaglia di logoramento, guidata dall’artiglieria, nel Donbass, ma ha guadagnato soltanto poche miglia quadrate di terreno, ancora al costo di pesanti perdite. Alla metà di giugno quell’attacco è più o meno ristagnato, e più di recente le armi occidentali sembrano aver leggermente spostato l’equilibrio delle forze a favore dell’Ucraina, sebbene le linee del fronte restino statiche, almeno per adesso.
D’altra parte, i tentativi occidentali di restringere le esportazioni russe sono stati un fallimento. Il petrolio russo ha ancora la strada aperta sui mercati mondiali, e il paese appare semmai inondato di contante.
Ma mentre la Russia non sta avendo alcun problema a vendere i suoi prodotti, sta avendo un mare di guai nel comprarli. Le sanzioni sulle esportazioni della Russia, come ho detto, sono state un fallimento, ma le sanzioni sulle sue importazioni – il rifiuto di vendere alla Russia beni essenziali – hanno avuto maggiore successo, per quanto ne so, di quanto tutti si aspettavano. Persino le nazioni che non fanno parte della coalizione che impone sanzioni, compresa la Cina, hanno bruscamente tagliato le proprie esportazioni alla Russia:
Il mondo non vuole vendere alla Russia. Fonte: Peterson Institute for International Economics
E questo taglio delle importazioni sembra stia colpendo l’economia russa:
L’industria russa sta soffrendo. Fonte: Sonnenfeld e altri. [1]
Niente di questo avrebbe avuto senso nell’epoca napoleonica, perché allora il commercio internazionale era molto più semplice. Le sanzioni sembra che stiano restringendo l’industria russa perché buona parte del commercio moderno consiste non di ben di consumo, ma di materiali industriali. Questo non era vero, ad esempio, nel 1810, con la principale eccezione del cotone – che non proveniva da aree sotto il controllo di Napoleone.
Inoltre, nel 1810 non c’erano molte imprese multinazionali. Oggi, una società che produce beni in Cina – persino se è di proprietà dello Stato cinese – è probabilmente riluttante a vendere beni strategici alla Russia nel timore di ritrovarsi sanzionata in altri, più importanti, mercati come gli Stati Uniti e l’Unione Europea.
Dunque, le sanzioni economiche contro la Russia sembra siano state sorprendentemente efficaci, solo non nel senso che tutti si aspettavano. Ciò detto, non c’è alcuna indicazione di cui sia a conoscenza che il costo economico delle sanzioni stia portando a qualche moderazione nella politica russa. Quello che invece stanno provocando è mettere in difficoltà la produzione militare russa, il che costituisce un problema reale per Putin, dato il flusso continuo di armi occidentali all’Ucraina.
Ma aspettate, la storia non è tutta qua, perché c’è un altro embargo di fatto in corso. Agli inizi della guerra, i sostenitori dell’Ucraina imploravano le nazioni europee – la Germania in particolare – di cessare di acquistare il gas naturale russo; esse non l’hanno fatto. Ma adesso la Russia sta, in effetti, sanzionando le sue stesse esportazioni di gas. Non si tratta di una politica esplicitamente dichiarata, ma la Russia sta riducendo le forniture ai mercati europei, nel tentativo abbastanza chiaro di danneggiare l’economia europea e di accrescere la pressione politica sull’Europa perché cessi di sostenere l’Ucraina.
Trovo interessante questa tabella, che mostra il prezzo del gas naturale in Olanda – il punto di riferimento europeo:
La frustrazione militare porta ad una stretta sul gas? Fonte: ICE
I prezzi del gas si sono impennati a febbraio con l’invasione russa, ma rapidamente sono calati più o meno ai livelli precedenti l’invasione. Fino alla metà di giugno, non hanno iniziato una crescita sostenuta. Non penso sia una coincidenza che la svolta verso l’alto corrisponda al momento in cui persino i russi hanno compreso che la loro offensiva nel Donbass non era destinata a produrre una svolta decisiva.
Tutto indica che questo è accaduto quando la Russia ha iniziato a ridurre le forniture di gas. In effetti, adesso è la Russia, non l’Occidente, il soggetto che cerca di utilizzare la guerra economica come un sostituto della sua incapacità a prevalere sul campo di battaglia.
Il parallelo storico più vicino che posso trovare è l’embargo sulle esportazioni di cotone imposta dalla Confederazione agli inizi della Guerra Civile, nel tentativo di costringere l’Inghilterra a intervenire dalla parte del Sud. Questo embargo non durò a lungo, ma quanto al momento in cui venne ritirato, esso è opinabile: la marina dell’Unione bloccava in ogni caso i porti sudisti. Non è il caso di dire che l’embargo non funzionò.
La manovra della Russia funzionerà meglio? Vorrei essere più sicuro di quanto lo sono sulla determinazione europea, in particolare considerata l’elevata inflazione e l’alto rischio di recessione (più alto in Europa di quanto non lo sia negli Stati Uniti). D’altra parte le nazioni che sembra siano più probabilmente esitanti, in particolare la Germania e l’Italia, sono in ritardo in ogni caso nella consegna di armi; l’embargo nascosto di gas della Russia è improbabile scoraggi spedizioni cruciali, tra gli altri, dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra e dalla Polonia.
La verità è che è difficile trovare esempi storici di guerre economiche di successo se non si considerano i blocchi che erano essi stessi una forma di azione militare – come la campagna statunitense dei sottomarini che devastò l’economia giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Alla fine, la guerra in Ucraina sarà probabilmente decisa sul campo di battaglia.
[1] La tabella mostra i dati dettagliati della produzione industriale russa in vari sotto settori. I decrementi indicano cali della produzione che vanno da meno del 10% in settori come le materie plastiche, il carbone e l’antracite, il ferro, la frutta ed i vegetali sino al 30-50% nei prodotti tessili, dell’acciaio, della porcellana e della ceramica, delle tinte, delle locomotive ferroviarie, degli elettrodomestici.
Qual è il problema dell’Italia? Di Paul Krugman (dal blog di Krugman, 22 luglio 2022)
luglio 24, 2022
July 22, 2022
What’s the Matter With Italy?
By Paul Krugman
As president of the European Central Bank, Mario Draghi saved the euro. In my estimation, this makes him history’s greatest central banker, outranking even the former Fed chairs Paul Volcker, who brought inflation under control, and Ben Bernanke, who helped avert a second Great Depression.
In a way, then, it wasn’t surprising that last year Draghi was brought in to lead Italy’s new coalition government — often labeled “technocratic,” but actually more a government of national unity created to deal with the aftermath of the Covid-19 pandemic. In a properly functioning democracy, nobody should be indispensable, but Draghi arguably was, as the only person with the prestige to hold things together.
But even he couldn’t pull it off. Facing what amounted to sabotage by his coalition partners, Draghi simply resigned, creating fears that the coming election will put antidemocratic right-wing populists in power.
I have no idea what will happen. Italy, like any nation, is unique in many ways, but not in some of the ways many people imagine. No, it isn’t fiscally irresponsible. No, it’s not incapable of running its internal affairs. And the threat of a takeover by the authoritarian right is hardly special to Italy; if you aren’t terrified by that prospect here in America, you haven’t been paying attention.
True, Italy does have a problem with economic stagnation. Even before the pandemic struck, Italy was noteworthy in having experienced two decades without growth in real gross domestic product per capita:
Italy’s long stagnation.Credit…Our World in Data
That stagnation is important, and also a major economic puzzle. But it doesn’t seem central to current events.
In other ways, Italy seems surprisingly functional given its reputation. Notably, it did a far better job than the United States in getting its population vaccinated:
Italians have taken their shots.Credit…Our World in Data
And while Americans on average have higher incomes than Italians, we’re also far more likely to die younger:
They may not be prospering, but they’re living longer.Credit…O.E.C.D.
What about Italy’s reputation for fiscal irresponsibility? There was a time when that notoriety was justified, and past imprudence left Italy with relatively high debt (although not relative to some other European nations, Japan, or Britain for much of the 20th century.) But in recent years, Italy has been quite disciplined in its spending. Consider the primary fiscal balance — tax receipts minus government outlays other than interest payments:
Fiscally disciplined Italy? Credit…International Monetary Fund
Until the pandemic struck, Italy actually ran consistent primary surpluses, a bit bigger than the rest of Europe as a share of G.D.P., and in sharp contrast to U.S. deficits.
In 2010-2012 Italy, along with other southern European nations, experienced a debt crisis, with “lo spread” — the difference between Italian and German interest rates — exploding. But as a handful of analysts, above all Belgium’s Paul De Grauwe, pointed out, this crisis seemed driven less by fundamental insolvency than by self-fulfilling panic. In effect, investors engaged in a run on the debts of southern European nations, creating a cash shortage that these countries, which didn’t have their own currencies and hence couldn’t print more money, were unable to resolve.
That’s where Draghi came in. In July 2012, as E.C.B. chair, he said three words — “whatever it takes” — that were taken as a promise that the bank would supply cash as needed to countries in crisis. And the mere promise was enough. Spreads plunged, and the crisis went away:
Can Europe pull off another Draghi? Credit…FRED
Now, however, the spread is back. Not at 2012 levels so far: as of this morning 10-year Italian bonds were yielding “only” 2.3 percentage points more than German. But this time Italy’s crisis may well prove more intractable than the euro crisis of the early 2010s.
Why? It’s true that the E.C.B. is, in effect, trying once again to pull a Draghi: It has introduced a new bond purchase scheme that is supposed to prevent the kind of market fragmentation that almost killed the euro a decade ago. But while Christine Lagarde, the current E.C.B. president, is smart and impressive, it’s unclear whether one can pull a Draghi without Draghi himself.
More important, what’s happening now seems more specifically Italian and less a matter of self-fulfilling panic than the last crisis. Spreads on Spanish and Portuguese debt, which generally tracked Italy last time, are up to some extent, but much less than Italy’s. That may be because the driving factor now isn’t so much simple financial risk as political anxiety.
As you can see from the chart above, this is actually the second time since the great Draghi rescue that Italian bond yields took off. It also happened in the late 2010s when a right-wing populist coalition took power. And this seems all too likely to happen again, except that this time the right-wing coalition will likely be even uglier.
In any case, yield spreads aren’t the important story here, although they’re not irrelevant either. The bigger picture is that at a time when Europe is already under severe stress — trying to respond to Russian aggression in Ukraine, trying to cope with a huge surge in inflation brought on in part by the foolish decision to rely heavily on Russian natural gas — one of the continent’s major nations seems about to go off the deep end. This is not what we need.
On the other hand, how different is Italy from the rest of us? The Italian crisis has very little to do with fiscal profligacy or general incompetence; as I said, it’s all about the rise of antidemocratic forces, which is happening all across the West.
Italy’s political fragmentation — and the apparent inability of the center-left to get its act together despite the clear and present danger from the right — may bring authoritarian parties to power sooner than elsewhere. But maybe not all that much sooner: It’s not at all that hard to see how American democracy could effectively collapse by 2025.
I agree with David Broder: Italy may well represent the West’s future. And it’s bleak.
Qual è il problema dell’Italia?
Di Paul Krugman
Come Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi salvò l’euro. Nel mio giudizio, questo lo rende il più grande banchiere centrale della storia, collocandosi persino prima dei passati Presidenti della Fed Paul Volcker, che rimise sotto controllo l’inflazione, e Ben Bernanke, che contribuì ad evitare una seconda Grande Depressione.
In un certo senso, dunque, non fu sorprendente che l’anno passato Draghi sia stato portato alla guida della nuova coalizione di governo dell’Italia – spesso etichettata come “tecnocratica”, ma in effetti più un Governo di unità nazionale creato per misurarsi con le conseguenze della pandemia del Covid-19. In una democrazia che funziona in modo appropriato, nessuno dovrebbe essere indispensabile, ma Draghi probabilmente lo era, in quanto unica persona con il prestigio per tenere le cose insieme.
Ma anche lui non è riuscito a farcela. Di fronte a quello che ha corrisposto ad un sabotaggio dei partner della sua coalizione, semplicemente Draghi si è dimesso, alimentando i timori che le prossime elezioni portino al potere i populisti della destra antidemocratica.
Io non ho idea di cosa accadrà. L’Italia, come ogni nazione, è unica in molti sensi, ma non in alcuni di quelli che immaginano molti. No, non è irresponsabile nella spesa pubblica. No, non è incapace di gestire i suoi affari interni. E la minaccia di una presa del potere da parte della destra autoritaria non è certo particolare nel caso dell’Italia; se non siete terrorizzati da quella prospettiva qua in America, vuol dire che siete disattenti.
È vero, l’Italia ha un problema con la stagnazione economica. Anche prima che colpisse la pandemia, l’Italia era sotto attenzione per aver conosciuto due decenni senza crescita nel prodotto lordo interno procapite:
La lunga stagnazione dell’Italia. Fonte: Il nostro mondo in dati
Quella stagnazione è importante, ed è anche un rilevante mistero economico. Ma negli eventi attuali non sembra fondamentale.
Sotto altri punti di vista, considerata la sua reputazione, l’Italia sembra sorprendentemente efficiente. In particolare, essa ha fatto un lavoro migliore degli Stati Uniti nel vaccinare la sua popolazione:
Gli italiani hanno avuto le loro iniezioni. Fonte: Il nostro mondo in dati
E se gli americani hanno in media redditi più alti degli italiani, da noi è anche assai più probabile morire più giovani:
Può darsi che non siano prosperi, ma vivono più a lungo. Fonte: OCSE
Che dire della reputazione dell’Italia di irresponsabilità nella finanza pubblica? Un tempo quella notorietà era giustificata, e l’imprudenza passata ha lasciato l’Italia con un debito relativamente elevato (sebbene non in rapporto ad altre nazioni europee, al Giappone o all’Inghilterra per buona parte del ventesimo secolo). Ma negli anni recenti, l’Italia è stata abbastanza disciplinata nella sua spesa. Si consideri l’equilibrio fiscale primario – le entrate fiscali meno le spese del Governo escluso il pagamento degli interessi:
Italia disciplinata nella finanza pubblica? Fonte: Fondo Monetario Internazionale
Fino al colpo della pandemia, in effetti l’Italia ha gestito stabili avanzi primari, come quota del PIL un po’ superiori al resto dell’Europa e in netto contrasto con i deficit statunitensi.
Nel 2010-2012 l’Italia, assieme ad altre nazioni meridionali dell’Europa, conobbe una crisi del debito, con lo spread – la differenza tra i tassi di interesse italiani e tedeschi – che esplose. Ma come una manciata di economisti, soprattutto il belga Paul De Grauwe, misero in evidenza, questa crisi sembrava guidata meno da una insolvenza di fondo che da un panico che si auto avverava. In effetti, gli investitori si impegnarono in un assalto ai debiti delle nazioni del sud dell’Europa, creando una scarsità di cassa che questi paesi, che non avevano valute proprie e di conseguenza non potevano stampare moneta, erano incapaci di risolvere.
È lì che intervenne Draghi. Nel luglio del 2012, come Presidente della BCE, egli disse tre parole – “whatever it takes” – che furono prese come una promessa che la Banca avrebbe offerto il contante necessario ai paesi in crisi. E fu sufficiente la semplice promessa. Gli spread crollarono, e la crisi se ne andò:
Può l’Europa tirar fuori un altro Draghi? Fonte: FRED
Adesso, tuttavia, lo spread è tornato. Sinora non ai livelli del 2012: questa mattina i rendimenti dei bond decennali italiani erano “soltanto” 2,3 punti percentuali più dei tedeschi. Ma può darsi che questa volta la crisi dell’Italia si dimostri più intrattabile della crisi dell’euro degli inizi del primo decennio del 2000.
Perché? È vero che, in sostanza, la BCE sta ancora una volta tentando di tirar fuori un Draghi: essa ha introdotto un nuovo programma di acquisti di bond che si suppone impedisca il tipo di frammentazione che quasi liquidò l’euro una decennio orsono. Ma se Christine Lagarde, l’attuale Presidente della BCE, è intelligente e ammirevole, non è chiaro se essa possa realizzare quello che fece Draghi senza Draghi stesso.
Ancora più importante, ciò che sta accadendo adesso appare più specificamente italiano, nonché meno una faccenda di panico che si autoavvera come la crisi passata. Gli spread sul debito spagnolo e portoghese, che in generale seguirono l’Italia l’ultima volta, in qualche misura sono cresciuti, ma molto meno dell’Italia. Questo può dipendere dal fatto che il fattore scatenante adesso non è tanto un semplice rischio finanziario, ma un fattore di ansietà politica.
Come potete notare dalla tabella sopra, questa è effettivamente la seconda volta dal grande salvataggio di Draghi che i rendimenti delle obbligazioni italiane prendono il volo. Accadde anche sulla fine del primo decennio del 2000, quando andò al potere una coalizione populista di destra. E questo sembra anche troppo probabile che accada nuovamente, sennonché questa volta la coalizione di destra sarà probabilmente anche più sgradevole.
In ogni caso, in questo momento gli spread dei rendimenti non sono il punto decisivo, sebbene non siano neppure irrilevanti. Il quadro più generale è che in un epoca nella quale l’Europa è già in grave tensione – cercando di rispondere alla aggressione russa in Ucraina, cercando di misurarsi con un’ampia impennata dell’inflazione provocata in parte dalla insensata decisione di affidarsi pesantemente al gas naturale russo – una delle nazioni principali del continente sembra in procinto di cadere in basso. Non è quello di cui c’è bisogno.
D’altra parte, quanto è diversa l’Italia dal resto di noi? La crisi italiana ha molto poco a che fare con lo sperpero della finanza pubblica o con una complessiva incompetenza; come ho detto, riguarda per intero la crescita di forze antidemocratiche, che sta avvenendo in tutto l’Occidente.
La frammentazione politica dell’Italia – e l’apparente incapacità del centrosinistra di agire unitariamente nonostante il pericolo della destra chiaro e attuale – può portare i partiti autoritari al potere prima che altrove. Ma forse non poi tanto prima: non è così difficile constatare che le democrazia americana potrebbe effettivamente collassare nel 2025.
Sono d’accordo con David Broder: l’Italia potrebbe ben rappresentare il futuro dell’Occidente. Che è cupo.
Pagina successiva »



















































